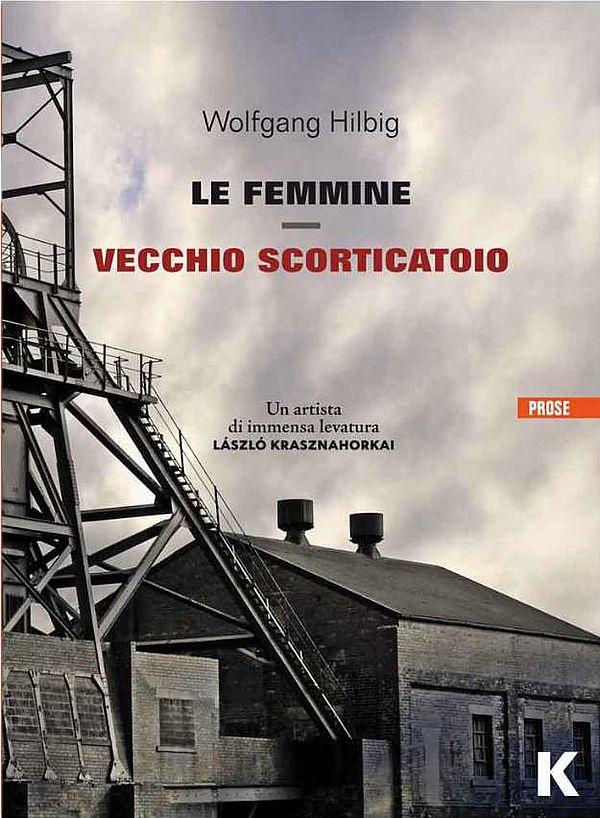Considerato uno dei maggiori autori tedeschi del Novecento, soprannominato l’Hölderlin della Sassonia per la sua poetica, paragonato a Kleist per la precisione e la bellezza lessicale, considerato l’erede di E.T.A. Hoffmann per le atmosfere romantiche e decadenti dei suoi testi, Wolfgang Hilbig è stato insignito dei più prestigiosi premi letterari, uno per tutti il George Büchner Preis nel 2002.
Eppure, nel panorama italiano della letteratura tradotta, era un grande assente. Per questo la scelta dell’editore Keller di dare alle stampe due delle sue opere più importanti è da considerarsi particolarmente lodevole e coraggiosa. Le femmine e Vecchio scorticatoio, raccolti in un unico volume, sono due racconti tradotti rispettivamente da Riccardo Cravero e Roberta Gado. Da molti anni di casa a Lipsia, traduttrice e mediatrice culturale, Roberta Gado ha già fatto conoscere al pubblico italofono un altro autore dell’editore S. Fischer e della terra di Hilbig, nonché suo grande estimatore, Clemens Meyer: «era una grande lacuna che siamo contenti di avere colmato. Tradurre Hilbig mette a dura prova ma regala anche grande soddisfazione per la sua straordinaria sensibilità e genialità linguistica».
Ci sono scrittori che leggiamo per nostro gusto e ci sono scrittori che non possiamo fare a meno di leggere. Wolfgang Hilbig appartiene alla seconda schiera e non si può leggerlo, a mio avviso, senza conoscerne la vita perché si rischierebbe di non comprenderne la grandezza o di non cogliere l’essenza che abita le sue opere, la pulsione che le sottende, le ossessioni e le oscure vertigini che guidano la sua penna. Nato nel 1941 a Meuselwitz, un piccolo paesino della Turingia a 40 Km da Lipsia, Hilbig avrebbe potuto rimanere per tutta la vita un semplice fuochista, di quelli che nei giorni gelidi della DDR aveva l’obbligo di spalare fino a 32 tonnellate di carbone. Invece, benché nato e cresciuto in un milieu avverso, è diventato ciò che sentiva di essere: uno scrittore.
Cresciuto senza padre, morto nel 1942 a Stalingrado, con un nonno analfabeta che capiva meglio il russo e il polacco del tedesco e andava ripetendo «non importa sotto quale governo, noi della classe operaia saremo sempre gli stupidi di turno», una mamma, iscritta nelle file della SED, che derideva le sue velleità letterarie e lo credeva un buono a nulla, ancora oggi ci si chiede dove e come Wolfgang Hilbig abbia trovato le conoscenze e il talento per coniare una propria lingua. Una lingua elaborata, originalissima, onirica, traboccante di sinestesie e di aggettivi capaci di tradurre in parole il suo immaginario, il suo flusso interiore e il suo vissuto. Quella stessa lingua altamente poetica che il critico letterario Marcel-Reich Ranicki definiva pericolosa perché rischiava di annebbiare la realtà storica.
Hilbig era fissato con la forma, «per me essere scrittore significa scrivere in modo artificioso», disse in un’intervista al giornalista Günter Gaus nel 2003. Dopo anni di scrittura avvolto nell’oscurità amica, nel 1979 per l’editore Fischer pubblica nella Repubblica Federale tedesca una raccolta di poesie dal titolo Abwesenheit («Assenza») che gli costerà alcune settimane di prigione per illecito valutario. Hilbig verrà scoperto dal grande pubblico e dalla critica prima con i suoi racconti in prosa Die Weiber (Le femmine) e Alte Abdeckerei (Vecchio scorticatoio) usciti nel 1987 e nel 1991, poi con i romanzi Ich (1993) e Das Provisorium (2000). In quest’ultimo è lui stesso a rivelarci cosa rende peculiare la sua penna: «per poter scrivere le mie opere ho sacrificato la mia biografia, la mia persona. Ho avuto molto presto l’impressione che la mia vita fosse scandita in singole scene di modo che potessi osservarla da tutti i punti di vista».
Si è sempre chiesto chi fosse suo padre, si è confrontato con le sue origini, ha descritto la landa industriale e povera in cui è cresciuto pur sottolineando di non avere mai sentito l’appartenenza a una Heimat, una patria: «sono cresciuto in una topaia fatta di sola industria, dove certe emozioni non si potevano sviluppare». Nato durante la Seconda guerra mondiale, cresciuto sotto la DDR e il socialismo nelle vicinanze di un lager distaccato del campo di concentramento di Buchenwald, nei suoi testi Hilbig critica il sistema liberticida della DDR, condanna le logiche e i crimini nazisti. Il centro delle sue riflessioni rimane però l’individuo con la sua solitudine, i suoi precipizi interiori, la sua disperazione, le sue pulsioni segrete. Il suo biografo Michael Opitz lo ha definito «un’eccezione del panorama letterario» perché Hilbig non scriveva come gli altri, scrivere era per lui un atto liberatorio, una lotta permanente contro le sue ossessioni.
Hilbig scrive Le femmine nella Germania dell’ovest, dove si trasferisce nel 1985 grazie a un permesso di espatrio temporaneo. L’opera, densa di elementi autobiografici, rappresenta il suo trampolino di lancio. Ci sono le baracche abbandonate nelle quali usava giocare da bambino, distaccamenti del campo di concentramento di Buchenwald. Vicino si trova una fabbrica di munizioni dove scopre delle detenute che in modo denigratorio vengono chiamate femmine («Weiber»), ma femmine sono anche le lavoratrici della fabbrica che il quarantenne Signor C. spia dalla grata dello scantinato in cui viene relegato, donne sudate e corpulente che nutrono le sue fantasie sessuali.
Un giorno il Signor C. viene licenziato e poi chiamato dall’Ufficio d’Indirizzamento al Lavoro. Vogliono conoscere il motivo per cui da tempo non ha un lavoro regolare. Lui balbetta che sente un’inclinazione per la scrittura «cosa vorrà mai scrivere? Non ha nemmeno fatto la maturità. Noi le abbiamo dato la possibilità di imparare un mestiere decente... La sua gratitudine nei confronti dello Stato e della società lascia assai a desiderare…» e gli propongono un posto nel dipartimento della nettezza urbana «Deve assolutamente presentarsi là al più presto…». Il Signor C. annuisce ma la severa signora lo avverte «io la registro, così la teniamo d’occhio e verifichiamo che non rimanga sulla cattiva strada». Ecco la presenza asfissiante dello Stato, il potere che lo tiene d’occhio, pronto a punirlo se non riga dritto perché chi non lavora e non pensa al futuro crea delle sgradevoli ripercussioni sociali.
Se Le femmine gli apre la strada, Vecchio scorticatoio viene consacrato a testo centrale della sua poetica. Nell’incipit il narratore interno ricorda quando nell’autunno del 1989 era a passeggio nella terra desolata alla periferia della sua cittadina d’origine: «Mi sono ricordato un ruscello fuori città, un corso d’acqua di un’iridescenza strana, in certi giorni quasi latteo, che avevo seguito per chilometri un autunno intero o persino più a lungo, forse solo per evadere da un territorio che, ad ammetterlo una volta per tutte, era racchiuso nei confini della mia stanchezza». Al centro di questo territorio c’è il vecchio scorticatoio, un edificio nel quale si cuociono carcasse di animali per trasformarle in sapone. Si chiama Germania II ed è un chiaro riferimento al passato nazionalsocialista: ciò che conduce nelle profondità buie della terra porta il nome che Hitler voleva dare alla capitale mondiale del suo impero. I lavoratori del vecchio scorticatoio, il loro modo di maneggiare le carcasse, simboleggiano il rapporto del popolo tedesco con gli orrori commessi. Nella poetica di Hilbig divengono dunque centrali il tema della rimozione del passato e della memoria collettiva, con particolari riferimenti ad Auschwitz.
Dicevo che per comprendere i suoi testi è necessario conoscere la sua vita. Per apprezzarli, invece, basta soffermarsi sulle immagini che sostanziano i suoi racconti affrescate con quella sua schizofrenica prosa poetica: «E via infine lungo rovine sommerse, lungo Germania II, dove tra i flutti giocano costellazioni di stelle, dove pascolano i minotauri».
Come dice Roberta Gado «una delle sue grandi capacità è creare questi enormi scenari metaforici che però, come fa la poesia, non sciolgono la metafora, per cui ci sono i capelli, il marciume, gli animali scuoiati ma non c’è mai un punto in cui l’autore ti dice: questa è la metafora della DDR, del socialismo o del nazismo. Per questo i suoi testi risultano criptici e stranianti».
Leggere Hilbig non è una passeggiata, la sua vita non lo è stata, ma proprio per questo le sue vertigini toccano profondità al contempo straordinarie e mostruose. Era figlio della sua epoca, ultimo tra gli ultimi, e il successo letterario non è bastato a liberarlo dai suoi fantasmi e dalle sue ossessioni.
Dopo la Riunificazione vive a Berlino con la moglie Natascha Wodin. Muore alcolizzato a sessantasei anni.