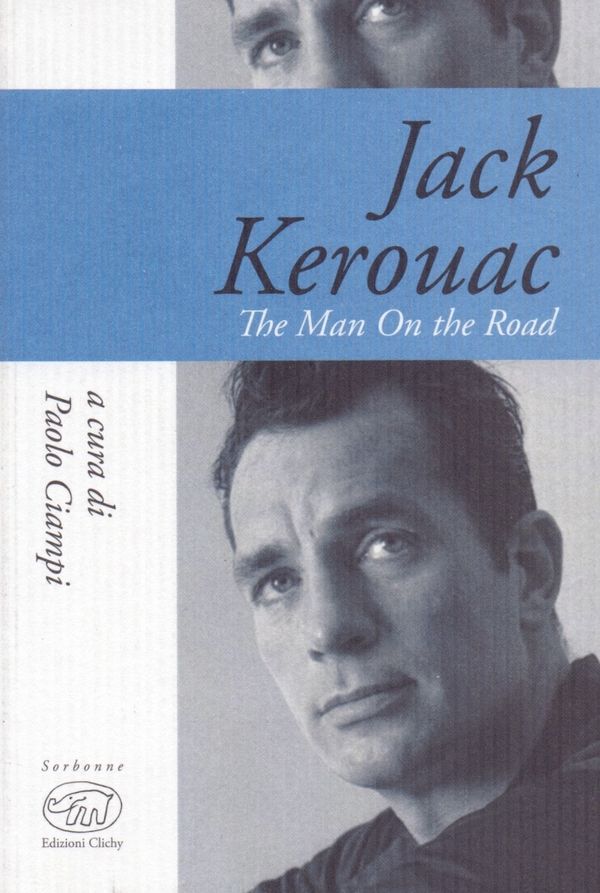«Un’estate senza fine» (Endless Summer). Così negli anni Cinquanta del Novecento i surfisti descrivevano la loro vita ideale: lunghi viaggi intorno al mondo puntando sempre verso oriente, rincorrendo il sole e l’onda perfetta. Quel sogno però potrebbe presto diventare un incubo a causa del cambiamento climatico. L’estate 2018 è stata davvero infinita, ma nel senso peggiore del termine. Infatti è stata una delle più calde di sempre (0,77 gradi in più rispetto alla media del ventesimo secolo), in buona compagnia di quasi tutti gli ultimi anni.
Già prima dell’estate si sono accumulati segni inquietanti. Una recente ricerca dell’Università di Ginevra, basata su immagini satellitari, ha mostrato quanto si stia riducendo la neve nel nostro Paese: in poco più di un decennio oltre tremila chilometri quadrati di manto nevoso si sono sciolti, un quinto del totale. Tra le conseguenze – e forse non è neppure la più importante – il turismo degli sport invernali potrebbe scomparire proprio nel Paese dove fu inventato.
È un mondo sottosopra. Quest’anno le temperature invernali nell’Artico sono state le più alte mai registrate: in due giorni di febbraio ha fatto più caldo al Polo nord che a Zurigo… Al tempo stesso secondo «Nature», una delle più autorevoli riviste scientifiche del mondo, la corrente del Golfo sta rallentando; la sua velocità è la più bassa degli ultimi milleseicento anni e questo riduce il suo effetto nel mitigare la rigidità del clima nordeuropeo.
Potrebbe andare peggio? Sì. Il riscaldamento globale potrebbe non essere un processo graduale e ordinato; varcata una soglia critica (che non conosciamo) il cambiamento potrebbe accelerare e diventare improvviso e radicale. La storia della Terra del resto è costellata di epoche dal clima estremo, con conseguenti estinzioni di massa.
Fermiamoci qui per adesso. Del resto, anche se spesso preferiamo voltare la faccia dall’altra parte, la situazione è ben conosciuta, soprattutto a chi viaggia spesso. David Goodrich ha studiato il clima per tutta la vita alla National Oceanic and Atmospheric Administration americana. Dopo la pensione è partito per un viaggio in bicicletta attraverso gli Stati Uniti per rendersi conto sul campo del cambiamento in corso, specie dopo il ritiro dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 imposto da Donald Trump. Quasi ogni tappa dell’itinerario ha mostrato segni inequivocabili: nel Cameron Pass (Colorado) le verdi foreste sono ridotte a una distesa di alberi grigi dopo devastanti incendi (sempre più frequenti e violenti), mentre grazie al caldo gli insetti divoratori del legno si riproducono a una velocità doppia del normale. L’intensità e la forza distruttiva degli uragani sono aumentate e il mare divora le coste. Nel Glacier National Park (Montana) i ghiacciai più piccoli potrebbero scomparire già nei prossimi dieci anni e i galli cedroni fanno il nido sempre più in alto. Il solo segno di ottimismo è la diffusione crescente di fonti di energia rinnovabili, sole o vento.
Il viaggio insomma ci strappa dalla nostra stanza con aria condizionata dove possiamo cullarci nell’illusione che si tratti solo di eventi eccezionali e quasi ci costringe a renderci conto davvero della situazione. Purtroppo però proprio i viaggi sono a loro volta parte del problema. Il turismo potrà sembrare leggero e svagato, ma in realtà è la terza attività economica mondiale dopo la chimica e il petrolio, davanti a colossi come l’automobile o l’industria alimentare. Si capisce facilmente come il suo impatto climatico sia considerevole. Nel 2017 gli arrivi sono saliti alla quota record di un miliardo e trecentoventitré milioni (+7 per cento rispetto al 2017); la proiezione al 2030 raggiunge un miliardo e ottocento milioni, naturalmente con una quota crescente di cinesi. E parliamo solo di turismo internazionale, poiché il turismo interno ai diversi Paesi è molte volte maggiore.
Poco più della metà dei viaggiatori internazionali si muove per svago. I viaggi di lavoro per esempio sono soltanto il 13 per cento del totale (dati UNWTO 2016). La maggior parte dei viaggi internazionali avviene in aereo (55 per cento) o su gomma (39 per cento), solo il 2 per cento utilizza il treno. Quando in una notte d’estate, distesi nell’erba, vedete il cielo solcato dalle scie degli aerei, sappiate che uno su due trasporta turisti.
Viaggiamo troppo. Nell’inedito scenario dell’iperturismo, sospinto anche dalle compagnie low cost e dalle nuove tecnologie, i viaggi sono diventati sempre più brevi e frequenti. Andiamo a Barcellona anche solo per prendere un caffè, come un tempo si guidava sino al mare per noia in una notte d’estate. Ma in questo modo lasciamo dietro di noi un pesante fardello di CO2, liberata nell’atmosfera proprio nel momento peggiore.
Per cambiamenti veri, per invertire la tendenza, occorreranno scelte drastiche e coraggiose. Ma intanto sin da ora una prima soluzione è comunque a portata di mano: viaggiare meno ma più a lungo, tornando a un modello «classico» di vacanza. Dopo tutto la cultura del viaggio contemporanea, grazie a una nuova capacità di osservazione, ha promosso il turismo di prossimità, al limite anche soltanto nei dintorni di casa. Alternando la riscoperta del proprio territorio e delle regioni vicine a pochi, lunghi viaggi internazionali nei luoghi ai quali siamo veramente interessati, senza preoccuparci troppo delle mode, possiamo sin da ora ridurre di molto il nostro impatto ambientale. E questo senza nulla togliere al piacere di viaggiare, vedere, conoscere, anzi liberandoci dall’infelice condizione, caratteristica del turismo contemporaneo massificato, di distruggere i luoghi che più amiamo.