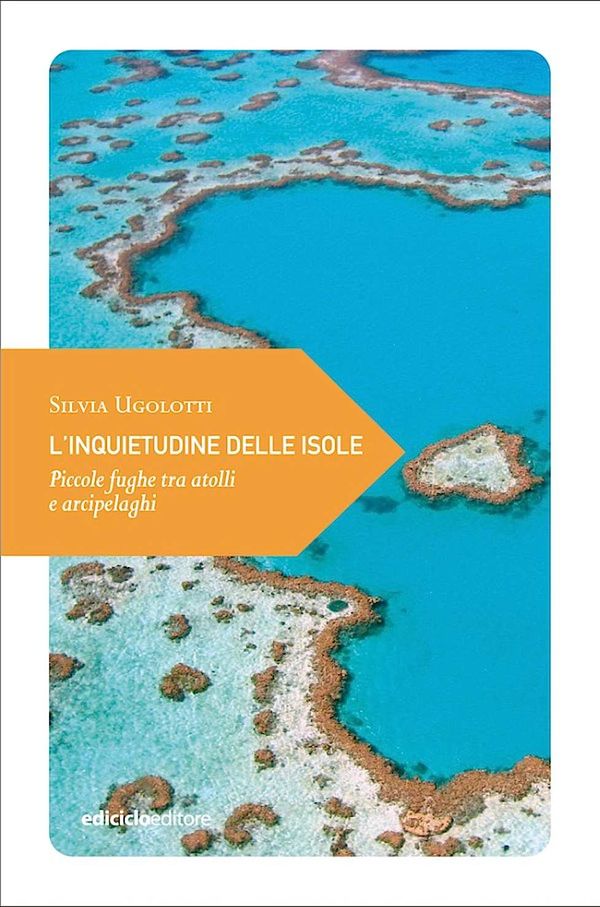Non è facile definire un’isola: è senza dubbio un’isola Bishop Rock, uno scoglio battuto dalle onde con un faro meraviglioso nell’arcipelago delle Scilly, a sud dell’Inghilterra. Ma l’Inghilterra poi non è forse essa stessa un’isola? E la Nuova Zelanda? E la Groenlandia, con i suoi oltre due milioni di chilometri quadrati? Insomma potremmo chiederci: quando sei troppo grande per essere ancora un’isola e devi rassegnarti a essere un continente?
Anche nel passato, del resto, le definizioni sono state spesso oscillanti. Per i Vichinghi un’isola era tale solo se ci voleva una nave con timone per raggiungerla. Per gli Irlandesi invece ci doveva essere abbastanza erba per nutrire almeno una pecora.
«Un’isola è un pezzo di terra circondato dalle acque, scoperto durante l’alta marea, e più piccolo di un continente» sostiene con maggior rigore scientifico il geografo Stephen Royle. Quante isole ci sono al mondo dunque? Le oscillazioni possono essere enormi, a seconda dei criteri adottati. Quando la Svezia fece un censimento delle sue isole nel 2001 i risultati variarono da 221’800 a 24 soltanto.
Le isole poi fanno strani scherzi. Nel 1831 l’Isola Ferdinandea spuntò dal mare di Sicilia giusto il tempo necessario per scatenare una disputa internazionale sul suo possesso tra Gran Bretagna, Francia e Regno delle Due Sicilie. Ma già l’anno seguente, forse spaventata da tanto fracasso, pensò bene di tornare sott’acqua.
Anche una piccola isola poi può essere attraversata dalla grande storia. È il caso di El Hierro, la più piccola delle Canarie, al largo della costa occidentale africana. Proprio lì nel II secolo d.C. il geografo Tolomeo fece passare il Meridiano zero, quello da cui si contavano tutti gli altri, ritenendo che fosse il punto più occidentale del mondo; e così per secoli è stata indicata su tutte le carte geografiche. Soprattutto i Francesi vi erano affezionati, perché si trovava a 20 gradi esatti a ovest del Meridiano di Parigi. E ancora nel 1884, quando venne spodestato dal Meridiano di Greenwich, il «Meridiano di ferro» era ancora utilizzato in Germania e nell’Impero austro-ungarico.
Le isole ci attraggono. Ci lasciano immaginare spazi di purezza preservata dalla corruzione della storia. Fu così anche quel giorno d’aprile del 1768, quando l’ammiraglio francese Louis Antoine de Bougainville – dopo aver attraversato l’immensa solitudine del Pacifico – giunse infine a Tahiti, accolto da uomini amichevoli e donne splendide ornate di collane di fiori, l’incarnazione del «buon selvaggio» immaginato da Rousseau.
Ancora alla fine dell’Ottocento il pittore Paul Gauguin partì a sua volta per Tahiti per rinnovare la propria ispirazione artistica e, nonostante qualche inevitabile disillusione, trovò quanto cercava: «La civiltà mi sta lentamente abbandonando. Comincio a pensare con semplicità, a non avere più odio per il mio prossimo, anzi ad amarlo. Godo tutte le gioie della vita libera, animale e umana. Con la certezza di un domani uguale al presente, così libero, così bello, la pace discende in me».
L’isola promette protezione dalla inquietante vastità del mondo perché offre uno spazio finito con un orizzonte infinito. Come ha scritto Fredrik Sjöberg: «L’isola esercita un’attrazione particolare su quegli uomini che sentono il bisogno di controllo e di sicurezza. Niente, infatti, è delimitato e concreto come un’isola». E proprio su un’isola – Runmarö, a est di Stoccolma – Sjöberg si è trasferito con la moglie e i tre figli. La vera ragione di questa scelta tuttavia è piuttosto l’insensata passione di Sjöberg per una particolare varietà di mosche, i Sirfidi, il cui aspetto esteriore simile alle api e alle vespe trae in inganno i loro predatori (L’arte di collezionare mosche, Iperborea, è proprio il titolo del suo primo libro di successo).
Oggi molte isole rischiano lo spopolamento, man mano che i loro abitanti prendono la via delle città e della modernità, come fece negli anni Trenta Marita, la nonna della scrittrice danese Siri Ranva Hjelm Jacobsen. Ma proprio la nipote un giorno avverte improvvisamente la nostalgia di un’isola verde, ventosa, scoscesa, un’isola delle Faroe dove pure non ha mai vissuto. Comincia così il racconto del viaggio di ritorno a Suðuroy (Isola, Iperborea).
Naturalmente per chi sull’isola ci vive sempre i sentimenti possono essere opposti: claustrofobia, isolamento, desiderio di fuga. Non a caso molte isole sono state carceri terribili, dalle quali si disperava di poter evadere, come la leggendaria prigione di Alcatraz, nella Baia di San Francisco, California. Per anni poi ho desiderato navigare sino all’isola di Sant’Elena, sperduta nell’Oceano Atlantico meridionale, dove fu confinato Napoleone perché perdesse ogni speranza di tornare in Europa. Scoperta nel 1502, distante duemila chilometri dalla costa angolana, è rimasta uno dei luoghi più difficilmente raggiungibili al mondo fino al 2017, quando è stato inaugurato il nuovo aeroporto internazionale.
Sulle isole proiettiamo i nostri desideri di avventure e ricchezze; nessuno l’ha raccontato meglio di Robert Louis Stevenson ne L’isola del tesoro (1883). Il più famoso racconto di pirati prese forma dalle fantasticherie di Stevenson sopra una mappa, iniziata dal figliastro Lloyd Osbourne (il quale pretese come compenso per la sua collaborazione che nella storia non apparissero donne) e completata dall’autore. Conoscete la storia: Jim trova una vecchia mappa del tesoro nel baule del vecchio marinaio Billy Bones, morto nella locanda gestita dai suoi genitori, attorno alla quale si aggirano loschi figuri…
Le isole sono state anche lo spazio ideale dove immaginare un mondo chiuso e perfetto. L’esempio più conosciuto è Utopia, pubblicata in latino nel 1516 dall’umanista Tommaso Moro, vent’anni prima di essere mandato a morte da Enrico VIII. Utopia è solo la prima di tante isole immaginarie, riflesse da miraggi, intraviste solo nei sogni dei marinai e dei poeti, eppure capaci di risorgere ogni volta nel taccuino del viaggiatore: sono L’isola non trovata (Guccini), L’isola che non c’è (Bennato).
La fascinazione profonda delle isole nasce proprio da questa ambiguità, da questa molteplicità di significati concentrata in uno spazio ristretto: un invito irresistibile per i viaggiatori. Del resto, come ha scritto Karen Blixen, «La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime o il mare».