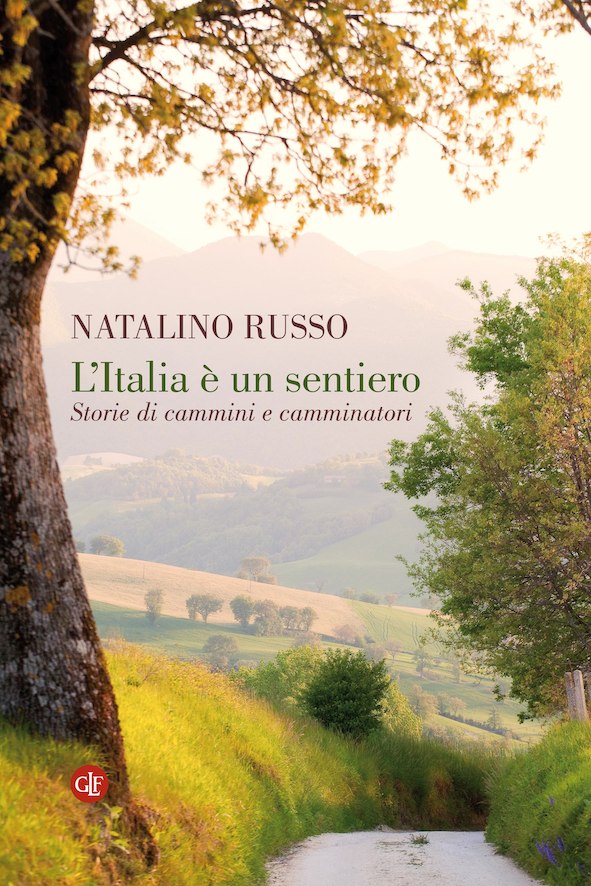Da qualche tempo la lingua svedese ha una nuova parola, «flygskam», «vergogna di volare», quando avvertiamo un senso di colpa pensando al danno ambientale causato dagli aerei. E subito sono sorte parole collegate come «tagskryt» («vantarsi di andare in treno») e «smygflyga» («volare in segreto»).
Greta Thunberg per il suo intervento a Davos ha preferito viaggiare 32 ore in treno dalla Svezia. Ma non è sola. Due sue connazionali, Maja Rosen e Lotta Hammar, hanno convinto quasi 15mila persone a smettere di volare per tutto il 2019: «Tanti sono preoccupati ma non sanno da dove cominciare. Un anno senza voli può essere il modo migliore per cambiare abitudini» ha spiegato Lotta. Secondo una ricerca del WWF, il 23% degli svedesi ha rinunciato a viaggiare in aereo nell’ultimo anno per ragioni ambientali, preferendo il treno.
In tutto il mondo cresce il numero di persone che ha scelto di non volare (o di volare meno). Tra loro molti studiosi del clima e dell’ambiente (e questo dovrebbe farci pensare) ma anche gente comune come Zoe Hatch, di Maidenhead, Regno Unito. Zoe ha smesso di volare nel 2015 e ha coinvolto nella scelta il marito e i due figli. Non è andata così male: «Quando voli il senso del viaggio scompare, mentre in treno avverti continuamente i cambiamenti nel mondo intorno a te». Sophie Voillot, una traduttrice di Montreal, ha volato un’ultima volta nel 2014 per organizzare il funerale del padre in Francia. Nella lista dei desideri aveva ancora viaggi negli Stati Uniti, India e Nepal, ma non pensa di aver perso qualcosa d’essenziale.
Volare è un diritto? Potrebbe piuttosto essere considerato un privilegio di pochi pagato da tutti. Infatti, solo il 3% della popolazione mondiale ha volato almeno una volta nel corso del 2017; e sino ad ora meno del 20% dell’umanità è salita su un aereo.
Nonostante queste modeste percentuali, gli aerei producono una parte importante (tra il 2 e il 5%, a seconda delle stime) dei gas serra responsabili dell’inquinamento globale, a cominciare dall’anidride carbonica (CO2), oltretutto rilasciata direttamente nelle zone più elevate (e delicate) dell’atmosfera. Indicativamente un aereo consuma come quattromila auto ma trasporta solo qualche centinaio di passeggeri. Un volo di linea tra Londra e New York, andata e ritorno, produce due tonnellate di CO2 per passeggero (fonte: «BBC») e provoca lo scioglimento di dieci metri quadri di ghiaccio artico (fonte: «Huffington Post»).
Senza dubbio le compagnie aeree potrebbero fare di più, ma sono state abituate male. Per troppo tempo sono state aiutate in ogni modo (anche con qualche problema di concorrenza rispetto per esempio al treno). Soprattutto nessuno ha chiesto loro di farsi carico della sostenibilità ambientale. Il risultato è stato la continua crescita dei voli, anche oltre la reale necessità. Ora qualcosa si muove. Il costo del carburante (la principale spesa) ha spinto diverse compagnie a rinnovare la flotta con aerei più efficienti e meno inquinanti. E finalmente la IATA (International Air Transport Association) si è impegnata per ridurre o compensare le emissioni degli aerei. L’accordo CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) sarà in vigore dal 2021, con l’obiettivo di mantenere le emissioni al livello attuale. È anche nel loro interesse: da qualche tempo le turbolenze sono più frequenti e più pericolose, l’aumento delle temperature riduce la portanza e rende più difficile il decollo da piste corte.
I passeggeri possono fare un’offerta per compensare le emissioni legate al proprio viaggio, sostenendo la creazione di nuove foreste o la produzione di energie rinnovabili. Non male, ma meglio sarebbe se non fosse volontaria, ma inclusa nel prezzo del biglietto. Si capirebbe allora meglio come molte tariffe irrisorie in realtà scaricano dei costi nascosti sulla collettività e l’ambiente. Inoltre non tutte le forme di compensazione proposte sono efficaci e certificate da organismi indipendenti. Altri interventi vengono continuamente rimandati, come la cancellazione dei programmi fedeltà. Al momento oltre 130 compagnie hanno programmi di questo tipo, con premi (per esempio voli gratuiti) sulla base dei chilometri percorsi. Sono ovviamente un incentivo a viaggi non necessari.
E tuttavia diverse organizzazioni – per esempio Greenpeace o Friends of the Earth – chiedono di più: far pagare alle compagnie aeree i costi reali della loro attività e tassare in misura crescente chi vola più spesso. Metà dei viaggi internazionali sono in aereo, metà di questi per turismo. Ha senso? Forse il volo dovrebbe tornare ad essere qualcosa di straordinario, giustificato da ragioni stringenti. Altrimenti meglio viaggiare con un altro mezzo di trasporto: il treno, per esempio. Un viaggio da Zurigo a Milano in aereo comporta l’emissione di oltre 100 kg di CO2 per passeggero rispetto a solo tre chilogrammi nel caso del treno. Su una tratta più lunga il rapporto migliora ma resta sempre nell’ordine di dieci a uno.
L’aereo consuma molto cherosene nella fase di decollo. Per questo un volo di breve durata può inquinare il doppio rispetto a uno a lunga distanza. Sulla base di questi dati in Francia alcuni deputati hanno proposto di vietare i voli tra città vicine tra loro, quando è disponibile un rapido collegamento ferroviario. Se si tenesse conto del tempo perso in aeroporto per i controlli doganali e di sicurezza, secondo un calcolo di «Le Monde», poco più della metà dei voli in Francia potrebbe essere sostituita dal treno. Per esempio il volo Lione-Marsiglia: 50mila passeggeri nel 2018 hanno causato inquinamento inutile.
Non è difficile immaginare un’applicazione del modello francese alla Svizzera, grazie anche alla geografia e alla buona qualità del sistema ferroviario. Sarebbe anzi interessante sperimentare la possibilità di abolire completamente i numerosi voli interni per la prima volta nel mondo. In maggio il Consiglio federale si è pronunciato contro l’ipotesi ma la questione non è certo chiusa. Al contrario altri mezzi di trasporto apparentemente inquinanti potrebbero in realtà essere preferibili. Una macchina di costruzione recente con quattro persone a bordo è ineccepibile dal punto di vista ambientale. Anche gli autobus a lunga percorrenza possono essere un mezzo di trasporto ecologico, economico, flessibile e confortevole.
Il cambiamento climatico pone una sfida ardua ma ha questo di buono: nessuna scelta contraddice le altre. Rinunce personali in favore di uno stile di vita più sobrio, progresso tecnologico, leggi più stringenti degli Stati e degli organismi internazionali, tutto va nella stessa direzione: quella giusta per l’ambiente.