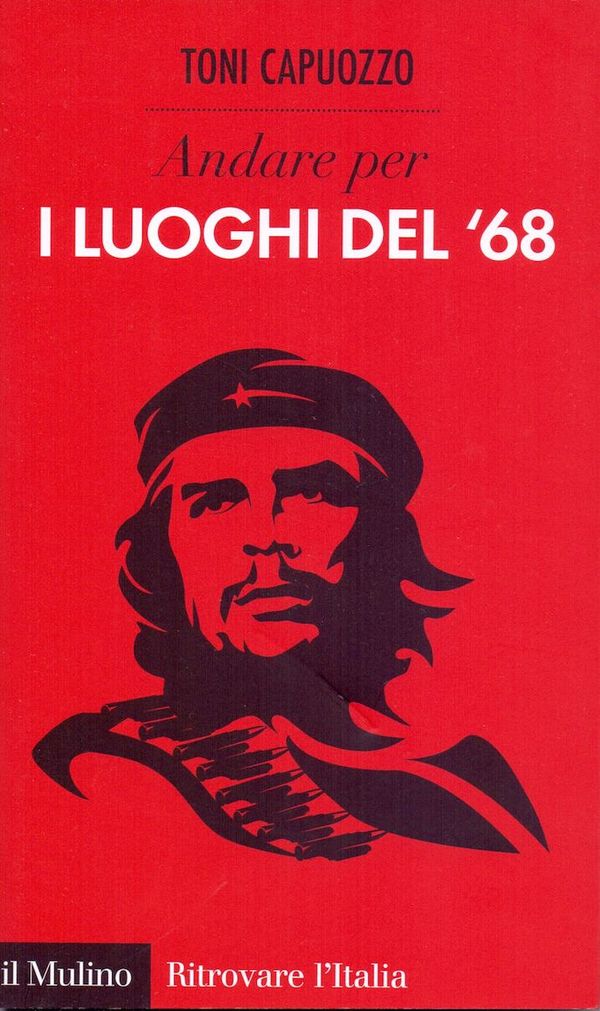«Va’ a dormire stanco vagabondo / Lascia che le città scorrano lentamente / Ascolta il canto d’acciaio delle rotaie» così canta Woody Guthrie nella Ninna nanna del vagabondo (Hobo’s Lullaby). Sapeva di cosa parlava. Per lunghi anni, da ragazzo, aveva vissuto d’espedienti e negli anni Trenta, quando terribili tempeste di polvere misero in ginocchio l’agricoltura dell’Oklahoma, fu costretto a cercare fortuna in California. Strada facendo conobbe molti hobo, com’erano chiamati allora i vagabondi americani.
Di hobo si comincia a parlare negli anni difficili seguiti alla Guerra di secessione (1861-65) tra nordisti e confederati e ancor più negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Il «Re degli hobo», «The Rambler», il Numero 1 («A-No.1») era considerato Leon Ray Livingston (1872-1944). Fu lui a creare il sistema di simboli che permetteva agli hobo di sapere dove trovare persone generose, cibo, lavoro, oppure come evitare cani pericolosi. Non è una leggenda: nel 2000 l’antropologa Susan Phillips ha trovato uno di questi segni tracciati col gesso sotto un vecchio ponte dimenticato lungo il fiume Los Angeles.
A differenza della maggior parte dei suoi colleghi, Livingston non beveva, non fumava, vestiva bene e aveva sempre qualche soldo in tasca. Scrisse diversi libri e dalla sua vita fu tratto anche un film di successo, L’imperatore del nord (1973). La trama: durante la Grande depressione il Numero 1, eroe dei diseredati per la sua abilità nel viaggiare di nascosto sui vagoni merci, si confronta con Shack, capotreno violento e spietato che non si arresta davanti a nulla, neppure a un omicidio, pur di tenere i clandestini lontani dai suoi treni.
Livingston raccontò i suoi vagabondaggi per l’America negli anni Novanta dell’Ottocento insieme a quello che sarebbe diventato lo scrittore più pagato del tempo, Jack London (L.R. Livingston, Coast to coast con Jack London, 1000eunanotte edizioni). Qualche anno dopo anche London raccontò le sue avventure in La strada. Diario di un vagabondo (Castelvecchi editore). La strana coppia attraversa un’America in crisi economica, popolata da diseredati, ferrovieri corrotti, venditori di elisir, impavidi sceriffi, vedove dal cuore grande, banditi...
Nel 1906 il numero degli hobo era stimato in mezzo milione (0,6 per cento della popolazione). Erano quasi tutti uomini naturalmente, ma emergono occasionalmente figure femminili come Bertha Thompson, «Box-Car Bertha» (è il titolo del libro pubblicato da Giunti), il personaggio creato da Ben Reitman ispirandosi alle vicende reali di una certa Retta Toble: «Ho trent’anni ora, mentre scrivo, e sono stata hobo per quindici anni…».
L’hobo è un uomo senza famiglia e senza carriera, sempre pronto a mettersi in viaggio saltando a bordo di un treno merci. E poi polvere di strade, alloggi di fortuna, amori rubati, qualche lavoro occasionale, meglio se all’aria aperta in una fattoria. È una vita precaria, in guerra perpetua con il freddo, la fame, le guardie assoldate dalle compagnie ferroviarie per dare la caccia ai viaggiatori di straforo. E poi i poliziotti naturalmente. Ancora Woody Guthrie nella Ninna nanna del vagabondo canta: «So che la polizia ti crea problemi / Quelli creano problemi dappertutto / Ma quando morirai e andrai in cielo / Non troverai di certo sbirri lassù». Invece nel paradiso degli hobo immaginato da un altro musicista, Harry McClintock (Big Rock Candy Mountains, 1928) i poliziotti ci sono, ma hanno gambe di legno, i loro cani denti di gomma e le sbarre delle prigioni sono di morbido stagno, anziché acciaio.
C’è qualcosa dell’hobo anche nel personaggio di Charlot, creato da Charlie Chaplin a partire dal 1914. Ma sarà soprattutto la Grande depressione, negli anni Trenta del Novecento, a far aumentare a dismisura il numero di persone spinte sulla strada dalla disperata ricerca di lavoro. In fondo hobo potrebbero essere anche George e Lennie, i braccianti che si guadagnano da vivere vagando per il paese di fattoria in fattoria, descritti da John Steinbeck in Uomini e topi (1937).
L’hobo si distingue sia dai lavoratori stagionali sia dai barboni perché è definito da una cultura (o meglio controcultura): è vagabondo e marginale per scelta prima ancora che per necessità; ha una sua dignità, curiosità e interessi, dei valori, un’idea del mondo basata sul viaggio e la libertà, il desiderio d’avventura, l’orgoglio di essere padrone del proprio destino.
Quando negli anni Cinquanta si afferma la società dei consumi, la figura dell’hobo gradualmente scompare. In fondo, come il cowboy, apparteneva all’America giovane e violenta della frontiera. La sua eredità tuttavia si è conservata soprattutto nell’arte e nella letteratura. Si coglie ancora nell’inquietudine esistenziale della Beat Generation e in un libro di viaggio famoso come On the Road di Jack Kerouac, pubblicato nel 1957. «Sal, dobbiamo andare e non fermarci mai finché non arriviamo». «Per andare dove, amico?». «Non lo so, ma dobbiamo andare».