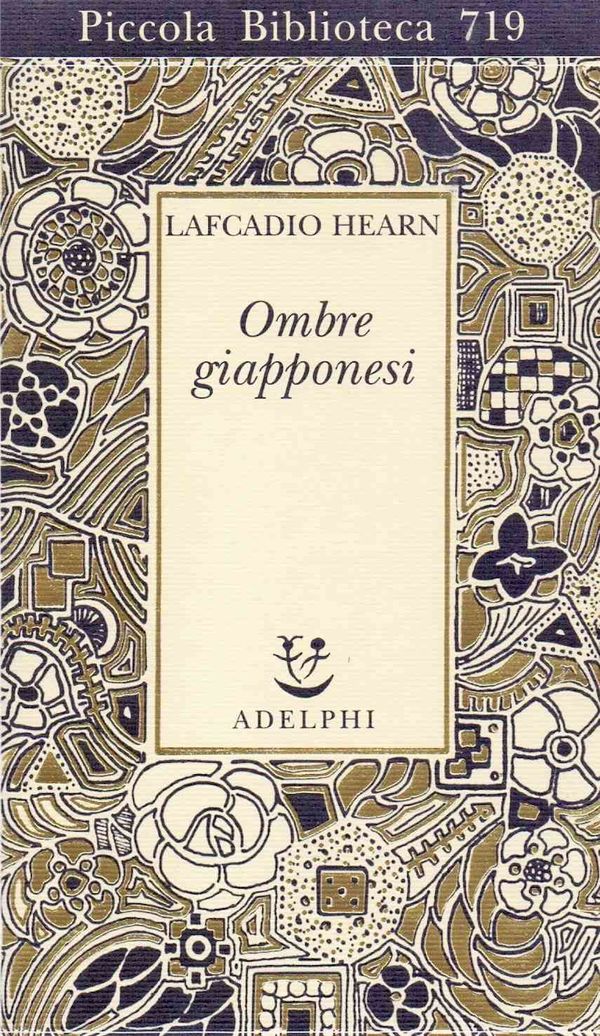Expat, la fortunata abbreviazione di expatriate / espatriato, indica una persona che risiede temporaneamente in un altro Paese, di solito per lavoro o dopo il pensionamento. Molti di loro sono strapagati professionisti e manager, ma sono ben rappresentati anche giornalisti, scrittori, artisti. È un termine usato soprattutto in Asia ma nel mondo globale è sempre più diffuso; persino il prestigioso «Wall Street Journal» ha un blog interamente dedicato alle diverse forme di questa condizione umana (https://blogs.wsj.com/expat).
Alcuni Paesi come la Thailandia sono prediletti dagli expat perché lo straniero è ben accolto e non deve rendere conto a nessuno delle sue scelte. In Giappone invece – sostiene chi ci ha vissuto – gli stranieri non sono sempre ben visti se, pur vivendoci a lungo, non si inseriscono rapidamente nella società; è invece apprezzato chi studia la lingua, mangia cibo giapponese, condivide valori e abitudini, compra casa e si sposa.
Da qualche tempo però questo termine expat è anche molto discusso. Per esempio lo scrittore e fotografo canadese Christopher DeWolf vive a Hong Kong dal 2008 e si è chiesto che senso abbia immaginarsi e raccontarsi come uno straniero in una città dove tutti sembrano venire da qualche altra parte del mondo; in una città costruita da immigrati sotto lo sguardo compiacente della potenza coloniale inglese e tuttora protetta da uno statuto speciale dopo il suo ritorno alla Repubblica popolare cinese.
«La città tra i mondi» l’ha definita lo scrittore Leo Ou-fan Lee, a sua volta nato in Cina, cresciuto a Taiwan, studi universitari negli Stati Uniti prima di stabilirsi a Hong Kong. Solo con il tempo e la fatica Leo Ou-fan Lee riesce a gettare lo sguardo dietro la superficie scintillante dei centri commerciali, i super condomini e le insegne al neon dei grattacieli dove vivono i cinesi per ritrovare i mercati sull’acqua, le librerie familiari di Mong Kok, i villaggi di pescatori, i templi di montagna, le bancarelle di noodle, l’opera cantonese…
Ma la città più nascosta non è necessariamente più vera; forse è solo più difficile vederla.
In ogni caso, a Hong Kong come altrove il termine expat sembra applicarsi soltanto agli agiati occidentali bianchi. Tutti gli altri – arabi, filippini o sudamericani – sono considerati invece immigrati. Sono sfumature linguistiche cariche di significato.
Come ha osservato Mawuna Remarque Koutonin, attivista di Africa Renaissance, lo stesso avviene anche tra Africa ed Europa. I professionisti africani attivi nell’Unione europea non sono expat, sono «immigrati di alto profilo» nel migliore dei casi. L’uso del termine expat insomma potrebbe avere una nascosta, forse involontaria componente di razzismo, ma certo esprime soprattutto differenze di classe e di status del Paese di provenienza. Infatti, anche Polacchi, Lituani e Lettoni, per fare un esempio, quando vanno a lavorare in un altro Paese europeo sono considerati immigrati, sebbene siano bianchi.
In queste critiche ci sono senza dubbio elementi di verità e per questo molti propongono di abolire semplicemente il termine expat e di usare per tutti immigrato. Ma potrebbe essere una soluzione troppo radicale, perché restano tra i due termini differenze di significato.
Per cominciare l’immigrato spesso è costretto a partire dalla povertà, mentre l’expat è chi vive in un Paese straniero per scelta, non solo lavorativa, ma anche perché ne apprezza il clima, la cultura, la vita quotidiana.
Molti strada facendo hanno trovato il loro secondo Paese, quello dove avrebbero voluto nascere, se fosse possibile scegliere. Tra loro c’era anche Gustave Flaubert, l’autore di Madame Bovary. Flaubert viveva nella provinciale Rouen, dove si annoiava a morte; pensava di essere un seme che il vento aveva portato nel posto sbagliato e sosteneva che dovresti avere la cittadinanza del posto che ti attrae, nel suo caso l’Egitto (e alla fine riuscì a coronare il suo sogno di viaggiare lungo il Nilo).
In ogni tempo poi sono esistite patrie ideali. Nel Rinascimento tutti volevano viaggiare in Italia e si sforzavano di parlare italiano; negli anni Trenta del Novecento Joséphine Baker cantava «J’ai deux amours / Mon pays et Paris» e nel 1937 ottenne infine la cittadinanza francese.
Anche quando scopre il suo secondo Paese, di solito l’expat non si trasferisce definitivamente: conserva la nazionalità e il passaporto della terra d’origine, dove trascorre comunque lunghi periodi. E anche all’estero passa molto tempo con i connazionali, a volte formando piccole società chiuse. Gli expat sono quasi esclusivamente occidentali perché possono permetterselo, perché hanno lavori migliori e quindi maggiori risorse economiche. Inoltre i loro passaporti sono accettati ovunque (oltre centocinquanta Paesi nel mondo accolgono i nostri viaggiatori senza visto, sono solo una cinquantina nel caso di chi viene dal Nord Africa); possono tornare a casa quando lo desiderano, per loro tutte le porte restano aperte.
Ma non si tratta soltanto di condizioni materiali più favorevoli. Eredi di generazioni mobili e inquiete, i Viaggiatori d’Occidente conoscono e apprezzano il sottile piacere di vivere, lavorare, amare sul confine tra due mondi e in due lingue diverse, senza appartenere interamente a nessuno dei due.