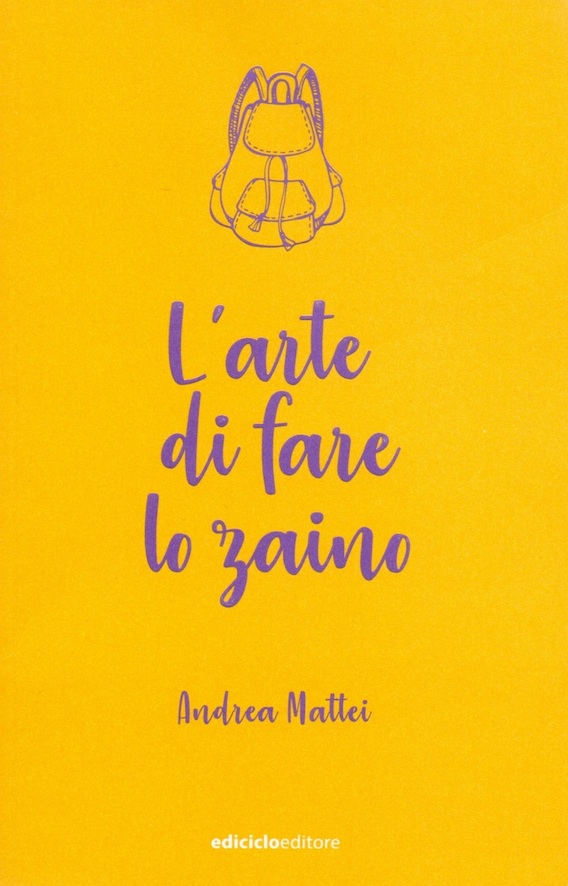Luke Dale Roberts, il più famoso chef del Sudafrica, ha cominciato a servire le sue ricette su eleganti fogli di carta monouso con una cornice; in questo modo evita di lavare cinquemila piatti alla settimana e risparmia acqua. Inoltre chiede ai suoi ospiti di usare le stesse posate per le varie portate, una bestemmia in un locale di lusso come il suo.
Benvenuti a Città del Capo, la più importante destinazione turistica del Sudafrica grazie alla sua storia coloniale, alle memorie di Nelson Mandela e della lotta all’Apartheid, alla natura, alle spiagge, alla vita notturna. Purtroppo dopo tre anni di siccità, la peggiore di sempre, la città sta finendo le sue scorte idriche. Il Giorno Zero, quando dai rubinetti non uscirà neppure una goccia d’acqua, era stato fissato dapprima al 15 aprile, poi è stato spostato un poco in avanti: prima all’11 maggio, poi al 4 giugno, infine al 9 luglio.
Questo primo risultato è stato possibile grazie agli sforzi di tutti per risparmiare acqua, tanto che in pochi mesi i consumi sono più che dimezzati. Come si fa? Docce non più lunghe di tre minuti, meglio ancora trenta secondi, anzi perché non lavarsi in mare? E poi sapete quanta acqua usate ogni volta che azionate lo sciacquone? A Città del Capo tutti conoscono la risposta (tredici litri) per questo lo fanno solo quando… ci siamo capiti.
Si dirà: perché i turisti non stanno a casa loro, finché manca l’acqua? La risposta è semplice: garantiscono 320mila preziosi posti di lavoro. Meglio allora considerare Città del Capo come una palestra, un’anticipazione del mondo che verrà, dal momento che la situazione è simile in almeno altre centoventi città del mondo. E non pensate a piccole città di provincia; stiamo parlando di Città del Messico, Tokyo, Delhi. Negli Stati Uniti Los Angeles viene da sei anni di siccità. Tutta l’Europa mediterranea poi, prediletta dai turisti ma semi-arida, ha gli stessi problemi.
Anche il turismo ha le sue responsabilità. Nel 2016, secondo «UNWTO Tourism Highlights», gli arrivi internazionali sono stati 1 miliardo e 235 milioni, mai così tanti. Il 55% dei viaggiatori è giunto a destinazione in aereo, con ovvi impatti sulle emissioni di CO2. Questo vuol dire che un volo su due è riservato ai turisti, mentre i viaggi di lavoro contano solo per il 13%.
Nel frattempo in Canada (a Victoria, nella Columbia Britannica) è stata organizzata la prima conferenza nazionale sul turismo sostenibile. Il 2017 è stato il miglior anno di sempre per il turismo canadese, superando di oltre un milione di visitatori il record precedente, anche grazie alla politica di Trump che ha deviato verso nord molti turisti diretti negli Stati Uniti. E se Trump ha ritirato gli USA dagli Accordi di Parigi, in Canada invece nessuno dei presenti ha messo in dubbio il cambiamento climatico in corso, né le responsabilità umane, turisti compresi. Al contrario – si è detto – proprio i periodi positivi consentono decisioni coraggiose per mitigare gli effetti del cambiamento climatico (incendi nei boschi, scioglimento dei ghiacci ecc.) e proteggere la natura selvaggia, anche a costo di ridurre il numero di turisti.
Questa consapevolezza purtroppo non è ancora diffusa. E dunque se l’industria turistica e i governi fanno troppo poco per la sostenibilità, dovremmo alzare la voce come consumatori, prima che sia troppo tardi. Alcune utili indicazioni vengono da una delle maggiori organizzazioni di operatori del settore, il World Travel and Tourism Council. Il WTTC ha recentemente lanciato la campagna «Chiediamo troppo?» (toomuchtoask.org), proponendo ai turisti di impegnarsi in prima persona, anzi di stringere un vero e proprio patto, per esempio chiedendo agli organizzatori dei nostri viaggi cosa fanno per l’ambiente e la società, scegliendo poi chi dà le risposte più convincenti. Altri suggerimenti? Informarsi in modo adeguato prima della partenza, sforzarsi di comprendere e rispettare la cultura dei Paesi visitati; adeguarsi alle consuetudini quotidiane, per esempio riguardo al modo di vestire o alla religione; non visitare luoghi sacri senza aver ricevuto il permesso; acquistare sempre cibo e servizi dai produttori locali. Sul piano della sostenibilità ambientale, dovremmo compensare l’anidride carbonica emessa nel nostro viaggio, ridurre il consumo d’acqua dove è scarsa, utilizzare meno plastica possibile smaltendola in modo adeguato, non partecipare ad attività che causano sofferenza agli animali.
Per quanto difficile, il cammino è chiaro. Il turismo sostenibile e responsabile non è più una nicchia di mercato, magari di lusso; ne abbiamo bisogno sempre, anche nelle destinazioni più popolari. La trinità introdotta dalle compagnie low cost – viaggi frequenti, lontano e a poco prezzo – non è sostenibile neppure nel medio termine e va semplicemente ribaltata: viaggiamo meno, ma restiamo più a lungo nei luoghi visitati; alterniamo lunghi viaggi internazionali alla scoperta dei Paesi vicini e al turismo di prossimità, nel proprio cantone e in quelli confinanti; accettiamo che la sostenibilità ha un costo.
È un nuovo stile di viaggio imposto dalla situazione, per ora in casi estremi come Città del Capo, ma presto ovunque; al tempo stesso tuttavia è anche un modo di viaggiare lento, profondo, interessante, coinvolgente. È il turismo di domani, se vogliamo che ci sia un domani.