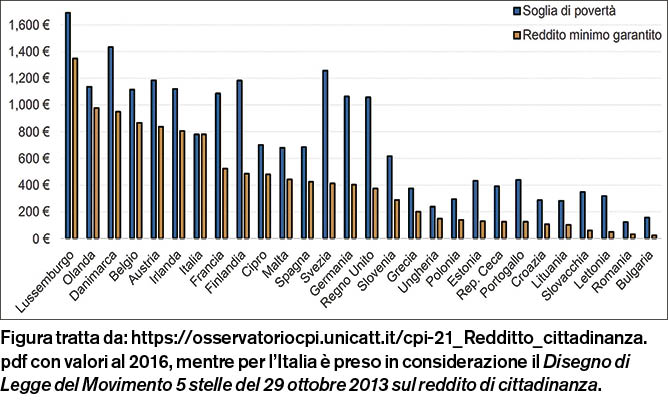Si è già avuto modo nell’articolo dal titolo Reddito e rendita, simili eppur diversi apparso sul numero 15 di «Azione» (2016) di trattare nel dettaglio la differenza fra i concetti economici di «rendita» e «reddito». Tale distinzione − fondamentale ma trascurata nelle decisioni di policy economica − non deve essere data per scontata in tempi in cui il dibattito mediatico ha occupato ampio spazio dedicato a temi come quelli del «reddito di cittadinanza». È questo il caso della vicina penisola italiana, che con decreto legge (D.L.) 4/2019 dal titolo Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ha introdotto una misura di sostegno finanziario (rivolta al successivo reintegro nel mondo lavorativo) laddove in possesso di certi requisiti fra cui economici quali un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9360 Euro annui e patrimonio immobiliare (oltre a quello della casa di abitazione) non superiore a 30’000 Euro. Il tutto per un beneficio, il cui importo complessivo non può eccedere 780 Euro mensili.
Si deve, però, dire che tale «reddito di cittadinanza» dovrebbe per le sue stesse caratteristiche essere ribattezzato in «rendita di residenza» come si andrà a breve ad illustrare. Salta ancora una volta all’occhio la profonda diversità che sussiste fra la nozione di «reddito» (che deriva solo ed esclusivamente da una nuova produzione di beni e servizi a vantaggio della Nazione nel suo complesso) rispetto appunto a quella di «rendita» (che implica invece il trasferimento di risorse economiche non nuove, ma preesistenti). Se il reddito arricchisce il Paese nella sua generalità aumentandone le risorse complessivamente disponibili, le rendite, alias i trasferimenti, non sono altro che un meccanismo a somma nulla, cioè il segno «meno» nel conto economico dell’uno (quale lo Stato ed i suoi contribuenti che cederanno risorse) è compensato dal segno «più» per chi li percepisce. In altri termini, ogni forma di sussidio, reddito minimo garantito (guaranteed minimum income nella terminologia internazionale) − pertanto, anche il cosiddetto «reddito di cittadinanza» – non è altro che un mero trasferimento di risorse, cioè «rendita», ma certamente non «reddito».
Essere consapevoli di tale differenziazione è fondamentale, poiché in assenza di essa si potrebbe erroneamente pensare che simili forme di supporto statale saranno (perlomeno, direttamente) fonte di benessere economico: certamente, esse possono sì esserlo indirettamente laddove il beneficiario (ri)trovi presto un’occupazione remunerata, che gli permetta di (re)integrarsi nei meccanismi lavorativi e di produrre egli stesso nuovo reddito, ma non possono certo esserlo per via diretta. È evidente che, se tale meccanismo di trasmissione (con cui un sussidio dovrebbe trasformarsi in incentivo occupazionale così da generare nuovo reddito) non dovesse per qualsivoglia ragione funzionare, la rendita rimarrebbe tale senza creare alcun effetto di PIL (cioè nuovo «reddito») per il Paese nel suo complesso. Tornando allo spunto di riflessione iniziale, non si può evitare di rimarcare che non soltanto tale «reddito» è in realtà una «rendita» ma anche che il concetto di «cittadinanza» deve essere altresì sostituito con quello di «residenza». Infatti, i requisiti della neo-introdotta misura lo confermano: perciò, uno dei criteri principali per accedervi − al di là dell’aspetto finanziario-patrimoniale − è proprio la «residenza», cioè quel «luogo in cui una persona vive abitualmente, formalmente indicato nei registri anagrafici comunali» (1), e non la «cittadinanza», cioè quel «vincolo di appartenenza di un individuo a uno Stato». Infatti, come indicato alla pagina informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, «[i]l richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo». Et voilà, ecco che il «reddito di cittadinanza» diviene necessariamente una «rendita di residenza».
Solo un problema terminologico, quindi? Non necessariamente poiché − se da un lato la pericolosità di non differenziare fra «reddito» e «rendita» è già stata illustrata ampiamente − anche la mancata distinzione fra «cittadinanza» e «residenza» non pare cosa da poco: in caso contrario, gli italiani residenti all’estero dovrebbero potere accedere a tali misure di sostegno semplicemente in forza della loro immutata cittadinanza. Cosa che, invece, non possono, sebbene proprio nelle scorse settimane da fonti importanti di Governo siano giunte rassicurazioni circa l’estensione agli italiani expat. Ancora una volta, pare quanto mai importante operare distinzioni lessicali al fine di inquadrare con altrettanta precisione ogni problematica in esame.