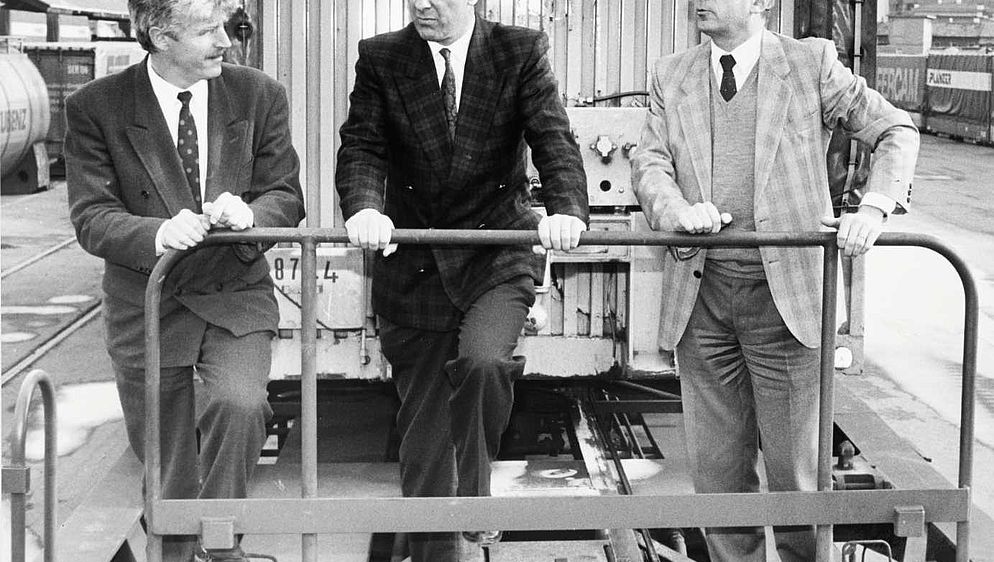Quello della mobilità, che rappresenta un perno attorno a cui ruota la nostra società, è un settore in continua evoluzione. In termini di sicurezza, velocità e concorrenzialità le aspettative sono molto alte, mentre crescono costantemente anche i volumi di traffico. Dopo l’inaugurazione di AlpTransit, non ci sono stati solo momenti positivi, è infatti delle ultime settimane la notizia secondo cui SBB Cargo si troverebbe in una grave impasse economica che ha messo a repentaglio centinaia di posti di lavoro, mentre il Brennero e il San Bernardino lamentano un aumento dei transiti dei mezzi pesanti dopo l’apertura della Galleria di base del Gottardo.
Da oltre mezzo secolo Hupac, azienda nata e cresciuta in territorio ticinese, gioca un ruolo da protagonista nelle scelte politiche, progettuali e strategiche della mobilità delle merci. Essa è infatti l’interlocutore fidato di politici, imprenditori, ambientalisti e iniziativisti, ed è riuscita così a creare delle fruttuose sinergie tra settore pubblico e settore privato.
Abbiamo incontrato Beni Kunz, classe 1957, CEO dell’azienda chiassese, che grazie alle sue invidiabili doti di mediatore, comunicatore, ma anche osservatore, pur rimanendo discretamente dietro alle quinte di diplomazia e politica, ha avuto un insospettabile peso specifico nella storia recente svizzera, europea ed internazionale, del trasporto delle merci.
Signor Kunz, dove si situa Hupac nel panorama svizzero e internazionale?
Per raccontare la storia di Hupac, credo sia importante partire proprio dagli inizi della storia dell’azienda, da quel 1967 in cui i ticinesi Pietro Ris, Sandro Bernasconi, Franz Hegner, Jacky Maeder e Hans Bertschi insieme alle ferrovie svizzere ebbero l’idea di trasferire i camion sulla ferrovia, creando la Hupac. A quel tempo l’esigenza del trasferimento non era di natura ambientale, ma meteorologica: le gallerie non esistevano ancora e quando nevicava si doveva passare dal Brennero o da Modane, allungando così la strada di 300 chilometri. Un sistema di trasporto dei camion su ferrovia esisteva già negli Stati Uniti, veniva chiamato «piggyback». Il nome Hupac deriva da «Huckepackverkehr». Se consideriamo che la politica europea cominciò a parlare di trasferimento negli anni 90, i fondatori di Hupac erano avanti di trent’anni rispetto alla loro epoca.
Le FFS sostennero da subito il progetto di Hupac?
Certo, anche perché senza le FFS sarebbe stato impossibile partire, nonostante avessimo già i volumi necessari di merce. All’inizio ci furono molte resistenze, la collaborazione tra la strada, che rappresentava la concorrenza, e i binari era considerata un tradimento: il detto era, «Mai andare a letto con il diavolo». Fu Franz Hegner, primo direttore generale delle FFS, e già nel consiglio Hupac, a mettere pace tra le due parti, e questa sinergia fa ormai parte della nostra cultura da cinquant’anni.
E la politica quale ruolo ha avuto in questo scenario?
Il primo consigliere federale che si impegnò per un ulteriore sviluppo del traffico intermodale fu Adolf Ogi. Un giorno, eravamo all’inizio degli anni 90, ci telefonò annunciando che sarebbe venuto a Chiasso per farsi spiegare il nostro lavoro poiché, per dirla con le sue parole, doveva «vendere il sistema combinato alla commissione europea». Con il pragmatismo che gli era congeniale nel 1992 convinse la Commissione europea della bontà del nostro sistema ferroviario. Ogi invitò molti ministri europei a vedere con i propri occhi la limitatezza del nostro sistema stradale, soprattutto a ridosso del Gottardo. Per rendere fino in fondo l’idea offriva agli ospiti dei cosiddetti «tour didattici di convincimento» in elicottero, durante i quali sorvolava Göschenen, località in cui spesso ci chiedeva di attenderlo con un paio di bilici e di vagoni. Quando nel 1992 nacque l’idea della Galleria di base noi eravamo nel settore già da 25 anni. A quel tempo oltre a noi in Svizzera c’era Intercontainer, di cui erano socie tutte le ferrovie europee.
Pur collaborando con la politica, Hupac si è spesso mossa con le proprie gambe, investendo all’estero e affidandosi alle proprie visioni. Quali sono state le maggiori difficoltà?
La Hupac è cresciuta costantemente, diventando il più grosso operatore internazionale. Grazie alla sua politica di investimento, oggi la Hupac dispone di più di 5500 vagoni propri, per un valore che raggiunge il mezzo miliardo di franchi. Nel 2008 abbiamo aperto degli uffici in Russia e nel 2015 a Shanghai, poiché la Cina ha deciso di sfruttare la via della Seta per raggiungere i mercati europei via terra. Un grosso problema sono state le dimensioni dei binari: in Cina hanno le stesse dimensioni di quelli europei, ma poi dal Kazakistan fino alla Polonia, passando per la Russia, i binari sono più larghi. Questo è un retaggio della Seconda guerra mondiale: le dimensioni dei binari venivano cambiate per ostacolare le invasioni. Un problema simile è dato dall’elettricità, che a livello europeo non è ancora standardizzata: una locomotiva che dalla Germania viaggia verso l’Italia ha tre sistemi elettrici diversi. Vi sono poi i macchinisti, che per legge devono parlare più di una lingua… L’anno scorso, quando crollò la galleria a Rastatt, e restammo bloccati per settimane, avevamo un’alternativa via Francia, ma non abbastanza macchinisti tedeschi che parlassero il francese, come previsto dalla Comunità europea. Proponemmo l’impiego di macchinisti tedeschi nel sistema di controllo francese, ma fummo bloccati politicamente. La commissione europea deve capire che se non si comincia a dare priorità alle soluzioni pragmatiche, il sistema del traffico europeo può andare in tilt da un momento all’altro.
In Svizzera gli anni Novanta furono contraddistinti da importanti plebisciti popolari, in cui il popolo prese decisioni coraggiose rispetto alla gestione del traffico… quale fu il vostro ruolo?
Negli Anni novanta ci furono molte votazioni sul traffico, nonché l’Iniziativa delle Alpi, e tutte dimostrarono come il popolo svizzero fosse a favore di questo tipo di trasferimento. Hupac ebbe un ruolo attivo a Berna, dove fu coinvolta in molti processi decisionali dalla commissione dei trasporti. Il dialogo tra Hupac e la politica è sempre stato serrato, dapprima con Adolf Ogi, poi con Moritz Leuenberger e ora con Doris Leuthard. I ministri ci consultano spesso poiché, grazie ai nostri cento azionisti, che sono i più grossi trasportatori d’Europa, abbiamo modo di sondare l’opinione del mercato.
Hupac è nata a Chiasso, ma contrariamente ad altre importanti aziende presenti sul territorio, è proprio in questa regione che sembra volere restare…
Noi siamo cresciuti qui e il nostro mercato numero uno è l’Italia, la cui vicinanza ci è servita per crescere. Da Chiasso Hupac non controlla solamente il mercato italiano, ma il mondo intero. Eppure, nonostante questa dimensione globale, non abbiamo mai dimenticato il concetto di responsabilità sociale, che io stesso ho ereditato dal mio predecessore Theo Allemann. La responsabilità sociale si traduce in molti modi, ad esempio nel desiderio di integrare i giovani nell’azienda, o nella creazione di corsi interni per gli apprendisti. Per Hupac i giovani sono il valore più importante, consapevolezza che ha portato anche alla creazione (in collaborazione con il Basket di Vacallo e altri partner) dell’associazione «Talento nella Vita». Anche se siamo un’azienda globale, il nostro cuore è locale.
Sono orgoglioso di fare parte di questa azienda e ci tengo a ricordare sempre la cultura dei soci fondatori: Sandro Bernasconi ad esempio, partecipava alle riunioni in tuta blu, le mani sporche di olio perché aveva appena finito di caricare i camion e mettere le catene… ed è questo l’esempio che deve passare alla prossima generazione. I nostri soci fondatori entrarono in affari non per fare i miliardi, ma per creare un sistema sostenibile, per crescere e garantire i posti di lavoro e reinvestire i soldi. Queste sono le nostre radici e i nostri valori e non abbiamo intenzione di metterli in discussione.
Qualità svizzere come la puntualità, la precisione, l’affidabilità e magari anche un briciolo di follia visionaria, hanno ancora valore sul tavolo delle trattative?
Il progetto AlpTransit è stimato a livello mondiale e ha fatto il giro del mondo. Se si pensa a grandi progetti arenati o falliti in contemporanea ad AlpTransit, come l’aeroporto di Berlino, costato il triplo del previsto e ancora chiuso, il disastro della stazione di Stoccarda o, appunto, il crollo della galleria di Rastatt, ci si rende conto di quanto sia eccezionale la Galleria di base. Accompagnando delle delegazioni in diverse ambasciate del mondo ho potuto constatare come la «Swiss precision» sia ancora oggi un marchio fantastico. Grazie ad AlpTransit la Svizzera ha creato un trend nella logistica europea.
Signor Kunz, ci spiega meglio la disposizione dei cosiddetti terminali intermodali, ossia le enormi piazze addette al carico e allo scarico di merce?
La nascita dei terminali rappresenta un ottimo esempio della collaborazione tra governo svizzero e mercato. Il terminale di Busto Arsizio ad esempio è nato su iniziativa svizzera di Hupac. Dopo un periodo iniziale a Milano, negli anni Settanta la Hupac si trasferì al vecchio scalo di Busto Arsizio. Le cose andarono bene finché il traffico non cominciò a lievitare, allora Busto Arsizio ci propose l’acquisto di un terreno di 120’000 metri quadrati. Il governo svizzero ci diede il suo sostegno, anche perché, se è vero che la Svizzera vuole il traffico su ferrovia, è giusto che il traffico di transito venga caricato e scaricato nei luoghi di origine e destinazione e non in Svizzera che rappresenta solo un’area di transito.
Ormai anche il terminale di Busto Arsizio ha raggiunto i propri limiti di capacità, per cui con il governo svizzero stiamo costruendo i terminali di Milano, Brescia e Piacenza. In cambio della costruzione a nostre spese dei tre terminali, dall’Italia abbiamo ottenuto il permesso di potenziare la linea ferroviaria di Luino (ristrutturata a nostre spese), che è quella più diretta per Busto Arsizio. È stata una lotta da entrambe le parti della frontiera: inizialmente infatti anche i nostri politici erano contrari a spendere 120 milioni di franchi per la ristrutturazione di una linea italiana. A quel punto cominciai anch’io, in rappresentanza di Hupac, ad organizzare dei «tour didattici» con parlamentari svizzeri e italiani, durante i quali spiegavo le nostre necessità, senza mai perdere di vista l’obiettivo ultimo, che è il trasferimento!
Il tanto agognato accordo con l’Italia c’è dunque finalmente stato?
All’assemblea di Lugano del 2012, cui ha partecipato anche Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, abbiamo firmato un accordo che è la base per il collegamento AlpTransit Gottardo-Chiasso, nonché per la tratta di Luino. Sono tre gli elementi che hanno portato a una collaborazione ottimale in ambito ferroviario: prima di tutto c’è stato un accordo bilaterale tra Hupac e FS con l’investimento e la progettazione dei nuovi terminali. Nel 2011 vi è poi stato l’accordo dei Castelli tra Andreas Meyer e Mauro Moretti, che prevede l’accesso ad AlpTransit da parte della rete italiana via Chiasso, Luino e Domodossola. Infine non va dimenticato l’accordo ministeriale tra i ministri Passera-Lupi-Delrio e Doris Leuthard a livello di trasferimento. La collaborazione tra Svizzera e Italia non è mai stata tanto trasparente come oggi. Questo accordo rappresenta la base del milione di camion che trasportiamo sulla ferrovia ogni anno.
Un milione di camion attraversa la Svizzera su rotaia, eppure siamo ancora lontani dall’obiettivo dell’Iniziativa delle Alpi, che chiede una riduzione dei transiti autostradali a 650’000 camion all’anno.
Attualmente il numero dei camion che transitano in strada ogni anno è inferiore al milione. Sarà però difficile migliorare la situazione finché non si risolve il problema del profilo dei quattro metri. Nel 2012 ci eravamo infatti resi conto che la Svizzera aveva investito 20 miliardi nella costruzione di una galleria alta quattro metri, come quelle autostradali, sebbene le linee dei portali nord e sud fossero alte solamente 3,80 m. In questo modo, una volta conclusa AlpTransit, si sarebbero potuti trasportare i container ma non i bilici! Noi della Hupac iniziammo a fare lobby con diverse associazioni, tra cui anche l’Iniziativa delle Alpi e organizzammo una conferenza stampa a Zurigo per spiegare la necessità di un ulteriore investimento per adeguarci ai quattro metri di altezza. Due consiglieri nazionali presentarono una mozione nel giro di due mesi e il parlamento si espresse a favore dei quattro metri.
I lavori di adeguamento termineranno nel 2020: forse non scenderemo mai a 650’000 passaggi, ma saremo almeno in possesso degli strumenti per provarci.
La consigliera federale Doris Leuthard è stata determinante nello scioglimento dell’annosa empasse creatasi fra Svizzera e Italia, dimostrando sensibilità verso il tema del trasferimento. Dall’altra parte però ha fatto anche un’importante campagna politica per il raddoppio del Gottardo. Hupac non l’ha percepita come una contraddizione?
Io il raddoppio lo vedo come una questione di sicurezza. Esso non minaccia il trasferimento per la semplice ragione che la ferrovia è ormai un elemento stabile nel mix logistico delle imprese. Se diamo il via libera al traffico tra Göschenen e Airolo, lo ritroveremo tra Chiasso e Melide e credo che politicamente questo sia impossibile. La legge prevede una sola corsia per ogni direzione, se si intende cambiare occorre una nuova votazione. Noi non temiamo il raddoppio del Gottardo, anche perché statisticamente negli ultimi anni siamo cresciuti, mentre l’attrattività della strada è in costante calo. Vi è inoltre un altro problema da non sottovalutare legato al trasporto su strada: in Europa mancano circa 220’000 camionisti. Ogni anno ne vanno in pensione circa 80’000, ma a sostituirli ce ne sono al massimo 20’000. Quello del camionista non è più un lavoro così interessante poiché gli autisti perdono più tempo in coda che in viaggio.
Personalmente quali sono le sue sfide attuali, Beni Kunz?
In azienda siamo nel bel mezzo di un cambiamento generazionale, in agosto lascerò Hupac Intermodal, pur restando come CEO del Gruppo Hupac. Sarò sostituito dall’attuale direttore di SBB Cargo International, Michail Stahlhut. Il passaggio delle consegne durerà tre anni, come accadde con Allemann, secondo il motto «continuità e accompagnamento». A quel punto è previsto che entrerò a far parte del Consiglio di amministrazione. Il mio hobby sarà ancora quello di seguire i giovani, lavoro che mi entusiasma perché ha un senso importante. Personalmente sono felice di avere fatto qualcosa per l’ambiente e per le prossime generazioni.