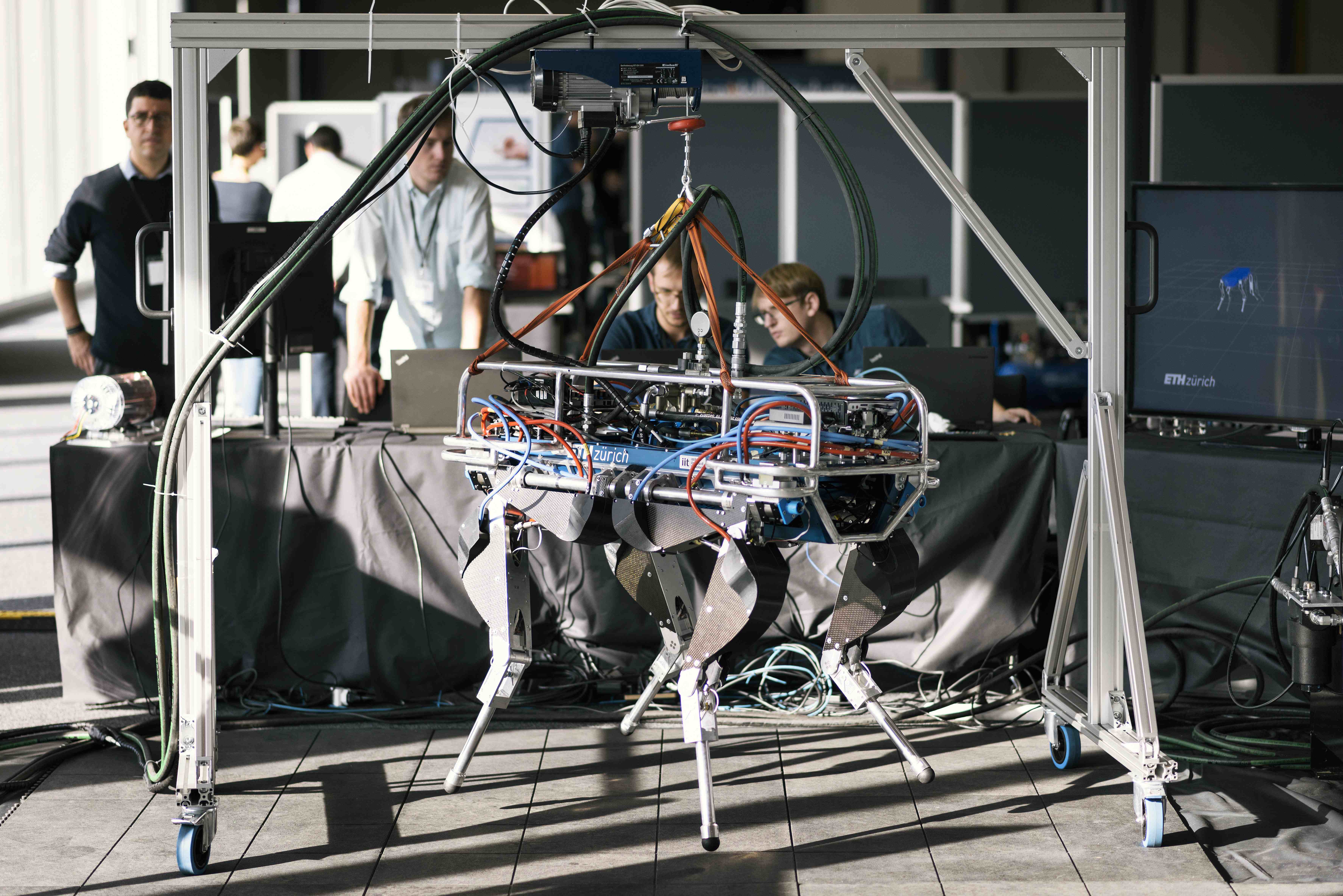I progressi della tecnica, nel mondo del lavoro, si scontrano talvolta con una mano d’opera non sufficientemente preparata ad accogliere le novità. In un mondo che promette di intensificare questa evoluzione, il problema antico della sostituzione del lavoro dell’uomo con quello delle macchine è sempre più d’attualità. Siamo ormai alla vigilia del tempo in cui i robot sostituiranno la quasi totalità del lavoro manuale, o magari in cui l’intelligenza artificiale sostituirà buona parte di quella dell’uomo.
Se consideriamo i progressi realizzati negli ultimi 50 anni, vediamo che anche in Svizzera il trasferimento dal lavoro dell’uomo verso quello delle macchine è stato costante. Se nel 1850 ancora quasi il 60% delle persone attive lavorava nel settore agricolo, questa percentuale è scesa oggi al 3%. Per contro, la percentuale di persone attive nel settore dei servizi, che era allora del 10%, è oggi salita al 75% circa. Durante un secolo anche l’industria ha costantemente aumentato il numero di addetti, ma dal 1960 il numero di occupati nel settore è sceso da quasi 50 al 20% circa.
È quello che gli economisti chiamano evoluzione strutturale, aggiungendo che essa continuerà e si è già guadagnata l’appellativo di «rivoluzione digitale». La Confederazione ha pubblicato in proposito un rapporto interno e tre studi esterni. Questi studi constatano un trasferimento del lavoro dell’uomo alla macchina negli ultimi 20 anni. Nel frattempo, sono aumentate le professioni che richiedono prestazioni elevate, mentre sono diminuite le professioni con esigenze medie. È rimasta invece stabile la percentuale di professioni con esigenze basse (vedi anche la rubrica di Angelo Rossi, ndr).
Finora la formazione in Svizzera ha saputo reagire bene all’aumento delle esigenze. La disoccupazione (epurata delle oscillazioni congiunturali) è rimasta relativamente stabile a un livello basso e la discrepanza fra i profili richiesti per i posti liberi e le competenze di coloro che cercano un posto di lavoro, secondo gli ultimi rapporti, non è aumentata. Su un piano generale, si può vedere che il grado di occupazione negli ultimi 20 anni è sensibilmente aumentato, mentre la distribuzione dei redditi nella popolazione è rimasta stabile. Anche i rapporti di lavoro «precari», cioè il lavoro su chiamata o a tempo determinato, dal 2010 varia fra il 2,2 e il 2,5% degli occupati.
Secondo gli studi di riferimento, la «digitalizzazione» nei prossimi decenni potrebbe provocare la diminuzione del 10% dei posti di lavoro attuali, ma nel contempo creare nuovi posti di lavoro, come indicano i cambiamenti strutturali avvenuti in passato. Secondo un’indagine recente, tra il 2010 e il 2015, in media annuale, tra il 10 e il 15% dei lavoratori hanno cambiato il settore in cui lavorano, mentre tra il 7 e il 10% hanno cambiato professione.
Oggi la domanda si è fatta più intensa per posizioni nella professione come quelle di personale dirigente, di economisti, di specialisti in informatica e nel settore della comunicazione, ma anche nel settore della salute per il personale di cura. È invece diminuita la domanda per il personale generico d’ufficio, per montatori e alcune specialità particolari. In base al profilo delle attività, dal 1926 sono andati persi circa 250’000 posti di lavoro nelle attività caratterizzate dalla «routine». Queste attività sono state trasferite su macchine, oppure all’estero. Per contro, l’economia ha creato circa 900’000 posti di lavoro in attività non di «routine», soprattutto in attività con elevate competenze sociali o analitiche. Inoltre i posti di lavoro perdono attrattività nella produzione, mentre ne guadagnano nella tecnica e nei servizi.
Uno degli studi ha allestito una lista di competenze che diventano sempre più importanti: quelle affini all’informatica, flessibili, di consulenza alla clientela, adatte al lavoro di squadra, all’analisi di dati, alla creatività e alla comunicazione. Non siamo però al punto in cui le conoscenze di ordine generale devono lasciare il posto a quelle specifiche della professione. Si conferma, infatti, che queste ultime vengono acquisite soprattutto in azienda.
Il sistema di formazione duale in Svizzera si rivela ben preparato per far fronte alla sfida della «digitalizzazione». Anche secondo i datori di lavoro non sono necessari grandi cambiamenti nel sistema di formazione. È però evidente che la formazione continua e l’aggiornamento delle conoscenze diventano sempre più importanti. Le statistiche dimostrano che la quota dei lavoratori con una formazione terziaria (Università, scuola universitaria professionale superiore, perfezionamento) dal 1966 è quasi raddoppiata, salendo dal 22 al 41%. Già oggi, per esempio, il 90% circa dei diplomati di una scuola per apprendisti di commercio segue corsi di perfezionamento. Lo stesso Consiglio federale ha deciso di stanziare maggiori fondi sia per il miglioramento delle conoscenze di base, sia per il perfezionamento, tenendo conto che la «digitalizzazione» è ormai di casa in tutte le professioni.