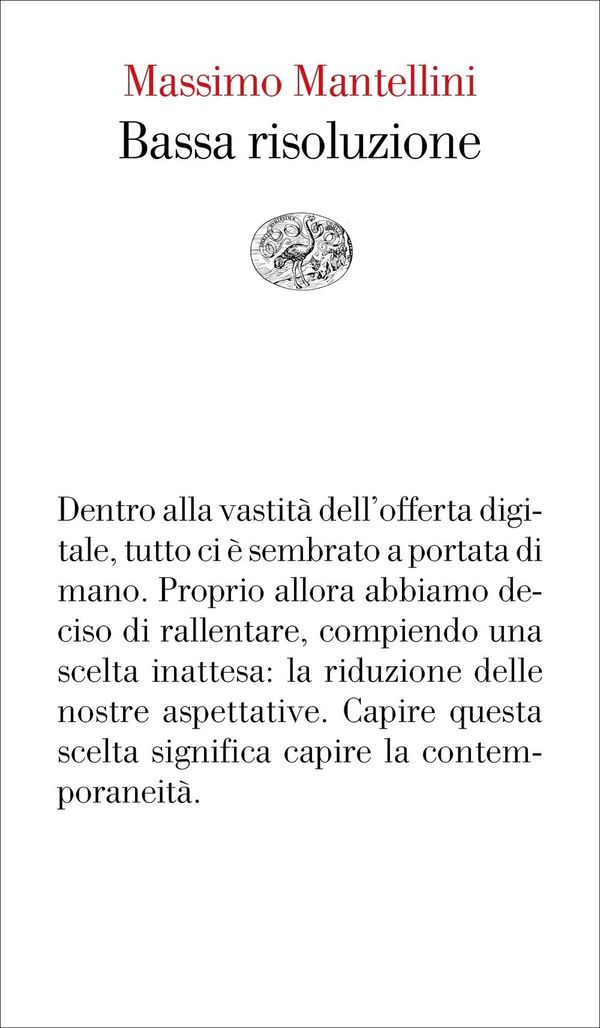Esperto di cultura digitale, blogger della prima ora, con un seguito di quarantacinquemila follower su Twitter (@mante), Massimo Mantellini è l’autore di Bassa risoluzione (Einaudi). Nel saggio mette in luce come la tecnologia tenda a farci scegliere, tra le tante opzioni, la più semplice e la meno approfondita. Un’attitudine alla «superficie» che pervade diversi aspetti della nostra quotidianità.
Mantellini, il suo libro si intitola Bassa risoluzione. Che cosa intende esattamente con questa definizione?
Il titolo del libro riassume un’ipotesi: quella secondo la quale, negli ampi processi di innovazione legati a Internet, sia possibile riconoscere scelte sociali di adattamento caratterizzate dalla riduzione di alcune nostre aspettative. Accade in molti contesti differenti. Nella musica per esempio: oggi disponiamo di tutte le canzoni del mondo a un click di distanza, eppure spesso scegliamo di ascoltarle con una qualità audio minore rispetto a quella degli impianti ad alta fedeltà di qualche decennio fa. Oppure nella fotografia: da quando scattiamo con i cellulari produciamo immagini di qualità inferiore rispetto a quella delle normali macchine fotografiche, ma in numero molto maggiore. Foto che non stamperemo mai e che potremo condividere in un istante. Insomma, nel momento in cui le potenzialità legate alla tecnologia sono diventate amplissime, abbiamo adottato in massa un meccanismo di riduzione e abbiamo mutato le nostre priorità.
Secondo lei, Internet ha portato a un abbassamento generale del livello culturale?
È una domanda complessa. Internet ha ampliato moltissimo l’offerta culturale: mai come oggi abbiamo avuto un così ampio accesso alla conoscenza. Non credo che tutto questo possa avere effetti negativi generali. Non mi fido della frase che sento ripetere spesso per cui «troppa informazione sia uguale a nessuna informazione». Andrà inoltre considerato, prima di abbandonarci a giudizi troppo severi, che viviamo un momento di transizione e che la nostra abilità nel gestire gli strumenti digitali è attualmente ancora elementare. Siamo dei bimbi che stanno imparando.
Nel suo libro descrive una tendenza, più accentuata nei più giovani, di essere «a bassa risoluzione». Si tratta di una propensione generazionale oppure il discorso è più articolato?
Siamo stati investiti un po’ tutti dalla trasformazione digitale. C’è un filo comune che ci unisce: è accaduto che a una maggior complessità abbiamo reagito con risposte apparentemente semplificatorie. Per poi accorgerci che, spesso, quelle scelte tanto superficiali non sono. Torno all’esempio delle foto: una volta stampavamo le immagini per conservarle negli album di famiglia e le mostravamo a poche persone. Adesso abbiamo la possibilità di condividere con chiunque le nostre memorie digitali. Quindi è vero, è cambiato il modo in cui usiamo le fotografie, ma non è necessariamente una mutazione negativa. Per quanto riguarda la questione generazionale, certamente esiste una fascia di età più vicina agli strumenti digitali. Oggi i ragazzi hanno una quota di adozione della tecnologia molto superiore rispetto ai più anziani. Se consideriamo l’ambito culturale nel suo complesso, notiamo che qualcosa è cambiato rispetto al passato: c’è una richiesta molto vasta di «superficie», non voglio per forza dire di superficialità, di modelli con i quali sia facile riconoscersi. Siamo di fronte a uno spostamento di valore, a una complessità strutturale che non riusciamo ancora a comprendere a pieno.
Si guarda spesso con sospetto e sdegno ai più giovani che trascorrono molto del loro tempo su Internet, «isolati», che «non vanno più in strada a giocare», come si faceva una volta. Lei suggerisce che non dovremmo chiamarli «nativi digitali» e che bisognerebbe essere capaci di uno sguardo complesso per capire la realtà in cui i ragazzi e le ragazze di oggi sono immersi. Può darci qualche indicazione in merito?
I «nativi digitali» non esistono, sono una banalizzazione che è di ostacolo alla crescita della cultura digitale fra i più giovani. L’espressione «nativi digitali» più che dei nostri figli parla di noi e di quello che non sappiamo fare. Danah Boyd, studiosa americana di tecnologia e social media, spiega molto bene nei suoi scritti che non possiamo applicare le nostre categorie di adulti per capire i ragazzi. Secondo Boyd, i ragazzi non si sono innamorati improvvisamente dei social network. Semplicemente i luoghi digitali sono stati a un certo punto gli unici disponibili nei quali sviluppare l’autonomia e la privacy che tutti gli adolescenti cercano, le stesse che le generazioni precedenti trovavano nell’incontrarsi al parco con gli amici. Nessun ragazzino va più a giocare in strada oggi, perché ci sono le auto, il rumore, l’inquinamento, e semplicemente il tempo libero è organizzato in maniera diversa. Se dovessi scegliere, alla mia generazione cresciuta davanti alla televisione io preferirei quella di mia figlia che ha un’intensa vita di relazione dentro lo schermo del suo smartphone. Anche se questo non significa che non ci siano effetti negativi: ogni giorno cerco di trascinarla fuori a fare una passeggiata.
In rete ci sembra di essere liberi, ma il rischio, secondo alcune interpretazioni, è di finire nella bolla informativa perché, attraverso gli algoritmi di personalizzazione dei motori di ricerca, non veniamo esposti a informazioni lontane dai nostri gusti e punti di vista. È d’accordo con questa interpretazione?
Negli ultimi anni abbiamo creduto ad alcuni miti dell’universo digitale: alla potenza degli algoritmi, al dominio assoluto dei bias di conferma o delle bolle informative che ci rendono polarizzati e circondati da persone che la pensano come noi. Uso la parola «miti» perché proprio in questi mesi stanno uscendo alcuni interessanti studi scientifici, l’ultimo ad esempio dell’Università di Oxford di qualche giorno fa, che suggeriscono l’esatto contrario. Secondo queste analisi le bolle informative non sono poi così opprimenti e mai come oggi abbiamo accesso a fonti e punti di vista lontani dai nostri. Internet del resto era nata per questo. Il punto di svolta resta quello della curiosità individuale: i nostri orizzonti in rete dipendono da noi, esattamente come nella cosiddetta vita reale.