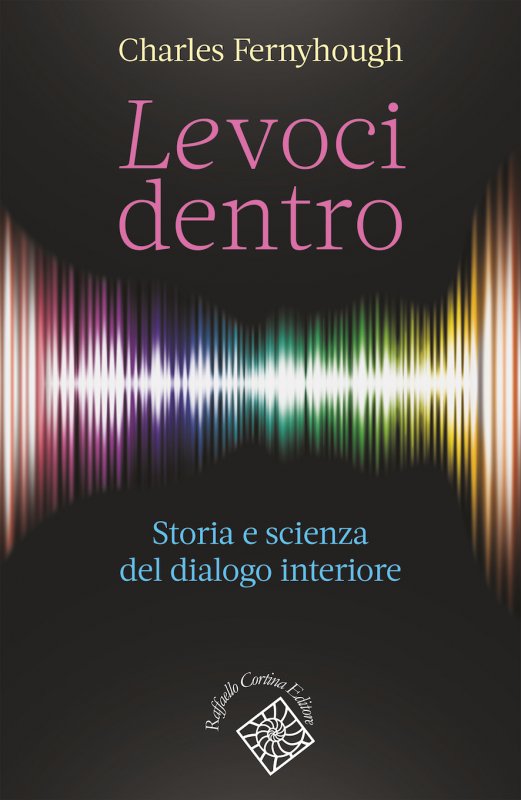Pressoché perfetta, «River» è una miniserie televisiva prodotta nel 2014 dalla BBC. Attore principale è lo svedese Stellan Skarsgård nel ruolo dell’investigatore John River. Fin dalle prime scene lo si vede lavorare in coppia con la collega Jackie «Stevie» Stevenson, che siamo persuasi esistere per quasi tutto l’intero primo episodio, fintantoché, lei girandosi di fronte alla camera, ne vediamo la nuca sfracellata. A questo punto ci rendiamo conto che River s’intratteneva con l’allucinazione di una collega defunta.
Siccome soffre di un profondo turbamento causatogli dalla morte della collega, River ha l’obbligo di recarsi con regolarità dalla psichiatra consulente della polizia e, nel corso delle sedute, lascia emergere la sua storia di «ascoltatore di voci». Nella finzione filmica, le voci che River sente hanno un corrispettivo allucinatorio nella fisionomia delle persone cui esse appartengono: tutte persone defunte che lo aiutano ad interpretare le complesse situazioni nelle quali s’imbatte; ma per la psichiatra quello di River è il caso di un «uditore di voci» e lo incoraggia a raggiungere, a Londra, un gruppo di persone anch’esse uditrici di voci. L’esistenza di simili gruppi non è una finzione e il loro ruolo è studiato da uno dei ricercatori più autorevoli tra quanti studiano l’esperienza di chi sente voci: Charles Fernyhough. Formatosi come psicologo dello sviluppo, Fernyhough insegna Psicologia alla Durham University e dirige «Hearing the Voice», un progetto di ricerca sulle voci interiori che gli ha consentito di accedere a risultati sperimentali di grande interesse condotti facendo ricorso a tecniche di Neuroimaging funzionale. Raccogliendo i risultati delle sue ricerche sul campo, delle sue osservazioni sperimentali ed integrando queste nozioni con la ricerca storica, Fernyhough ha scritto una storia del dialogo interiore intitolata Le voci dentro.
In una intervista dedicata al suo personaggio, l’attore Stellan Skarsgård ebbe a dire che, dal punto di vista della verosimiglianza con quanto accade nella realtà, John River è poco realistico perché, di solito, chi sente le voci essendo schizofrenico, è privo di quell’empatia che, viceversa, caratterizza il detective protagonista della serie tv. In realtà, spiega Fernyhough, la questione è un po’ più complessa perché chi «sente le voci» compie un tipo di esperienza distribuita lungo uno spettro di variabilità molto esteso. Tra i tanti casi descritti da Fernyhough, molti sono soggetti che, pur facendo occasionalmente esperienza di sentire voci, non sono a tal segno psichicamente dissociati da non poter entrare in empatia con altri, sicché il personaggio interpretato da Skarsgård è assai più verosimile di quanto l’attore non ritenga.
Charles Fernyhough è uno psicologo che conosce la sofferenza dei soggetti che sentono voci dentro di loro. Tutti i pazienti da lui esaminati hanno subito traumi, per venire a capo dei quali la loro mente ha messo in atto processi dissociativi. Tuttavia, sebbene l’autore di Le voci dentro sia bene consapevole che l’argomento affrontato nel suo studio è motivo di tanta sofferenza, ciò che si propone di fare, osservato che «altre esperienze comuni a tutti noi implicano una sorta di disconnessione con la realtà, come per esempio sognare o fantasticare», è comprendere per quale ragione nella mente sofferente emergano proprio delle voci.
Per trovare una spiegazione al fatto per cui «le voci» sono una strategia della mente per contenere gli effetti devastanti dei traumi, Fernyhough ritiene fondamentali le osservazioni dello psicologo sovietico Lev Semënovič Vygotskij. Sottolinea con forza la rilevanza che il «dialogismo» svolge nell’opera di Vygotskij: è nel dialogo con gli adulti che apprendiamo il linguaggio ed è proprio conservandone la natura dialogica che lo introiettiamo, facendolo nostro. In virtù di questa natura dialogica i bambini, comunicando con sé stessi, usano il linguaggio con funzione autoregolativa (per esempio dicendosi come dovranno sistemare i pezzi di Lego), mentre lo sportivo adulto dialogherà anch’egli con sé stesso per indirizzare la sua attenzione verso l’esecuzione di un particolare gesto atletico.
L’esempio dello sportivo, estensibile alla nostra vita quotidiana, permette a Fernyhough di rilevare che ognuno di noi sente la propria voce interiore orientarlo in un modo o nell’altro, e che questa voce, a volte, può essere anche in competizione con altre voci portatrici di prospettive diverse. Ciò accade non perché – se equilibrati – abbiamo più personalità, ma perché la natura del linguaggio è fondamentalmente dialogica, e il nostro «io» è una sorta di centro di gravità di una narrazione ininterrotta, dove le voci s’intrecciano in una polifonia che ricordano le pagine dello scrittore José Saramago. Fernyhough ipotizza che queste voci sentite dentro da chi soffre sono una sorta di «errore di attribuzione»: il soggetto, cioè, assegna a un’entità che non è lui l’enunciazione dei discorsi che lo sopraffanno, ma ammette che «rimane da capire per quale motivo un ricordo traumatico venga percepito come una voce». Nella prospettiva dello psicologo inglese, tra il soggetto sano e il soggetto che soffre non c’è una netta discontinuità perché entrambi sono immersi nel flusso del linguaggio: «i nostri Sé vengono costantemente costruiti e ricostruiti in modi che spesso funzionano bene, ma che spesso collassano»; in quel momento, il dialogo interiore che ci aiuta a prendere le decisioni difficili e ci aiuta a risolvere problemi complessi, è come se prendesse vita propria occupandoci l’intera mente – esperienza che nel suo studio Fernyhough cerca nella vita di filosofi e di mistici, così come di scrittori e pittori, persuaso che il dialogo interiore è quanto meglio ci contraddistingue come specie.