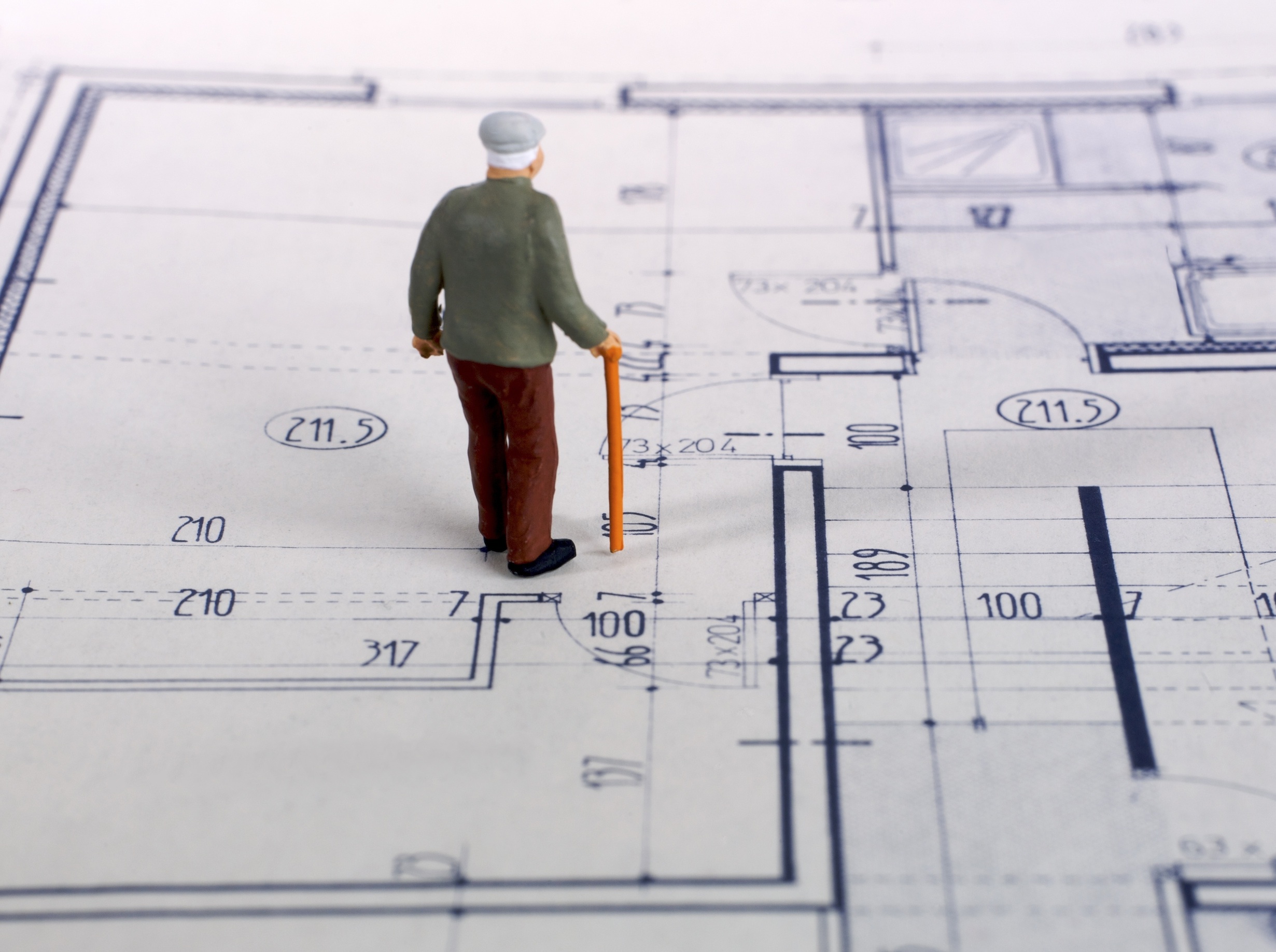Fra la casa con il giardino o il grande appartamento familiare e la casa per anziani esistono soluzioni abitative alternative in risposta ai nuovi bisogni di una crescente popolazione anziana? Da qualche tempo il mercato sta rispondendo in modo affermativo. I progetti di abitazioni a misura di anziano, le residenze intergenerazionali, l’integrazione di nuovi servizi nei complessi residenziali sono in aumento. Enti e associazioni si chinano sulla questione nell’ambito di uno sviluppo insediativo che, oltre alle tendenze demografiche, deve guardare alle esigenze sociali, ambientali ed economiche.
Nella Svizzera francese sono in corso diverse sperimentazioni nel tentativo di capire come soddisfare necessità di fatto assai eterogenee. Per una valutazione della situazione ticinese, soprattutto dal punto di vista dei diretti interessati, vale a dire degli anziani, ci siamo rivolti a Stefano Cavalli, responsabile del Centro competenze anziani (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale) della SUPSI.
Al momento non esistono ricerche mirate su questo aspetto della vita degli anziani ticinesi. Stefano Cavalli è però l’autore – con i colleghi Michele Egloff e Barbara Masotti e con Francesco Giudici dell’Ufficio di Statistica del Canton Ticino – di un approfondito studio generale pubblicato due anni or sono. «Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino» fornisce dati significativi basati su un campione rappresentativo composto da 700 persone di età superiore ai 65 anni. Dalla ricerca emerge che il fenomeno degli anziani residenti in strutture appositamente concepite per la loro fascia d’età è ancora marginale a livello numerico.
Spiega al riguardo Stefano Cavalli: «La ricerca evidenzia che la maggior parte delle persone anziane, anche dei grandi anziani, continua a vivere a casa propria, mentre una minoranza, meno del 20% degli ultraottantenni, vive in una casa per anziani. Questo grazie a due sostegni fondamentali: la famiglia e i servizi di aiuto a domicilio. Negli ultimi anni si è effettivamente manifestato un interesse per soluzioni abitative intermedie, ma al momento riguarda solo un numero esiguo di anziani e, anche se questo numero tenderà sicuramente a crescere, non credo che diventi maggioritario».
Quali i motivi alla base di questa affermazione? «Gli anziani ci tengono a rimanere a vivere al proprio domicilio, nella casa o nell’appartamento dove hanno costruito la loro storia, al quale sono legati molti ricordi. Con l’invecchiamento lo spazio troppo grande, la mancanza di comodità, le barriere architettoniche rappresentano problemi che, soprattutto chi è proprietario, cerca di risolvere in loco. C’è inoltre da considerare l’aspetto economico. Due terzi dei giovani anziani (65-79 anni) e la metà degli ultraottantenni sono proprietari del loro domicilio, di cui spesso hanno già pagato gran parte dell’ipoteca. Trasferendosi rischiano di ritrovarsi in spazi più ristretti a costi maggiori. Vendere la casa (o l’appartamento) non è sempre la soluzione, perché si vorrebbe poterla lasciare ai figli. Un altro problema legato al trasloco è quello di dover abbandonare il quartiere o il paese, visto che questi nuovi complessi sorgono piuttosto nei centri urbani, perdendo così la rete sociale costruita sull’arco di un lungo periodo, a volte dell’intera vita. Solo l’avvicinamento alla residenza dei figli può agire da stimolo positivo».
La differenza fra la realtà urbana e quella delle valli che caratterizza il canton Ticino è un ulteriore fattore di diversità per quanto riguarda il fabbisogno abitativo degli anziani. Nelle valli ci sono più persone che risiedono in abitazioni meno confortevoli e difficilmente accessibili per un anziano fragile, ma il legame con il territorio è generalmente più forte. In queste zone progetti abitativi innovativi per gli anziani potrebbero favorire la permanenza in valle, ma non sono attrattivi per gli investitori il cui interesse economico è legato ai grandi numeri.
Il responsabile del Centro competenze anziani, pur valutando positivamente le iniziative pubbliche e private in corso, evidenzia inoltre che gli anziani più bisognosi di questa tipologia di appartamenti non sono tanto quelli ancora autosufficienti quanto i più fragili, con la salute in parte già compromessa. Attualmente il Ticino, come la Svizzera francese, è caratterizzato da un’incisiva politica a favore dei servizi di aiuto a domicilio per ritardare la presa a carico in istituto. Il numero di anziani residenti a casa propria e con bisogni importanti sta aumentando. «Mi riferisco, ad esempio, a coloro che dipendono dall’aiuto di terzi per svolgere i gesti essenziali della vita quotidiana», precisa il ricercatore. «Circa la metà di loro vive a domicilio proprio grazie ai servizi citati e all’aiuto dei familiari. Tutte queste persone presentano dei bisogni maggiori rispetto ai destinatari dei nuovi progetti abitativi per anziani. Un altro esempio è l’aumento delle problematiche di tipo cognitivo nella popolazione che risiede a domicilio. È però vero che lo scopo di queste iniziative è piuttosto quello di motivare i giovani anziani ad anticipare il trasferimento per vivere gli anni futuri in condizioni migliori».
Condizioni definite migliori secondo i criteri oggettivi dei promotori o il parere dei familiari. Le preferenze degli anziani, come riferito, non sono ancora state indagate. Per il ricercatore bisognerebbe quindi capire a quali condizioni sarebbero disposti a lasciare la propria abitazione, quali sarebbero per loro vantaggi e svantaggi e quali le priorità. L’inchiesta dovrebbe coinvolgere dei giovani anziani ma anche coloro che arriveranno all’età della pensione fra 10-15 anni. A breve il Centro competenze anziani si occuperà piuttosto dei grandi anziani, partecipando a uno studio nazionale sui centenari.
Attualmente nel nostro cantone molti progetti e di riflesso la ricerca si concentrano sulla salute, mentre è ancora relativamente poco sviluppato il tema della vulnerabilità relazionale nella quale l’abitazione gioca un ruolo di primo piano. Per il responsabile del Centro competenze anziani questo aspetto è tutt’altro che trascurabile, ma risulta difficile reperire le persone a rischio di isolamento sociale. Se rimanere a casa propria il più a lungo possibile, anche a costo di vivere soli, è la soluzione di gran lunga preferita, l’insorgere di problemi di salute può limitare i contatti sociali ed essere all’origine di un sentimento di solitudine. Non a caso i nuovi progetti residenziali introducono la presenza del custode sociale o di enti già attivi nell’aiuto agli anziani.
Ripensare completamente il modo di vivere nella terza età, prendendo decisioni già nella fase attiva della vita significa modificare in modo assai radicale la visione della stessa. Per certe culture è forse più semplice e in Svizzera alcune realtà sembrano già essere entrate in questa dimensione, come dimostrano anche diversi esempi citati durante un recente seminario organizzato da ASPAN Ticino (Associazione svizzera per la pianificazione del territorio) in collaborazione con l’associazione Generazioni & Sinergie, ideatrice del Pentalogo, una lista di criteri e concetti per abitare bene a tutte le età. L’incontro, svoltosi lo scorso marzo a Bellinzona, ha toccato un ampio spettro di nuove sfide legate al tema dell’abitare, dai nuovi fabbisogni derivanti dall’invecchiamento della popolazione al ruolo della pianificazione del territorio. Significativo il contributo di Dario Spini, professore all’Università di Losanna e direttore del polo di ricerca nazionale LIVES, per il quale le sperimentazioni in corso nei cantoni romandi – come appartamenti per più anziani con spazi privati ed altri in comune o soluzioni modulari per le abitazioni in proprietà – corrispondono alla necessità di disporre anche nell’ambito abitativo di risposte diversificate per soddisfare i bisogni di una popolazione anziana molto eterogenea. Popolazione che proprio in Ticino è in proporzione più numerosa rispetto al resto della Svizzera.