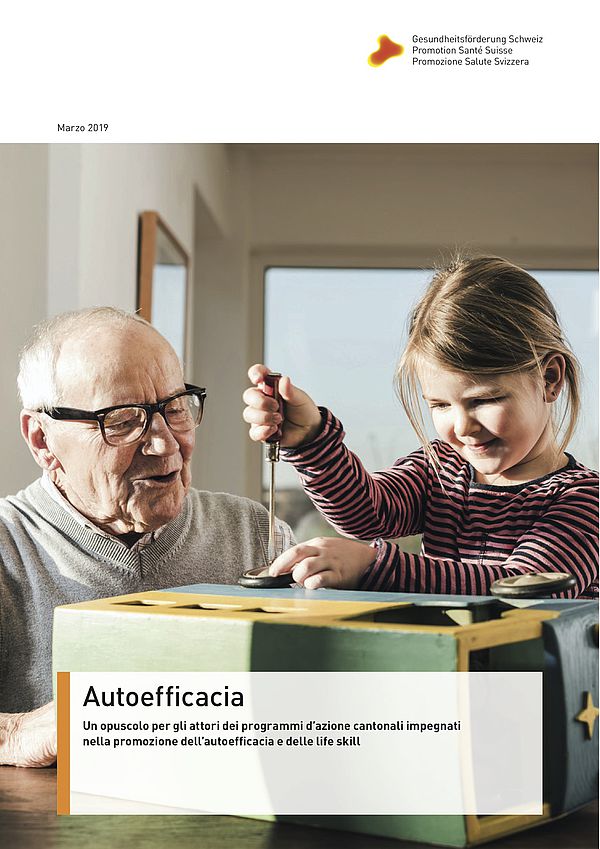Essere sempre sopra i propri figli controllandoli e cercando di soddisfare tutti i loro bisogni o concedere maggiore indipendenza affinché imparino dall’esperienza e quindi anche dai propri errori? I primi sono comunemente definiti genitori-elicottero (da un’espressione inglese coniata dagli autori di un volume pubblicato nel 1990), mentre i principi educativi puntano piuttosto sulla fiducia e l’autonomia. I genitori-elicottero sono quindi in prevalenza connotati negativamente, anche se uno studio pubblicato di recente da due professori di economia statunitensi ne evidenzia l’influsso determinante sulle chance di riuscita dei figli ricollegando questa attitudine al contesto economico della società americana. Per capire quali sono nella nostra realtà i comportamenti prevalenti e come è possibile sfruttarne i rispettivi punti di forza ci siamo rivolti alla pedagogista Martina Flury Figini, coordinatrice del Progetto Genitori del Mendrisiotto e Basso Ceresio con sede a Chiasso.
L’esperienza di questa associazione, a diretto contatto con i genitori di bambini piccoli nell’intento di rafforzarne le competenze educative, dimostra come sia sempre possibile nel corso della vita attivare e sviluppare le proprie risorse, ma anche quanto sia più difficile compierlo nell’età adulta. È infatti durante i primi tre anni, in particolare fino al secondo, che si formano le life skills, ossia le competenze di vita come la percezione di sé, la gestione delle emozioni e la capacità di risolvere i problemi. «L’importanza di queste risorse interne – spiega Martina Flury Figini – non è più ribadita solo dai pedagogisti, bensì riconosciuta anche a livello di salute pubblica a causa del loro impatto sul benessere della persona. Una recente pubblicazione (marzo 2019) di Promozione Salute Svizzera indirizzata agli attori dei programmi cantonali che promuovono queste competenze pone l’accento sull’autoefficacia e su come l’infanzia e l’adolescenza siano fasi cruciali per il suo sviluppo». Nell’opuscolo l’autoefficacia è definita come «la convinzione soggettiva di essere in grado di affrontare con successo determinate situazioni grazie alle proprie competenze» (Brinkmann 2014). Questa aspettativa soggettiva influenza il modo di affrontare le situazioni e il loro esito in una sorta di circolo virtuoso. «L’obiettivo dell’educazione – prosegue la pedagogista – è quello di crescere una persona che da adulta sia in grado di inserirsi nella società operando scelte e assumendo responsabilità. Il percorso che promuove la fiducia, l’autonomia e appunto l’autoefficacia deve iniziare subito. È lungo, laborioso, ricco di esperienze e non privo di cadute dalle quali rialzarsi per proseguire. Cito volentieri al riguardo l’esempio del bambino che impara a camminare. È un’immagine semplice da visualizzare e racchiude tutto il senso di questo concetto. L’esercizio è lungo e ogni bambino si prende il suo tempo raggiungendo l’obiettivo con il proprio stile. Allo stesso modo occorrono anni per prepararsi alle sfide dell’età adulta e il cammino non è il medesimo per tutti. Purtroppo nella nostra società, oltre a perdere il valore del tempo, si tende ad anticipare sempre di più. L’essere umano per costruire e cambiare ha invece bisogno di tempi dilatati».
Ecco perché nasce un certo contrasto fra i concetti chiave dell’educazione e il comportamento dei genitori-elicottero. Questi ultimi partono da un sentimento positivo che ricerca la vita più felice possibile per il loro figlio e che nella nostra società passa dal benessere economico. Questo è particolarmente accentuato nel contesto americano nel quale i professori Matthias Doepke e Fabrizio Zilibotti hanno svolto la loro ricerca sfociata nel volume Love, Money and Parenting: How Economics Explains the Way We Raise Our Kids (Amore, soldi ed educazione: come l’economia spiega il modo nel quale cresciamo i nostri figli). Loro stessi, cresciuti rispettivamente in Germania e in Italia negli anni Settanta, si rendono conto di aver beneficiato di genitori permissivi e quindi di un elevato grado di libertà in un contesto economico nel quale la scelta professionale non implicava in partenza una diseguaglianza nella retribuzione. I genitori-elicottero si sono manifestati nel decennio successivo (il termine è infatti apparso nel 1990) caratterizzato da un ritorno della competizione e della diseguaglianza. Genitori iperpresenti che tendono a sostituirsi ai figli nelle scelte fondamentali, soprattutto in ambito scolastico, sono quindi più efficaci? «Dal punto di vista economico si può anche concordare – risponde Martina Flury Figini – ma le nuove generazioni ci dimostrano ogni giorno che i loro valori sono anche altri».
Sicuramente una madre e un padre presenti, attenti e in grado di spiegare i vantaggi di determinate scelte, rappresentano un sostegno. È però una questione di misura, avverte la pedagogista. Seguire bene i figli non significa infatti soddisfare tutti i loro bisogni, magari prima ancora che si manifestino o sostituirsi a loro nelle decisioni. Martina Flury Figini: «Più che il controllo dall’alto (associato all’immagine dell’elicottero), aiutano gli stimoli legati ad aspettative alte ma realistiche. Il concetto di riferimento è la “zona di sviluppo prossimale” definita dallo psicologo russo Lev Vygotskij negli anni Trenta. All’interno di questa zona il bambino, con l’aiuto degli altri, può aumentare il suo sviluppo (ciò che è in grado di svolgere da solo) e raggiungere nuovi obiettivi, mentre oltre il perimetro di questa zona i problemi da risolvere risultano troppo ambiziosi e il tentativo è destinato a fallire generando un sentimento di frustrazione. È quindi in questa zona che gli stimoli dei genitori possono essere efficaci proprio perché alla portata del figlio».
Di fondamentale importanza risulta sempre essere la relazione che i genitori instaurano con i figli, basata sulla fiducia reciproca e costruita giorno dopo giorno. I genitori restano il punto di riferimento, conclude la pedagogista, anche quando sono contestati, in particolare nella fase adolescenziale. Nei momenti delicati il comportamento dei genitori-elicottero è giustificato, ma se diventa la regola può precludere un sano sviluppo della personalità con ripercussioni che si possono manifestare anche solo dopo tanti anni. Molto meglio, secondo l’esperienza di Martina Flury Figini, riuscire ad alternare i ruoli a dipendenza delle circostanze. Di nuovo come per il bambino che impara a camminare, l’intervento dell’adulto è sporadico, determinato da necessità o pericolo.