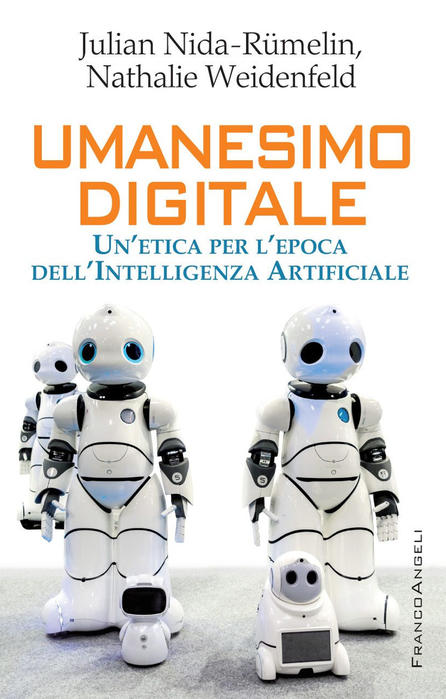Julian Nida-Rümelin, tra i più noti filosofi tedeschi viventi, e Nathalie Weidenfeld, studiosa ed esperta di cinema di fantascienza, hanno scritto Umanesimo digitale, appena pubblicato in italiano da Franco Angeli. Il saggio – ha vinto il Premio Bruno Kreisky nel 2018 come miglior libro politico dell’anno – è una bussola filosofica tascabile per orientarsi nell’era dell’intelligenza artificiale. Nel testo riflessioni teoriche si alternano a citazioni di film distopici e fantascientifici come Matrix, Ex Machina, Blade Runner, Metropolis, Minority Report, 2001: Odissea nello spazio.
Julian Nida-Rümelin e Nathalie Weidenfeld, ci date la vostra definizione di umanesimo digitale?
L’umanesimo digitale che proponiamo è un’utopia, qualcosa a cui tendere.
Innanzitutto, è un modo di pensare che richiede di prendere congedo dal paradigma della macchina. Né la natura nel suo insieme né l’uomo possono essere considerati come delle macchine. Il mondo non è un orologio e l’uomo non è un automa.
In secondo luogo, va considerato che le macchine possono espandere e migliorare la capacità umana sia nell’azione sia nella creatività. Possono essere utilizzate nello sviluppo umano tanto a fin di bene quanto in cattiva fede. Di sicuro non possono sostituire la responsabilità umana, sia quella individuale sia quella culturale e collettiva della società. Paradossalmente tanto la responsabilità individuale quanto quella collettiva vengono amplificate, non diminuite né marginalizzate, dall’utilizzo delle macchine digitali. Le nuove possibilità dell’interazione attraverso le tecniche digitali rappresentano sfide a cui l’essere umano razionale non si può sottrarre delegando le decisioni a sistemi autonomi, siano essi robot umanoidi oppure software capaci di auto-apprendimento.
Perché serve un umanesimo digitale?
Abbiamo bisogno di nuove prospettive complesse dal punto di vista etico e teorico per interpretare il presente e il futuro. Non possiamo pensare di cogliere le implicazioni del reale utilizzando sistemi binari di pensiero. L’umanesimo digitale è favorevole alla tecnologia. Sostiene l’applicazione di tutte le tecniche digitali per il miglioramento della condizione umana e la conservazione dei sistemi ecologici – anche in considerazione degli interessi vitali delle generazioni future. Allo stesso tempo, tuttavia, si oppone nettamente alle tendenze di fuga e di delega per il futuro conferite a uno sviluppo tecnologico inteso come autosufficiente.
Un’utopia pragmatica dell’umanesimo digitale fa proprio il principio di realtà. L’esperienza umana non è l’interpretazione dei dati sensibili, ma si basa su una comprensione di fatti empirici e normativi. Senza intenzioni non si può avere nessuna esperienza genuina, né etica né empirica. Le macchine non hanno intenzionalità. Non imparano nulla, anche se sono in grado di simulare percezione e comportamento.
La diffusione dell’impiego dell’intelligenza artificiale pone una serie di nuove domande. Ve ne faccio qualcuna. I robot pensano davvero? Possono provare sentimenti? Ci ruberanno il lavoro?
L’umanesimo digitale non attribuisce proprietà mentali alla simulazione del comportamento umano. Piuttosto, affina i criteri di riconoscimento della responsabilità umana in considerazione della disponibilità di nuova tecnologia digitale. Secondo questo approccio filosofico, noi esseri umani non possiamo trasferire le nostre scelte alla presunta autonomia delle macchine digitali. L’idea che i computer o i robot abbiano una personalità, o che comunque un giorno la possano acquisire, dovrebbe essere definitivamente messa da parte come una proiezione (in senso psicoanalitico) regressiva. È la ricaduta nell’animismo delle culture dell’Età della pietra. L’attribuzione di un’anima ad alberi, corsi d’acqua e alle sagome delle nuvole può essere paragonata allo stesso meccanismo con cui attribuiamo un’anima ai computer oppure ai robot. Se si ragiona così, non si fa altro che mitigare il peso della solitudine e delle scelte che affligge l’unica specie del pianeta, rappresentata da noi essere umani, capace di trasformazione nell’epoca dell’Antropocene.
L’umanesimo digitale ha una visione ottimista del futuro. Secondo voi non c’è ragione per essere angosciati rispetto alle conseguenze della diffusione della tecnologia. In che modo possiamo evitare gli scenari peggiori?
Crediamo che sia necessario che gli esseri umani abbiano il controllo delle infrastrutture, delle comunicazioni e delle interazioni digitali. Se ciò non è possibile su scala mondiale, queste infrastrutture devono essere garantite mediante trattati multilaterali, preferibilmente sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Non si può accettare che gli interessi commerciali di Google, Facebook e delle altre grandi aziende del settore blocchino lo sviluppo di infrastrutture neutrali di comunicazione e di interazione digitali. L’immenso aumento delle possibilità di informarsi con uno sforzo minimo e in modo affidabile, le diverse opzioni di formare comunità e perseguire obiettivi comuni, le nuove opportunità di comunicazione attraverso i confini culturali potrebbero essere condizioni ideali per uno sviluppo umano e democratico in tutte le regioni del mondo. Potrebbero dare un contributo significativo all’autodeterminazione individuale e politica e realizzare l’ideale illuministico di una cittadinanza informata e responsabile, sia a livello nazionale sia internazionale. L’educazione individuale e collettiva dovrà focalizzarsi sul giudizio indipendente e sul potenziamento delle capacità decisionali.
Precisazione
L’intervista è stata rivista e modificata dalla giornalista per esigenze di chiarezza testuale.