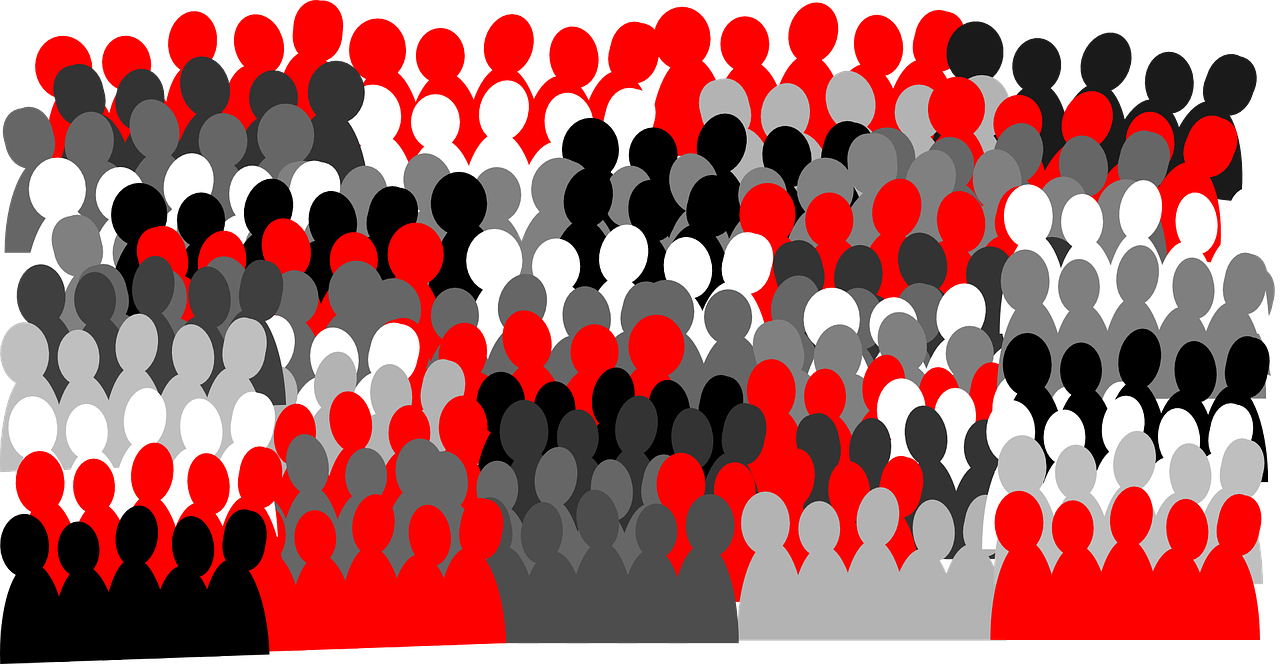Ci sono espressioni che usiamo tutti i giorni ma che non definiamo mai, come se il loro significato fosse talmente ovvio da non richiedere chiarimenti. L’espressione «opinione pubblica» è una di queste e, magari con parole diverse, è presente nel lessico di tutti i tempi. È stato per primo Parmenide a parlare di doxa ed episteme dove il primo termine designava le opinioni e i giudizi immediati dei membri di una comunità e il secondo faceva invece riferimento alle conoscenze certe della scienza. L’avvento della stampa a caratteri mobili nel XV secolo ha ovviamente giocato un ruolo decisivo, assieme ai vari rivolgimenti sociali e politici dei secoli successivi, nell’assegnare alle valutazioni del popolo notevole importanza nella gestione del potere, soprattutto nei regimi democratici. Nella percezione corrente l’immagine dell’opinione pubblica presenta però una nuova peculiarità ossia il fatto che essa è divenuta oggetto di indagini speciali attraverso tecniche anche molto raffinate. Da queste ricerche emerge peraltro una realtà che, per certi versi, non era mai stata intuita o, comunque, resa esplicita. Si tratta del carattere composito dell’opinione pubblica, cioè della presenza di «classi» di opinione diverse fra loro che, in molti casi, si distribuiscono in analogia alla curva di Gauss, detta anche «a campana».
Alcuni studiosi definiscono l’opinione pubblica come l’opinione della maggioranza dei cittadini, ma questa pare essere una semplificazione eccessiva per almeno due motivi fondamentali. Innanzitutto, pressoché sempre, sono le minoranze a generare mutamenti in fatto di idee, cultura, arte, scienza e tecnologia e la loro diffusione giunge alla maggioranza dei membri di una comunità con inevitabile ritardo, cioè quando altre minoranze stanno già incubando ulteriori innovazioni. L’opinione dei più, perciò, è portatrice di valutazioni e giudizi perennemente legati a fattori che erano in essere prima del suo formarsi. Negli ultimi decenni, per esempio, l’opinione della maggioranza è stata di volta in volta perplessa o preoccupata circa l’avvento dei computer, poi dei telefoni cellulari, poi di Internet, poi dei robot, finendo però, dopo qualche ritardo, per coagularsi attorno a queste innovazioni determinandone il successo. Rilevare e analizzare solo l’opinione della maggioranza in molti casi è quindi fuorviante mentre non andrebbe mai trascurata l’opinione di classi di opinione minoritarie.
In secondo luogo, soprattutto in fatto di posizioni politiche, una maggioranza, diciamo così, «assoluta» esiste solo formalmente nei regimi totalitari poiché in tutti i paesi del mondo occidentale vi sono almeno due, ma spesso il numero è maggiore, aree di opinione che coincidono con i classici partiti di destra e sinistra. Negli stessi referendum le cose stanno in questo modo.
Dunque un’opinione pubblica come entità unitaria non esiste o, per meglio dire, essa si manifesta unitariamente solo nei casi in cui le valutazioni riguardano eventi sui quali il cosiddetto «sentire comune» è davvero notevole. Per esempio, di fronte ad un devastante atto di violenza lo sdegno coinvolge l’intera popolazione. Tuttavia, se si sale anche solo un gradino e si passa alle opinioni sulle misure preventive da prendere o circa le sanzioni da attuare nei confronti dei colpevoli, la distribuzione statistica riaffiora pienamente. Così, mentre la maggior parte delle valutazioni si disporranno attorno ad una posizione media, da una parte della curva appariranno le valutazioni meno dure e dall’altra quelle più repressive. Ciò significa che l’opinione pubblica è effettivamente compatta solo quando di mezzo vi sono valori e principi che, per natura o per evoluzione storica, fanno ormai parte stabile delle nostre premesse etiche e culturali. Al contrario, quando si ha a che fare con eventi, personaggi o proposte politiche le opinioni rappresentano la conclusione di veri e propri processi mentali, o ragionamenti, di profondità variabile, realizzati sulla base di fattori individuali come le proprie convinzioni ideali, le proprie esperienze, i propri sentimenti, le proprie simpatie. Quel che ne risulta è, appunto, una distribuzione per classi di orientamento che evidenzia sempre un ventaglio più o meno ampio di posizioni contribuendo ad assegnare al concetto di opinione pubblica una vistosa inconsistenza poiché, di fatto, ci si trova di fronte a più opinioni pubbliche. A ben vedere, dunque, espressioni adatte agli stati psicologici individuali come «l’opinione pubblica è disorientata» oppure «l’opinione pubblica è turbata» sono del tutto prive di senso soprattutto se ci si trova di fronte ad eventi, come una imprevista crisi economica o una serie improvvisa di attentati terroristici, sui quali manchino affidabili e accertate versioni ufficiali e nei riguardi dei quali, quindi, le ipotesi sono necessariamente molteplici. È in queste circostanze che, in passato come oggi, nascono semmai le dicerie che altro non sono se non la risposta collettiva, creduta da molti e contrastata da altri, ad una domanda assillante ma senza risposta certa. Le dicerie sono molto pericolose perché tendono ad auto-realizzare il proprio contenuto e soprattutto le proprie conseguenze.
In tutti i suoi sviluppi, infine, l’opinione pubblica mostra una intrinseca tendenza a svolgersi secondo due fasi, messe in luce negli anni 50 da Paul Lazarsfeld e Elihu Katz. Secondo questa teoria, divenuta ormai un classico della sociologia della comunicazione, in una prima fase i membri di una comunità vengono a conoscenza – magari grazie ai mass media – di qualche novità ma sarà solo l’approvazione o la disapprovazione di qualche personaggio importante della stessa comunità a decretarne il successo o l’insuccesso. L’opinione pubblica, dunque, si ripiega sull’opinione privata, di singoli uomini o gruppi. Ma il processo è solo raramente in grado di agglomerare l’opinione di tutti e anzi, come abbiamo notato sopra, in varie occasioni più opinion leader conquistano il consenso di più gruppi, diversi fa loro. In definitiva, l’opinione pubblica, soprattutto in società nelle quali la comunicazione è intensa e pervasiva, è un arcipelago costituito da numerose isole e da numerosi maître à penser, più o meno meritevoli di questo ruolo ma, di fatto, capaci di influenzare altri uomini. È una realtà umana universale, nel tempo e nello spazio, senza la quale non solo l’opinione pubblica non esisterebbe ma la stessa società perderebbe qualsiasi significato.