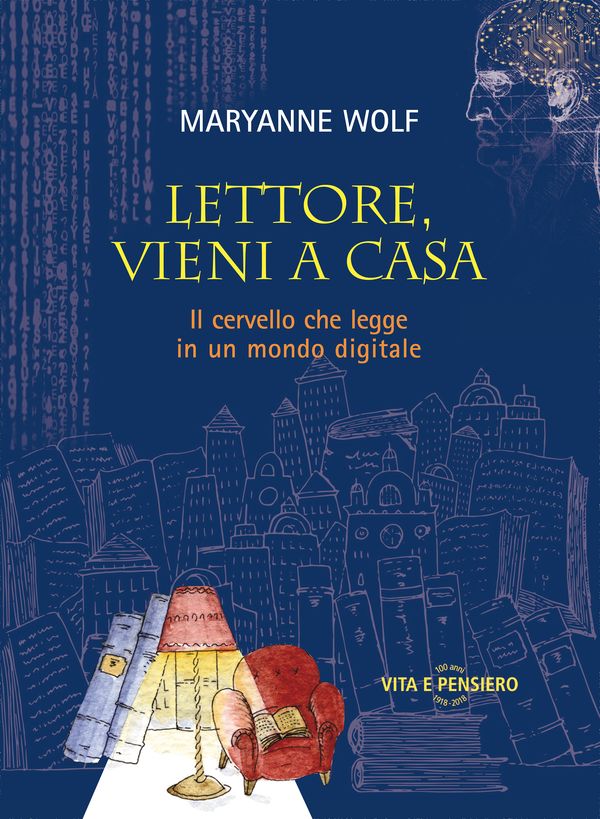Internet ci sta togliendo la capacità di perderci nelle pagine dei romanzi e dei saggi, di venire rapiti per ore dai mondi di carta. Chiunque ami leggere sa che qualcosa è cambiato con la diffusione del digitale: è sempre più difficile immergersi in un testo senza lasciarsi distrarre. A causa delle continue notifiche dello smartphone oppure dell’abitudine a controllarlo, e delle giornate trascorse per lavoro davanti al computer, è diventato faticoso concentrarsi, entrando nella «lettura profonda». Così la definisce Maryanne Wolf, una delle più note neuroscienziate cognitiviste, che insegna alla University of California di Los Angeles (Ucla). Nel suo ultimo libro, Lettore, vieni a casa. Il cervello che legge in un mondo digitale (Vita e Pensiero), appena tradotto in italiano, analizza come i nostri meccanismi cerebrali si stiano indebolendo e le conseguenze di questa trasformazione sulle nostre vite e sulla società.
Professoressa Wolf, può spiegarci nel dettaglio che cos’è la lettura profonda?
La lettura profonda è composta da una serie di processi mentali piuttosto sofisticati. Questi meccanismi non sono solo importanti da un punto di vista individuale, ma anche collettivo, perché permettono di sviluppare l’empatia, danno cioè la possibilità di avere una prospettiva, di allenare la comprensione che abbiamo della teoria mentale degli altri: ci permettono di vedere come e cosa pensano le persone. La combinazione dei processi cognitivi che avvengono grazie alla lettura profonda, ci consente di andare al di là della saggezza dell’autore che leggiamo e di svilupparne una nostra. Creiamo così un pensiero nuovo che è alla base della conoscenza.
Perché la lettura profonda è importante?
La lettura profonda non ci rende semplicemente degli elaboratori di informazioni, ma esseri umani che arrivano alla conoscenza, in grado di utilizzarla per prendere decisioni, per stabilire quale potrà essere la persona migliore che è in noi. La lettura profonda è un ponte che collega le informazioni, è un cortocircuito in un certo senso, qualcosa di assolutamente fondamentale per sviluppare il sapere. L’elaborazione cumulativa del cervello che legge ci consente di andare oltre a ciò che sappiamo già e oltre al testo: dentro di noi avviene un processo nuovo, modifichiamo la conoscenza per trasformarla in qualcosa di più vicino alla saggezza, e questo ci può aiutare ad essere persone virtuose. Dal punto di vista culturale, la lettura profonda è una delle più importanti abilità acquisite dagli esseri umani, a livello individuale e sociale, perché contribuisce alla democrazia: consente a tutti di avere prospettiva, di provare empatia nei confronti degli altri, di aspirare all’analisi critica e ad un pensiero diverso e inedito.
Come sta cambiando con la tecnologia il nostro modo di leggere?
I nuovi studi dimostrano che stiamo perdendo i nostri processi più sofisticati di lettura a causa della tecnologia. In teoria, potremmo attivare la lettura profonda anche davanti a uno schermo, ma in realtà non lo facciamo. Le ragioni sono due: lo schermo ci spinge alla velocità e a saltare da una parte all’altra del testo. Pensiamo, così facendo, di filtrare le informazioni per risparmiare tempo e invece non riusciamo a concentrarci nemmeno sui punti che abbiamo scelto. A lungo andare, questa abitudine si rivela dannosa.
Quando perdiamo la capacità della lettura profonda che cosa succede?
Questa perdita riguarda adulti e bambini: non siamo più in grado di vedere la bellezza nella cultura, viene meno il consolidamento nella nostra memoria, avviene un grave danno per la democrazia. Se disimpariamo l’empatia e le basi per lo scambio di prospettive alternative ci impoveriamo intellettualmente e assumiamo una costruzione molto più ristretta di ciò che siamo.
Se siamo lettori profondi di romanzi o saggi e ci rendiamo conto che stiamo perdendo questa capacità, cosa possiamo fare per recuperarla?
Prima di tutto, due ore prima di andare a letto non bisogna stare davanti allo schermo, grande o piccolo che sia. In secondo luogo, se sentiamo di perdere la capacità alla lettura profonda, dobbiamo prendere la cosa seriamente, dandoci delle regole. La regola più importante è leggere profondamente ogni giorno per almeno venti minuti, anche di più, ma questo tempo può essere già sufficiente. Non dobbiamo permetterci deroghe. Io ad esempio mi sveglio la mattina, medito e poi leggo, per venti minuti, teologia, filosofia, qualsiasi cosa mi richieda una forte concentrazione e sia sfidante per la mia mente. Non è importante quando lo si fa, ma farlo, perché la lettura profonda deve essere una disciplina: dobbiamo esercitare i circuiti cerebrali deputati a questa attività.
Le nuove generazioni, abituate fin dall’infanzia allo schermo, rischiano di non avere nemmeno idea di che cosa sia la lettura profonda. Come scrive nel suo ultimo libro, leggere non è qualcosa di naturale, ma una capacità che va imparata e coltivata. Che cosa si può fare per correre ai ripari?
Nel mio ultimo libro, nei capitoli sei, sette e otto, ho descritto dettagliatamente la mia proposta per salvaguardare la capacità di leggere. Ho analizzato, da zero a dieci, a cosa servono le letture su carta e su schermo, e ciò che deve essere gestito con la codifica e con l’elaborazione dei dati. Ci sono tante strategie. Nelle scuole, le letture su carta e su schermo possono essere combinate, ci può essere un’ibridazione. Va comunque ricordato che la lettura su carta è fondamentale perché implica un rallentamento, richiede più tempo, e permette un consolidamento nella memoria a lungo termine. C’è un rapporto tra l’attenzione e la memoria, sfortunatamente lo schermo distrae molto. Quando si è distratti, non si riesce a immagazzinare le informazioni con lo stesso livello di dettaglio, non è possibile concentrarsi e quello che si sta leggendo non entra nella memoria.
* L’intervista è stata tradotta e in alcuni passaggi adattata dalla giornalista.