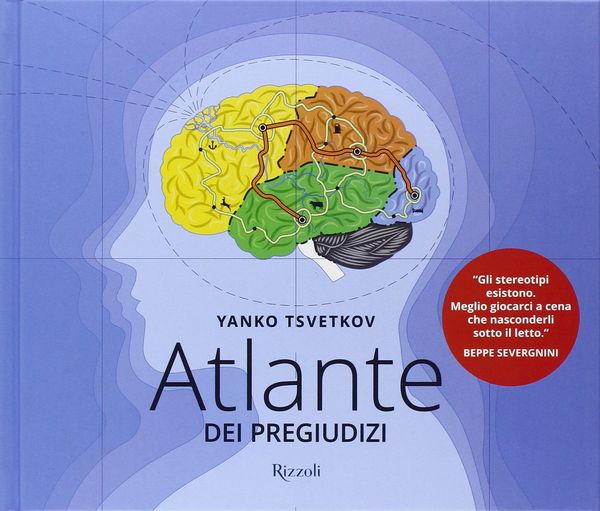L’uso di mappe per orientarsi nello spazio è assai recente. Nel mondo classico, le mappe svolgevano funzioni molto diverse da quelle che, oggi, riconosciamo loro. In quell’età, servivano per celebrare le ideologie imperiali, spiegare la creazione, descrivere l’aldilà e inquadrare le dottrine religiose.
L’ultima delle mappe classiche risale al 1300. Disegnata su velino di vitello, progettata da un gruppo di religiosi che risiedevano nelle cattedrali di Lincoln e Hereford, in Inghilterra, mostra il mondo secondo le credenze del cristianesimo medievale. L’opera è nota come Mappa mundi di Hereford. Al centro esatto è collocata la città di Gerusalemme. L’Africa subsahariana è popolata di mostri, con i «Trogloditi» che scavano caverne, il velenoso «Basilisco», la tribù dei «Blemmi» che hanno «bocca e occhi nel torace», e quella dei «Filli» che «espongono i propri neonati ai serpenti». Al Nord c’è il giardino dell’Eden, all’estremo oriente si pratica il cannibalismo, oltre le Porte d’Ercole si estende il mare ignoto, ecc. Ma l’età delle esplorazioni stava per arrivare, e se alla fine del Trecento mappe come l’Atlante catalano mostrano ancora Gerusalemme al centro, cominciano anche ad emergere dettagli utili per chi avrebbe fatto rotta verso i paesi delle spezie.
Rispetto alle coeve mappe occidentali, quelle prodotte in Oriente sembrano più attente al dettaglio geografico, come per esempio, la Mappa Kangnido, che rappresenta la penisola coreana all’inizio del 1400, e si estende sino a raffigurare l’Europa. Ma anche le mappe orientali sono l’evoluzione di una tradizione caratterizzata, anch’essa, da opere realizzate con lo scopo di rappresentare non tanto dei luoghi, quanto piuttosto dei punti di vista ideologici.
È a questa antica tradizione che s’ispira il più famoso cartografo del web, il bulgaro Yank Tsvetkov, l’autore del celebre Atlante dei pregiudizi. Le sue cartine, che rappresentano il mondo dal punto di vista ideologico di questo o quel paese, da anni stanno girando online (la casa editrice Rizzoli ha pubblicato la versione italiana). In quasi tutte le mappe disponibili, la Svizzera è identificata con i termini di «banca», «cioccolato», «neve», «soldi», «orologi». Siamo «soporiferi» nella cartina dell’Europa vista dalla Grecia nel 2011; «maleducati» nella visione dalla Spagna dello stesso anno; l’anno successivo, per i latinoamericani, siamo sineddoticamente «Heidi», e «stupidi» per l’Austria; mentre nella mappa che rappresenta l’Europa vista dalla Svizzera nel 2010 siamo semplicemente il «Mondo».
La tendenza degli abitanti di una nazione a far coincidere i limiti geografici del proprio paese con quelli del «Mondo» cresce con la supposta o reale importanza della loro nazione. Le terre emerse viste dal punto di vista degli americani nelle rappresentazioni di Yanko Tsvetkov mostrano una tale centralità degli Stati Uniti, che pressoché ovunque, fuori dai loro confini, gli americani potrebbero scrivere «hic sunt leones». Ma ciò che Tsvetkov vuol mostrare non è tanto la distorsione prospettica di chi si sente al centro del mondo, quanto la forza e la specificità del pregiudizio. Dal punto di vista americano, il Brasile è semplicemente la «Terra del pube rasato», così come l’India è lo «Yoga»; e se il Madagascar è fatto coincidere con i «Pinguini» è perché Tsvetkov è bravo a farci capire che gli stereotipi, oggi, nascono anche da una fiction che crea un immaginario capace d’imporsi con forza sul reale – non per nulla la Nuova Zelanda è definita «La contea».
Fotografo, scrittore, illustratore, graphic designer, bulgaro che ha studiato in tedesco, ha vissuto prima in Inghilterra e ora in Spagna, Yanko Tsvetkov dice d’essere innanzitutto un viaggiatore. Si sente un dilettante in ogni attività, sebbene come graphic designer riconosce di essere estremamente pedante. In pochi anni, è diventato una celebrità, e con le sue mappe continuamente aggiornate si prefigge il solo compito di fornire strumenti utili perché una comunità possa prendere coscienza di quanto peculiare sia il suo punto di vista sul mondo, sostenendo che «per quanto concerne l’esplorazione culturale, siamo ancora nel Medioevo». L’autore non ha altro scopo se non quello di richiamare l’attenzione sul fatto che «ciascuno di noi vede se stesso come un modello per l’intera razza umana». Un messaggio semplice ma anche imbarazzante, in un momento storico che vede la celebrazione del proprio territorio da parte di tutti i populismi: «trascuriamo consapevolmente il fatto che la mancanza di umiltà non è il difetto di una cultura in particolare, ubriaca di potere o immersa nell’ignoranza, ma è un problema comune al genere umano».
In questa prospettiva, i molti video raccolti nel sito web «Who wants to be second?» (www.everysecondcounts.eu) perseguono le stesse intenzioni dell’Atlante di pregiudizi, usando però l’autoironia. Mentre, cioè, Tsvetkov disegna mappe che mostrano paesi contrassegnati da etichette che dichiarano il pregiudizio che su di essi hanno specifiche nazioni, i filmati usano ironicamente mancanza di umiltà denunciata da Tsvetkov, facendo la deliberata apologia dei luoghi comuni; espediente retorico il cui effetto viene amplificato dall’imitazione per antifrasi del celebre proclama di Donald Trump «America first!». Cosicché, se il neo presidente americano può ripetere logori luoghi comuni, dichiarando che il suo paese può tornare a primeggiare, perché mai non dovrebbe esserci dell’orgoglio ad essere secondi, facendo un’uguale apologia dei luoghi comuni del proprio paese?
Cominciato nel 2009, il lavoro di Tsvetkov non si è più interrotto. L’autore continua a pubblicare nuove mappe: il mondo visto da Marine Le Pen, quello visto da Donald Trump, quello visto da qualunque utente di Facebook, la mappa dell’Europa islamizzata, quella dei disordini alimentari correlati alle nazioni, ecc. È uno sforzo costantemente rinnovato per far emergere gli stereotipi, ma anche per prefigurare come potrebbe essere il mondo se l’azione politica fosse solo guidata dal pregiudizio, senza sforzarsi di comprendere davvero quali sono le complesse interazioni che ci legano. «In questa società globale interconnessa, dove le informazioni viaggiano più velocemente dei pensieri, forse i pregiudizi non sono altro che un effetto collaterale della nostra pigrizia mentale».