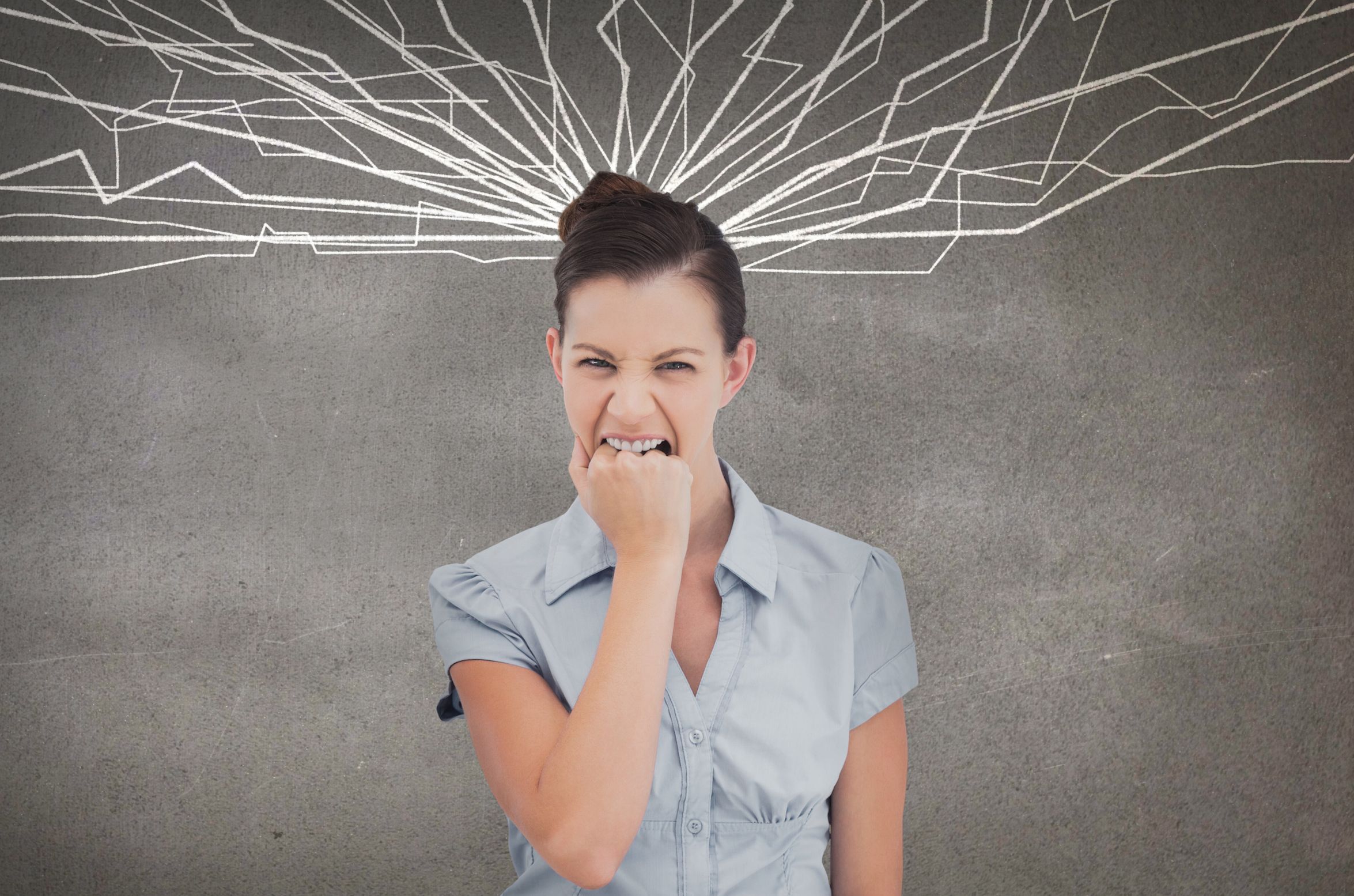La rabbia è un’emozione tabù per le donne, considerate ancora, secondo lo stereotipo comune, il «gentil sesso». Qualcosa però sta cambiando. Di questo nuovo scenario si stanno occupando libri, conferenze e articoli negli Stati Uniti e in Canada, dove è nato un vero e proprio filone sulla scia dell’ondata di manifestazioni di protesta del 2018 (la Women’s March) e del movimento #MeToo. Alcuni titoli recenti: Good and Mad (Buona e furiosa) di Rebecca Traister, editorialista del «New York Times» che ha firmato altri due libri bestseller su donne e politica; Rage Becomes Her (uscito in italiano col titolo La rabbia ti fa bella) di Soraya Chemaly, scrittrice e attivista; Burn It Down (Distruggi), curato da Lilly Dancyger, editor e giornalista. In questa raccolta di saggi a più voci viene raccontata la rabbia nella sua dimensione privata e pubblica.
Ed è proprio l’impatto sulla società ad essere particolarmente interessante. Come scrive Elaine Blair sul «New York Times» a proposito del libro di Traister, la storia dimostra che la rabbia femminile può essere trasformativa, favorendo veri e propri mutamenti sociali. Si pensi a Elizabeth Freeman, prima afroamericana in schiavitù a vincere una causa per affrancarsi dal padrone, in Massachusetts, nel 1781. La sua lotta è stata motivata dall’aver preteso l’applicazione, per se stessa, del primo articolo nella Costituzione americana: «tutti gli uomini sono stati creati uguali» (la sua storia dovrebbe presto diventare un film). Un altro nome importante è quello di Rosa Parks, che col suo rifiuto di cedere il posto su un autobus a un bianco cambiò per sempre la storia dei diritti civili. Altre meno famose hanno preso parte ai movimenti abolizionisti, per il diritto di voto e del lavoro. Nessuna di loro riusciva più a tollerare le condizioni nelle quali viveva. Eppure, spiega Traister, «raramente la rabbia è stata considerata giusta e patriottica quando ha avuto origine dalle donne».
La rabbia, nella sua declinazione di emozione politica in risposta a un’ingiustizia, dovrebbe essere più che lecita stando agli indicatori internazionali che misurano il grado di subalternità in cui vivono ancora molte donne. Secondo il Global Gender Gap report del World Economic Forum del 2018, ci vorranno almeno altri duecento anni per colmare la disparità salariale tra uomini e donne. Per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la violenza di genere è la «maggiore preoccupazione di salute pubblica», con il trentacinque per cento delle ragazze e delle adulte che hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita.
In molte hanno iniziato a dire basta. La furia femminile ha preso forma, ricorda Traister, nel movimento #MeToo che probabilmente sta cambiando per sempre il mondo del lavoro americano, con conseguenze a lungo termine anche nel resto del pianeta. Sono state smascherate antiche prevaricazioni considerate «normali»: le molestie verbali e fisiche sul lavoro, che passano dal ricatto agli abusi fisici, non sono più considerate tollerabili.
Soraya Chemaly nota che le donne vengono ancora educate, fin da piccole, a sopprimere la propria collera, un vero e proprio spreco, secondo l’autrice, perché «un arsenale carico di ira» fa comodo per reagire quando si appartiene alla metà discriminata della società. La gestione della rabbia resta spesso privata. Questo sembra indicare, ad esempio, il diffondersi delle cosiddette rage rooms, dove si sfogano le proprie frustrazioni distruggendo oggetti con mazze, spaccando mobili con martelli, lanciando piatti e bicchieri (ma anche computer) contro il muro e sul pavimento. Presenti in diversi Paesi del mondo, le «stanze della rabbia» sono frequentate per il settanta per cento da una clientela femminile, secondo Battle Sports, compagnia canadese che gestisce un franchising internazionale chiamato, appunto, «Rage Room» in Canada, Stati Uniti, Singapore, Ungheria e Australia. La psicologa francese Florence Millot ha spiegato alla rivista inglese «Huck» che non è stupita dalla tipologia dell’utenza. «Anche se le donne provano rabbia esattamente come gli uomini, hanno meno spazio per esprimerla. La rabbia femminile resta un tabù perché le donne vengono ancora messe su un piedistallo. Sono considerate figure materne, devono occuparsi della famiglia. Se manifestano accessi di ira sono, per la società, dei diavoli».
Diversi studi dimostrano che è meglio nascondere la collera, soprattutto nei posti di lavoro. Quella femminile è vista in modo più sfavorevole rispetto a quella maschile. Le donne se ne vergognano, secondo una ricerca di qualche anno fa della Cambridge University. Conclusioni simili si trovano in pubblicazioni di Harvard e dell’Università di Chicago.
Anche arrabbiarsi di fronte a un evento traumatico come una malattia non è benvisto. Un libro appena uscito, intitolato Disrupting Breast Cancer Narratives: Stories of Rage and Repair (Cambiare le narrazioni sul cancro al seno: storie di rabbia e rimedio) di Emilia Nielsen, scrittrice e accademica canadese, analizza la necessità di offrire spunti e possibilità diverse alle donne che si trovano ad affrontare esperienze difficili e dolorose dal punto di vista fisico. Per resistere alle cure e all’incertezza, più che discorsi retorici e raccolte fondi (di dubbia trasparenza) con nastri rosa, occorre mettere al centro l’arrabbiatura lecita di chi si ammala. Fare diventare la malattia non più un fatto individuale ma collettivo, come di fatto lo è già, stando ai numeri che indicano l’incidenza del cancro al seno. Nel testo di Nielsen, per ora solo in inglese, vengono citati i contributi di studiose e scrittrici come Barbara Ehrenreich, Kathlyn Conway, Audre Lorde e Teva Harrison. Per ricordare, come scriveva Barbara Brenner, attivista per la lotta contro il cancro al seno, che «la rabbia è utile, dipende da cosa ci fai».