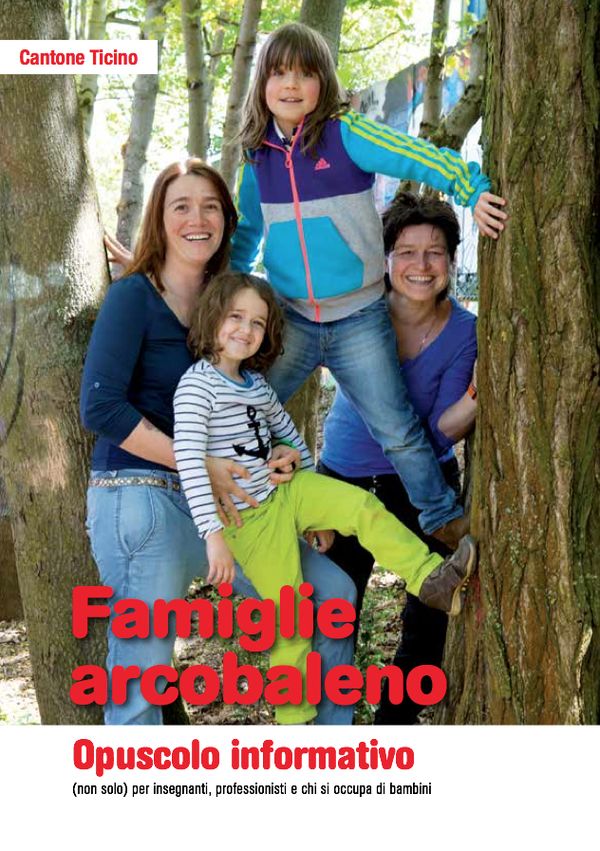«La prima infanzia è un periodo estremamente fecondo per l’apprendimento, in questa fase si gettano le basi dell’apprendimento sull’intero arco della vita e si acquisiscono competenze di vitale importanza». Scrivono così i redattori del Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera, intendendo per prima infanzia gli anni che vanno dalla nascita ai quattro anni. Il documento è stato pubblicato per la prima volta nel 2012 ed è ora giunto alla sua terza edizione. Il Quadro d’orientamento è considerato il primo passo in un percorso nel quale il nostro Paese ha accumulato un certo ritardo continuando a considerare la cura del neonato e del bambino piccolo un fatto strettamente famigliare, alimentando un atteggiamento «custodiale» nei confronti dei bambini. Scardinare una mentalità tradizionale è un’operazione lenta, un lavoro che richiede consapevolezza e coinvolgimento. Ne abbiamo parlato con Dieter Schürch, membro della Commissione svizzera per l’Unesco e docente all’università Sigmund Freud di Milano.
Dott. Schürch, che cos’è il Quadro d’orientamento e quali sono le ragioni che stanno alla base della sua stesura?
Il punto di partenza è stato uno studio che la Commissione svizzera per l’Unesco ha commissionato all’università di Friborgo per valutare la situazione e lo stato delle cose per quanto riguarda la prima infanzia in Svizzera. Dallo studio è emerso in modo palese che, in confronto ad altri Stati europei, la Svizzera era in ritardo: non esistevano dei criteri che definissero la qualità pedagogica o semplicemente che cosa ha da essere l’accoglienza, la cura e l’educazione del bambino in età prescolare. Inoltre si constatava una certa confusione nelle qualifiche del personale impiegato negli asili nido e una carenza a livello di ricerca universitaria. Da qui il primo passo è stato quello di dare mandato al Meierhofer Institut per il bambino di Zurigo di redigere un documento che definisse quali fossero i punti fondamentali per creare un ambiente in grado di rispondere a determinati criteri di qualità nell’accoglienza della prima infazia. È nato così il Quadro d’orientamento: per noi una specie di sasso lanciato nello stagno svizzero.
Quali sono stati i passi successivi?
Si è passati a una fase di sperimentazione per vedere fino a che punto il suo contenuto potesse essere condiviso e al limite modificato. Sull’arco di due anni il Quadro d’orientamento è circolato in Svizzera e si è chiesto alle strutture di accoglienza di valutare se potesse corrispondere alle loro esigenze. Nelle tre regioni linguistiche si sono annunciati degli asili nido che hanno preso parte a questa fase, il Ticino è stato il cantone con il maggior numero di istituti coinvolti. Dopo due anni a Lucerna si è svolto un incontro per «tirare le somme» di questa fase sperimentale, l’esito è stato molto positivo e si è finalmente salutata l’adozione di un documento a livello nazionale che trattasse la tematica dell’approccio pedagogico alla prima infanzia. Oggi esiste, dunque, un primo mattone su cui costruire ciò che dovrebbe essere un cambiamento di mentalità in un settore che è di fondamentale importanza per quanto riguarda lo sviluppo del bambino e dell’uomo. Inoltre sulla base di questo hanno preso forma altri documenti che trattano aspetti particolari quali l’integrazione, lo spazio sociale, la salute, l’ambiente. L’ultimo è del 2016 e tratta in modo specifico la prevenzione della povertà nella prima infanzia.
Quali sono le idee alla base del Quadro d’orientamento?
Le conoscenze scientifiche che derivano dalle ricerche sul bambino piccolo soprattutto in ambito delle neuroscienze e della psicologia mostrano che molta parte delle potenzialità dell’uomo si sviluppano e prendono forma nei primi 3-4 anni di vita, vale a dire prima dell’entrata nella scuola. Oggi, dunque, sappiamo che nel momento dell’entrata nella scuola determinate condizioni sono già ad un punto tale per cui bambini che non hanno avuto la possibilità di crescere in un ambiente favorevole non riescono più a recuperare il ritardo accumulato. Possiamo affermare che gli sforzi che la scuola da sempre fa per rimediare alla disparità tra chi ha goduto di un ambiente favorevole che ne promuovesse le potenzialità (potenzialità che peraltro esistono in tutti i bambini) e chi invece purtroppo non lo ha avuto portano sostanzialmente a scarsi risultati.
In questo ambito come si profila il Canton Ticino?
Il Ticino è considerato un modello in Svizzera. Nel 2013, alla presentazione del Quadro d’orientamento, è subito nata una proficua discussione dalla quale è emerso un punto di debolezza, e cioè lo spezzettamento che esisteva sul territorio nel campo della prima infanzia, le molte organizzazioni esistenti si ignoravano a vicenda sia nel settore della cura del bambino sia nell’ambito della genitorialità. Si è così dato vita a due tavole rotonde che hanno avuto la caratteristica di mettere in contatto tutti gli attori che si muovono in questo ambito e che hanno poi identificato una tematica comune, quella delle transizioni, cioè il passaggio del bambino piccolo dalla famiglia all’asilo nido, dall’asilo nido alla scuola, dai genitori ai nonni. Si è deciso di attribuire alla Supsi il ruolo di coordinatore e di stendere un progetto denominato TIPI, cioè Ticino Progetto Infanzia. Oggi esiste da circa un anno, creando un movimento straordinario, di ricerca, di sviluppo e di formazione. Ora anche nel resto della Svizzera si sta seguendo il modello ticinese.
A suo avviso dove rimangono delle lacune?
Sul piano della sensibilizzazione per quel che riguarda il rapporto con il bambino si stanno compiendo passi significativi, dove però la commissione constata una lacuna è in ambito sociale e politico. La politica guarda, osserva, ma si ha l’impressione che non ci sia ancora una vera presa di coscienza di ciò che è la posta in gioco. Così affinché Comuni, Cantoni e Confederazione prendano ancora più sul serio tutto ciò che in questo settore c’è ancora da fare abbiamo riassunto sotto forma di Appello i punti che meritano ancora di essere discussi per portare a un cambiamento sostanziale in questo settore. Non ci siamo però accontentati, serviva un veicolo più accessibile, è nata così l’idea di allestire una mostra itinerante che coinvolgesse tutta la società e rendesse visibile e presente a tutti ciò che è il mondo del bambino piccolo. La mostra intitolata «La scoperta del mondo» è stata pensata dall’associazione Voce per la qualità e prenderà il via da Bellinzona, sarà partecipativa e interattiva, rivolta ai bambini, alle famiglie e a tutta la popolazione. Circolerà in tutta la Svizzera e terminerà nel 2019 a Berna, dove si pensa di organizzare una manifestazione conclusiva che si rivolga e integri la politica.
Quali sono gli ostacoli a uno sviluppo di una sensibilizzazione a livello della popolazione?
Gli ostacoli sono di varia natura, soprattutto persiste una certa visione di bambino, di cosa sa fare alla nascita, di come si sviluppa, di come deve essere preparato per entrare nella scuola, ed è una visione che è molto difficile cambiare. Parlare di bambino in un modo differente da quello che è una concezione tradizionale è ancora molto difficile. Inoltre, se guardiamo le statistiche, in Ticino solo il 13% delle famiglie porta un bambino all’asilo nido, la mentalità è ancora quella che considera la mamma o la famiglia come l’unico luogo che riesce a prendersi cura in maniera adeguata del bambino piccolo. Come se diventare genitore facesse automaticamente acquisire le competenze necessarie. Il 40% delle famiglie non porta i bambini in nessuna struttura di accoglienza, il 20% si appoggia sui nonni, che comunque hanno una visione tradizionale sia della famiglia sia dell’accoglienza del bambino. Il processo che ha preso avvio con il Quadro di orientamento, che svela un’immagine di bambino molto diversa da quella che la società ha, è un mutamento di mentalità difficile da provocare perché richiede tempo e cambiamenti di ruoli all’interno della famiglia. In questo siamo arretrati rispetto ad altri Paesi. Inoltre dovrebbe coinvolgere la società intera in un discorso interdisciplinare e proporre nuove riflessioni e nuove strategie in diversi ambiti che tengano conto del punto di vista del bambino piccolo. Ad esempio nell’ambiente costruito, dagli appartamenti alle strutture dei quartieri, dal parco giochi ai marciapiedi, dai percorsi previsti negli spazi urbani ai rumori, insomma la qualità ambientale in senso più vasto.