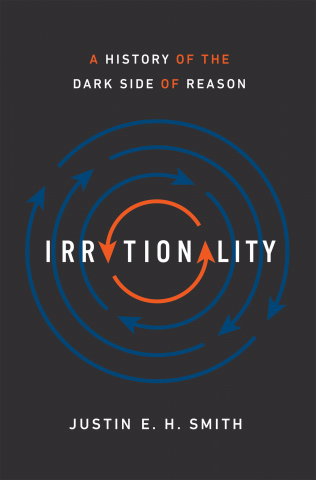La specie umana non è razionale e guidata dal buonsenso. Negli anni più recenti, in particolare, siamo sprofondati in una fase di «grande irrazionalità, fervore, prepotenza, destabilizzazione e paura». A ben guardare, comunque, tra corsi e ricorsi storici, l’umanità è da sempre preda di stupidità e oscurantismo. La storia che ci viene insegnata a scuola, con i Greci che hanno inventato la Ragione, passando per l’epoca dei Lumi che ha consacrato la razionalità a valore supremo, in un crescendo di progresso senza interruzioni, è parziale. Con Irrationality (Irrazionalità), Justin Smith, professore di Storia e filosofia della scienza all’Università di Parigi VII Denis Diderot, ripercorre «il lato oscuro della ragione», come recita il sottotitolo del suo libro (per ora disponibile in inglese per Princeton University Press, nei prossimi mesi in arrivo in italiano). «Azione» lo ha raggiunto al telefono.
Professore Smith, perché ha deciso di scrivere un libro sull’irrazionalità?
Sono uno storico della filosofia e ho un grande interesse per la storia delle idee, per gli usi e gli abusi della logica. Nel mio percorso di studioso mi sono occupato di come, nel pensiero antico, la conoscenza della logica fornisse gli strumenti per avere ragione sugli altri con la sottile arte del sofismo e di quello che veniva definito “spacciare menzogne”. A questi miei interessi si è sommato ciò che è cominciato ad accadere nel 2015, quando i media americani e internazionali hanno iniziato a parlare dell’emergere del populismo globale, culminato con l’elezione, l’anno successivo, di Donald Trump. Questo mi ha portato a estendere i miei studi sui limiti della logica alla politica e alla cultura, applicando la storia delle idee ai tempi di oggi.
Che cosa intende per irrazionalità?
Non è semplice inserire l’irrazionalità in una definizione univoca perché può assumere diversi significati in base ai contesti. Possiamo partire da una descrizione generale di razionalità, intesa come il dedurre la giusta conclusione da un determinato insieme di riferimento. Con l’irrazionalità le persone sembrano arrivare alla giusta deduzione, usando le informazioni a disposizione in un modo che a livello superficiale è corretto, ma in realtà tralasciano alcune informazioni fondamentali per il ragionamento. Vorrei sottolineare che l’irrazionalità non è sempre negativa e infatti lo spiego nel mio libro: ogni ambito della nostra vita, individuale e sociale, ha degli aspetti irrazionali che non dobbiamo certo eliminare. Pensiamo a quando dormiamo e sogniamo, ad esempio, oppure a quando siamo innamorati, ubriachi, in situazioni di euforia collettiva come allo stadio o a un concerto.
Qual è il problema dell’essere irrazionali?
Se non fossimo irrazionali non avremmo la fantasia e tutto quello che ne deriva, dai romanzi, ai film a tutta la produzione culturale che conosciamo. Il problema vero è come riusciamo a incanalare l’irrazionalità nella realtà. Penso che avessero ragione T.W. Adorno e Max Horkheimer, filosofi del secolo scorso, quando sostenevano che l’Illuminismo aveva una tendenza innata a degenerare nel mito e che c’è una propensione della ragione verso l’irragionevolezza, esacerbata dagli sforzi eccessivamente ambiziosi per invertire il processo. Nell’epoca in cui viviamo l’irrazionalità individuale, il pensare in termini mitici al proprio posto nel mondo, come si fa quando si è bambini, è passata dal livello privato a quello pubblico e ne vediamo i risvolti ovunque, in particolare negli Stati Uniti.
Lei affronta le conseguenze dell’irrazionalità in politica, anche per quanto riguarda i social media.
Abbiamo visto come nelle scorse elezioni americane Donald Trump sia riuscito a vincere anche grazie all’uso dei social media. Il fatto che Twitter e Facebook siano il principale campo di battaglia della politica di oggi è qualcosa di interessante e allo stesso tempo terrificante. Si tratta di una modalità completamente nuova perché le regole dei social media sono diverse da quelle usate dalla politica negli ultimi duecentocinquanta anni. Sono regole per nulla razionali: adesso per essere ascoltati bisogna dire le cose nel modo più emotivo ed estremo, più punti esclamativi si mettono nei tweet più è probabile diventare virali. I social media sono, in ultima analisi, impostati per massimizzare i conflitti e la dimensione spirituale dell’esistenza umana e, come ho cercato di dimostrare nel mio libro, hanno precipitato la politica mondiale nella decadenza totale. Per chi si occupa di filosofia come me, è sorprendente anche pensare alle visioni di Leibniz che nel 1600 immaginava un futuro nel quale ci sarebbero state delle macchine, delle protesi di intelligenza artificiale potremmo dire, che ci avrebbero aiutati a elaborare le nostre argomentazioni in un modo che ci avrebbe permesso di capire chi avesse ragione e chi torto. Questo sogno leibniziano è sembrato verosimile fino al 2014, con la Primavera araba, quando Twitter sembrava ancora un motore della democrazia. Poi però quelle spinte sono finite male e ora siamo davanti a un nuovo scenario: non resta che constatare che internet sta peggiorando i nostri problemi.
Perché è utile approcciarsi all’irrazionalità da una prospettiva filosofica?
Qualcuno mi ha criticato perché non propongo soluzioni concrete come fanno i libri di auto-aiuto, ma questo non può essere l’unico piano possibile di azione sulla realtà che abbiamo. Voglio dire, molti filosofi del passato hanno cercato di dirci come vivere meglio quando indagavano la natura dell’universo, le cause finali, le leggi della fisica, e così via. Attraverso la conoscenza della verità filosofica, quella che oggi chiamiamo la verità scientifica, si è meno tormentati dalle superstizioni e quindi si reagisce meglio alle delusioni. Questo è il tipo di auto-aiuto che io cerco di fornire, non regole su come essere felici, ma un invito a pensare più a fondo alle questioni sostanziali.