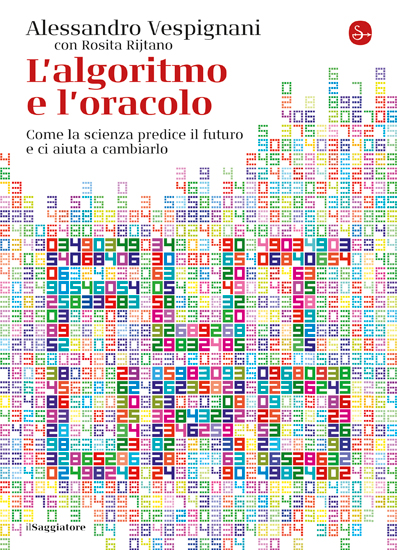Dal navigatore quando siamo alla guida di un’automobile, alle piattaforme di musica e di film, alle pratiche che inoltriamo per chiedere un’ipoteca, le nostre vite sono governate dagli algoritmi. La parola in sé può lasciarci indifferenti oppure suscitare ritrosia e invece dovremmo imparare a considerarla nel dettaglio. Dovremmo sforzarci di guardare da vicino gli algoritmi, cioè «le regole che definiscono una sequenza di operazioni che usiamo per identificare tendenze, trovare associazioni, estrarre le leggi e le dinamiche alla base di fenomeni sociali».
Un primo passo può essere quello di leggere L’algoritmo e l’oracolo (Il Saggiatore) del fisico italiano Alessandro Vespignani, professore alla Northeastern University di Boston, negli Stati Uniti, e guru dei sistemi complessi. Il libro permette di addentrarsi nell’identificazione di tutte le definizioni che siamo abituati ad ascoltare senza soffermarci, da machine learning (l’uso di algoritmi in grado di ricevere una serie di dati e di apprendere da soli, modificando le formule man mano che trovano schemi e associano dati) a neural network (algoritmi basati su un modello semplificato del cervello umano). E fornisce le nozioni base per capire quanto la tecnologia ci stia governando e condizionando. «Siamo costantemente accompagnati da un mondo di applicazioni che riescono a leggere nella nostra mente e a guidare quello che facciamo. A chi è giovane abbastanza da essere sempre stato in possesso di uno smartphone può sembrare scontato che ci siano così tanti strumenti pronti per aiutarci: tutto questo è innegabilmente comodo. Dobbiamo però constatare che siamo di fronte a sistemi che possono portare a distorsioni inevitabili. E soprattutto dobbiamo pensare che chi possiede la conoscenza per creare algoritmi capaci di influenzare milioni di persone, come già avviene, attraverso piattaforme culturali, commerciali e di socializzazione, ha un enorme potere». Così spiega Vespignani, raggiunto via Skype da «Azione» nel suo laboratorio negli Stati Uniti, un grande open space di pareti di vetro dove lavora col suo gruppo di ricerca. Scienziati, politici, fisici, matematici, economisti, informatici di nazionalità diverse che si incontrano quotidianamente per discutere di problemi relativi a dati, reti, sistemi biologici e sociali e predittivi (sono gli oracoli della nostra era): dalle diffusioni di epidemie come quella di Zika in America Latina alle copie che venderà un libro appena pubblicato. Questo tipo di previsioni, possibili grazie agli algoritmi, sono utilizzate non soltanto dai governi, nel caso delle pandemie, o dalle case editrici, per romanzi e saggi, ma anche dai giudici americani (lo scandalo del sistema COMPAS, uno dei tanti algoritmi usati per prevedere il rischio che un imputato commetta nuovamente un reato, è diventato negli anni scorsi di dominio pubblico dopo l’inchiesta dell’associazione di giornalismo investigativo «ProPublica») e dalle squadre sportive. Vespignani racconta che nel calcio l’intelligenza artificiale viene usata per scremare la lista dei candidati ideali a ricoprire un determinato ruolo e per evitare infortuni muscolari durante l’allenamento, avvisando il mister prima che sia troppo tardi ed evitando perdite milionarie. Al Barcellona, da 2 anni, lavora un gruppo di data scientists che aiuta la squadra a elaborare le tattiche giuste per ogni partita.
Anche nell’arte si fanno previsioni. Si vaticinano le carriere degli artisti. Attraverso l’analisi di quasi 500mila mostre in 16mila gallerie e una serie di altri dati che includono compravendite, aste, musei in 146 paesi del mondo nel corso di 36 anni di storia, sono stati stabiliti i parametri che indicano se un artista avrà successo e in quanto tempo. Secondo questi parametri, chi ha avuto la possibilità di debuttare nel 20 per cento delle istituzioni più prestigiose a livello internazionale avrà vita facile, mentre chi ha iniziato in musei o gallerie di serie B e dopo 10 anni non ha ancora sfondato è da considerarsi fuori dai giochi. Soltanto 240 artisti presi in esame, lo 0,048 per cento del campione (meno di uno su 10mila), sono riusciti a emergere dal basso.
Ma è davvero una consuetudine che per puntare su un artista, uno scrittore, un calciatore ci si basi sugli algoritmi? «Certamente, questa è la realtà che stiamo vivendo» dice Vespignani senza la minima esitazione. «È chiaro, pensando ad esempio ai libri, che se una casa editrice punta molto denaro su un certo romanzo, investendo nella promozione, mette in atto il meccanismo della profezia che si auto-avvera. E così facendo scarta una serie di altre possibilità che magari avrebbero potuto comunque essere valide». Secondo il ricercatore «non c’è modo di sottrarsi a questo sistema, ormai è impossibile» e quindi non ci resta che regolarlo. «La tecnologia, dal mio punto di vista, non rappresenta una deriva inarrestabile che ci porterà alla distruzione. Questo tipo di sospetto c’è sempre stato davanti a ogni grande rivoluzione tecnologica». Si pensi ad esempio all’invenzione della stampa di Gutenberg (nel 1455 uscì il primo libro stampato). I tradizionalisti credevano che la divulgazione di testi accessibili a fasce più ampie di popolazione avrebbe avuto conseguenze nefaste.
Al di là delle opinioni individuali, è un dato di fatto che usando computer e smartphone interagiamo continuamente con la rete e produciamo una serie di informazioni che ci riguardano. Per avere un’idea, si stima che ogni giorno vengano creati due Exabyte e mezzo di dati, equivalenti a una torre di oltre mezzo milione di dvd uno sopra l’altro. Cercare di non lasciare tracce in rete è praticamente impossibile a meno di decidere di andare a vivere in una delle pochissime aree remote rimaste sulla terra, senza contatti con l’esterno. «Invece di ragionare con una mentalità novecentesca, bisogna informarsi per capire cosa si può fare per controllare e regolamentare il sistema, senza lasciare agli esperti del settore decisioni che hanno un impatto incredibile sulle nostre vite. Tutti devono entrare nel merito di questi temi, non occorre essere degli scienziati per riuscirci. La consapevolezza è la vera arma a nostra disposizione».