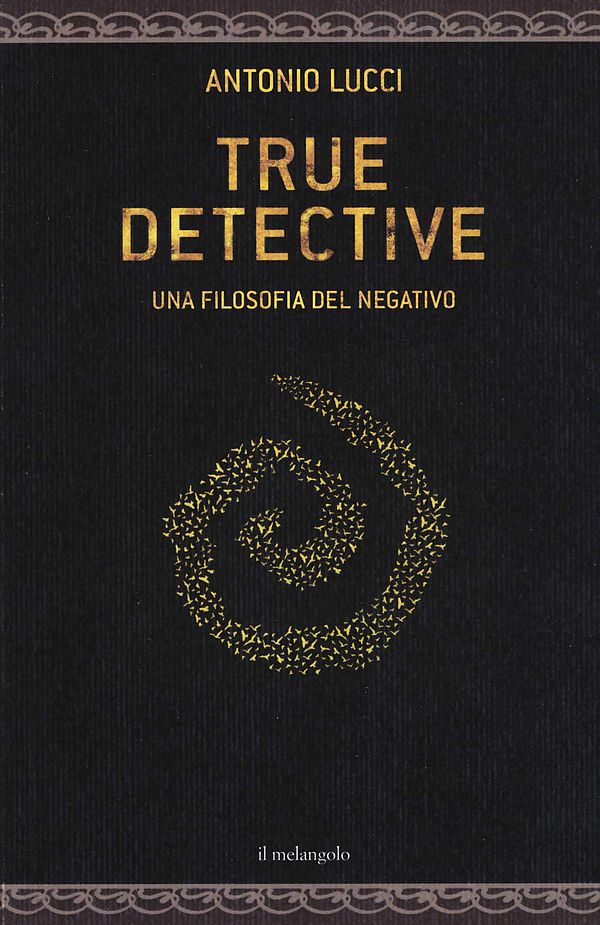«Per comprendere la società del 1800 bisogna leggerne i romanzi, per comprendere quella del ’900 bisogna guardare i suoi programmi televisivi. Per comprendere la nostra società bisogna guardare le serie televisive (e giocare ai videogames)». Così ha dichiarato Antonio Lucci ricercatore presso il Forschungsinstitut für Philosophie di Hannover, autore di un saggio intitolato True Detective. Una filosofia del negativo.
L’immediata popolarità di cui ha goduto la prima serie di True Detective è dovuta a quattro fattori: l’abilità dell’autore Nic Pizzolatto, la recitazione dei due attori principali Matthew McConaughey e Woody Harrelson, la controversa questione del presunto plagio dello scrittore americano «maledetto» Thomas Ligotti, e l’esposizione al grande pubblico di un’America torbida, inquietante, percorsa da una febbrile inclinazione al nichilismo che emerge in questi anni come un fiume carsico.
La prima serie di True Detective si svolge in Louisiana, nel 1995. Sotto un albero isolato nel mezzo di una piantagione viene ritrovato il cadavere di una donna forse uccisa seguendo un rituale: nuda, legata, inginocchiata verso la pianta e con delle corna animali appoggiate sulla testa, quasi come stesse pregando. I due detective incaricati di indagare sul caso sono Rustin Cohle e Martin Hart interpretati rispettivamente da Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Essi incarnano due figure contrapposte di tipi americani. Martin «Marty» Hart riprende il classico stereotipo dell’americano per bene, non si pone grandi domande esistenziali e preferisce parlare di tutto ciò che è mondano e comune. Rustin «Rust» Cohle è chiamato dai colleghi «l’esattore» perché preferisce prendere appunti su un librone nero e non sul classico bloc-notes. Rust è umbratile, in procinto di scivolare lungo il piano inclinato della paranoia, dedito a una maniacale e quasi perversa attenzione al minimo dettaglio e allo studio delle persone.
Dopo l’uscita della prima serie di True Detective, l’attenzione generale è andata alla figura di Rustin Cohle, sia per l’audacia con cui Nic Pizzolatto ha portato in una serie televisiva una visione fortemente pessimista del mondo, sia perché ha fatto riemergere una tradizione americana «oscura», raccontata attraverso la letteratura di autori come Howard Phillips Lovecraft o Edgar Allan Poe, antesignani di una letteratura dell’inquietudine, spesso sconfinante nell’horror. Ma l’ulteriore ragione per la quale questa prima serie ebbe subito ampia eco è che, proprio per i dialoghi messi in bocca dal pessimista Rust, Nic Pizzolatto è stato accusato di plagio, e in particolare di aver usato ampi stralci dell’opera di Thomas Ligotti intitolata La cospirazione contro la razza umana.
Personaggio misterioso, scrittore e saggista americano, Ligotti è una sorta di filosofo del perturbante, una specie di rabdomante sensibile agli aspetti più inquietanti della società americana contemporanea. Non è tanto l’horror, che egli racconta nella sua narrativa e descrive nei suoi saggi, quanto piuttosto l’«orrore soprannaturale», il lato in ombra della realtà di tutti giorni. Rivolgendosi al suo sconcertato collega Marty, in effetti, Rust si esprime spesso usando parole che sembrano tratte da La cospirazione contro la razza umana. Nella serie TV Rust dice: «Siamo diventati troppo consapevoli di noi stessi. La natura ha creato un aspetto della natura stessa separato da sé. Siamo creature che non dovrebbero esistere secondo la legge della natura», con l’intenzione di sottolineare la nostra estraneità alla natura; mentre nel libro di Ligotti si legge: «Sappiamo che la natura è virata nel sovrannaturale fabbricando una creatura che non può e non dovrebbe esistere secondo le leggi della natura, ed invece lo fa». Nic Pizzolatto non solo non ha negato questi riferimenti a Ligotti, ma ha dichiarato di aver costruito il personaggio di Rust proprio facendo ricorso a tutta la tradizione letteraria e filosofica, cui fa riferimento lo stesso Ligotti, innescando in tal modo una ricerca delle fonti filosofiche della serie TV che ha moltiplicato articoli, saggi e libri.
La tradizione pessimista, alla quale dà voce il detective Rustin Cohle è il lato oscuro dell’american way of life descritto da Ligotti nelle pagine di La cospirazione contro la razza umana, dove tutti i valori della società americana del detective partner Martin Hart sono additati come illusori e catastrofici. Nell’ideologia americana, per esempio, ha un posto di primo piano la persuasione che ognuno è pienamente padrone del proprio destino. Per Ligotti, invece, ciascuno di noi non è altro che una marionetta. Altro valore della società americana messo in crisi da Ligotti è la convinzione che le risorse dell’ambiente non siano esauribili e che, come vuole la tradizione positivista, le forze del mondo debbano essere piegate e domate agli scopi definiti dal genere umano. La critica di Ligotti è di un radicalismo senza compromessi: ispirandosi al filosofo norvegese Peter Wessel Zapffe – che coniò il termine «biosofia» con lo scopo di estendere il campo della filosofia per comprendervi gli interessi degli altri esseri viventi oltre agli umani –, sostiene che «la distruzione dell’ambiente è solo un elemento di contorno al rifiuto dell’umanità di guardare nelle fauci dell’esistenza», sposando la visione antinatalistica di Zapffe che sosteneva: «L’umanità dovrebbe porre fine alla sua esistenza di sua volontà».
Ma qual è la reazione attuale a questo rinnovato orientamento pessimista? Per Thomas Ligotti occorre semplicemente scoraggiare la riproduzione del genere umano, di cui il pianeta Terra non ha alcun bisogno. Tuttavia, nelle ultime scene di True Detective, Rustin Cohle, convalescente dopo una grave ferita, dice: «Ero sparito. Non esisteva “io”. C’era soltanto amore… e allora mi sono risvegliato», indicando la tradizione buddhista come una possibile via di salvezza.