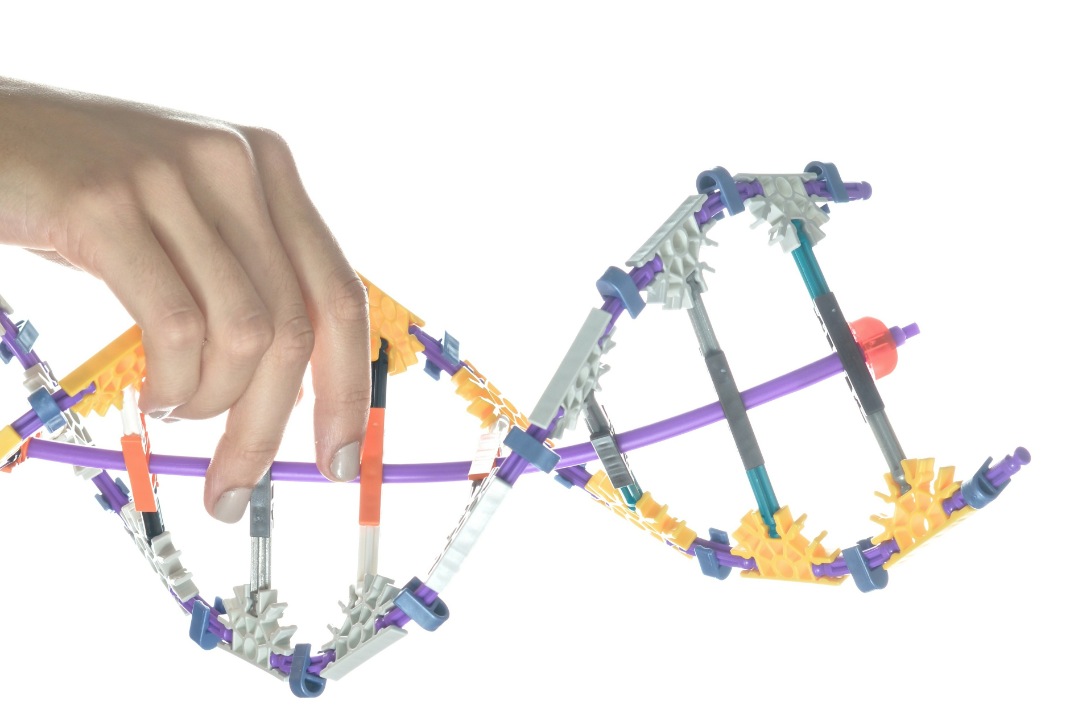C’erano una volta gli organismi geneticamente modificati, oggi ci sono gli organismi geneticamente editati. «Grazie all’enzima Cas9 gli OGM classicamente intesi stanno per diventare preistoria perché non servirà più trasferire un gene da una specie all’altra, bensì modificare direttamente i geni che ci interessano con un taglia-incolla». Così scrivono Luca De Biase e Telmo Pievani in Come saremo. Storie di umanità tecnologicamente modificata, un saggio che, prendendo in rassegna un ampio ventaglio di tecnologie che stanno modificando la nostra vita quotidiana (da quelle per comunicare, a quelle per procreare, passando dalle tecnologie per curare), ha l’ambizione non tanto di prevedere il futuro, quanto piuttosto di affinare una metodologia in grado di indicare ciò che appare più probabile possa accadere, dai due autori definito il «possibile adiacente».
I due autori hanno una formazione molto diversa e a unirli è un comune interesse per la prospettiva storica e l’uso sociale delle tecnologie. Formatosi come economista, De Biase si è distinto per la perspicacia con cui ha rinnovato le sue analisi in ordine ai rapidi avvicendamenti tecnologici degli ultimi due decenni nell’ambito della comunicazione. Filosofo di formazione, Pievani ha poi spostato i suoi interessi nel campo della biologia, diventando uno dei più autorevoli divulgatori in lingua italiana dell’evoluzionismo, che egli – seguendo l’insegnamento di Niles Eldredge e Ian Tattersall – ha contribuito ha rendere più ricco di strumenti interpretativi.
Il concetto che De Biase e Pievani hanno di «tecnologia» è molto ampio, ed è a tal segno una caratteristica specifica della nostra specie, da indurre i due autori a sostenere che «il genere Homo si è insomma evoluto in simbiosi con le sue tecnologie».
Un concetto importante che De Biase e Pievani usano è quello di «nicchia eco-culturale», utile per tener costantemente presenti due aspetti recentemente emersi dalla ricerca paleoantropologica: «il carattere ramificato, regionale e irregolare dei processi d’innovazione tecnologica» dovuto alla nostra evoluzione non lineare; e i mutamenti che abbiamo noi stessi introdotto nelle nicchie ecologiche in cui si siamo evoluti.
Sullo sfondo di questo concetto, che sottolinea la coevoluzione tra genere e ambiente mediata dalla tecnologia, il lavoro che hanno svolto De Biase e Pievani è stato quello di esaminare l’evoluzione della tecnologia alla luce delle più recenti acquisizioni teoriche nell’ambito degli studi dell’evoluzionismo.
Per i due autori, la prima spinta evolutiva sono i fenomeni di innovazione e di creazione, caratterizzati da dinamiche di cambiamento che in biologia evolutiva sono denominate pattern. Talvolta, le mutazioni tecnologiche «sono indotte da agenti progettuali che le pensano appositamente e le gettano nell’arena» – basterebbe pensare a figure come Steve Jobs, per esempio; altre volte, invece, «la nascita di intere famiglie di nuove tecnologie può essere sprigionata in modo non intenzionale dall’apertura di inediti campi di ricerca»: il passaggio dall’analogico al digitale ha aperto possibilità innovative date dalla natura stessa della nuova tecnologia.
In questa prospettiva, è fondamentale il concetto di exaptation. Si tratta di quei casi, nei quali una struttura, evolutasi per una certa funzione, è stata successivamente reclutata o cooptata per fare altro. È il caso, per esempio, delle piume degli uccelli: molto probabilmente evolutesi per fungere da termoregolatori, sono poi state cooptate per rendere più efficiente il volo. Qualcosa di simile è accaduto, per esempio, alla tecnologia degli SMS: nata per soddisfare necessità tecniche, è poi diventata uno strumento di comunicazione perché cooptata in pratiche sociali che l’hanno adattata ad altri scopi.
Molta attenzione i due autori dedicano ai processi selettivi delle tecnologie. «L’espressione processi selettivi al plurale è da preferirsi a selezione naturale, perché gli schemi di selezione sono molteplici pur condividendo la stessa logica di fondo». Anche le tecnologie conoscono una forma di «potatura». Si pensi, per esempio, al gran numero di sistemi operativi esistenti negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso: la successiva «potatura» ha poi selezionato Windows, MacOS e Linux.
Non sempre, però, la selezione premia la tecnologia migliore o più funzionale. La tastiera QWERTY, per esempio, nacque per evitare che i martelletti delle prime macchine per scrivere meccaniche si sovrapponessero, distanziando le lettere più usate dai dattilografi. Ebbene, la configurazione QWERTY è ancora usato oggi, sebbene non abbia più nessuna ragion d’essere e malgrado altre configurazioni abbiano dimostrato di essere più veloci.
Fatta chiarezza sul modo in cui le tecnologie mutano, si diffondono e vengono selezionate, De Biase e Pievani, osservato che «non è possibile predefinire in modo finito lo spazio delle configurazioni delle tecnologie future», che, cioè, abbiamo delle difficoltà predittive dovute alla complessità delle interazioni all’interno delle nicchie eco-culturali e tra le nicchie stesse, introducono il concetto di possibile adiacente: «l’adiacente possibile è, in altri termine, l’insieme degli stati potenziali del sistema tecnologico attuale che distano di un solo passo reale da ciò che di volta in volta è il presente».
De Biase e Pievani non sono, quindi, dei futurologi. Il loro possibile adiacente non ci fa vedere che cosa c’è nel futuro, bensì che cosa c’è dietro l’angolo. Sennonché la peculiarità del loro approccio consiste nell’attribuirci una responsabilità apparentemente imprevista. Mentre l’evoluzione per seleziona naturale, ben lungi dall’essere deterministica, è casuale e solo a posteriori riconducibile ad una catena di cause ed effetti, l’evoluzione tecnologica, essendo culturale, è in una misura notevole guidata dalle nostre scelte, le quali – secondo De Biase e Pievani – dipendono dalle nostre narrazioni. Se noi ci «raccontiamo il futuro» come dimensione di mero profitto economico, per esempio, orienteremo in un certo modo l’evoluzione tecnologica; se, invece, ci «raccontiamo il futuro» immaginandolo come luogo di benessere condiviso, orienteremo l’evoluzione tecnologica in un altro modo. Come saremo, dunque, ci dice che il futuro è imprevedibile ma che il possibile adiacente dipende da due fattori: le possibilità intrinseche delle tecnologie usate oggi e dai valori che vogliamo perseguire nel futuro.