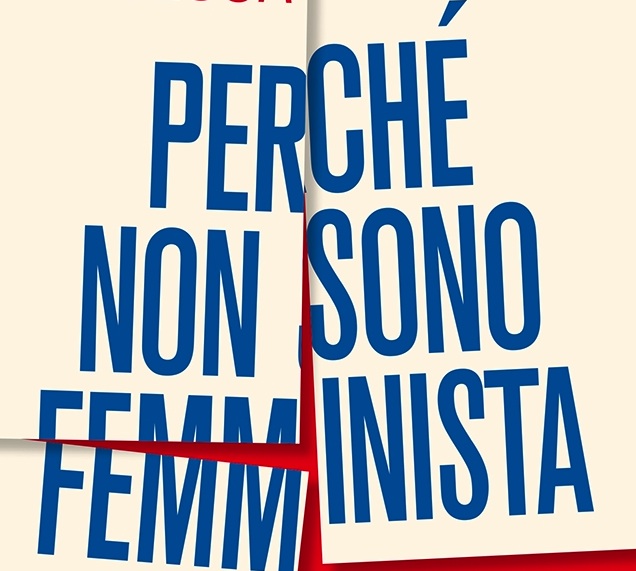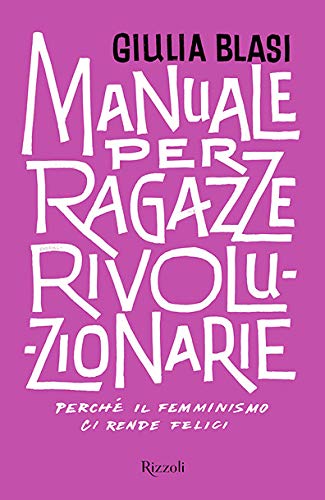Nell’anno appena finito il femminismo è stato alla ribalta della cronaca, a causa del #metoo contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro, in particolare nel cinema. Si è parlato allora di una quarta ondata del movimento delle donne, si è detto però anche che la denuncia da parte di una sola categoria, quella delle attrici, non essendo inclusiva non intacca in alcun modo il dramma della discriminazione sessuale in ambito lavorativo e ancor meno la tragedia della violenza sulle donne. Quindi? Per cercare qualche punto di approdo da cui guardare alla condizione del femminismo oggi può essere utile la lettura parallela di due testi pubblicati nel 2018 e che, almeno a giudicare dal titolo, pur parlando di femminismo, non hanno nulla in comune: Perché non sono femminista di Jessa Crispin e Manuale per ragazze rivoluzionarie di Giulia Blasi.
Intanto, Giulia Blasi, promotrice della campagna #quellavoltache, cita il testo di Jessa Crispin e in effetti i due libri muovono, almeno apparentemente, da un punto di vista condiviso: rinnegare il femminismo mainstream, tradotto nella versione italiana del testo di Crispin con l’espressione «femminismo universale» e definito da Blasi «femminismo pop». Le due autrici, infatti, si scagliano contro l’idea che essere femministe significhi «un generico richiamo alla forza delle ragazze» o «un sistema di auto-aiuto, un’altra voce che dice alle donne che dovrebbero avere orgasmi migliori, fare più soldi, aumentare il loro quoziente di felicità…».
Il modo, però, in cui Blasi e Crispin nei fatti si oppongono al femminismo patinato e offrono la loro visione alternativa del femminismo appare molto diverso. In primo luogo, l’autrice statunitense prende le distanze dall’uso dell’espressione mascolinità tossica: «nessuno parla di femminilità tossica, eppure esiste, a giudicare da certi atteggiamenti femminili nella cultura contemporanea. Ma preferiamo parlare della mascolinità tossica come una cosa innata, mentre tutti i problemi comportamentali femminili sarebbero generati dalla società. È comodo». L’autrice statunitense rifiuta l’idea che si possa fare riferimento ad atteggiamenti causati dal testosterone, quando nel caso in cui alcuni comportamenti vengano imputati agli estrogeni, reagiamo con sdegno e orrore. Blasi invece fa ricorso a questa espressione, ma non la attribuisce a questioni di ordine naturale: «mascolinità tossica, quel lato della cultura che incoraggia gli uomini a essere aggressivi, arroganti e prevaricanti». Di nuovo, quindi, una contrapposizione fra i due testi solo apparente, in quanto l’autrice italiana connota la mascolinità tossica come culturale e non dovuta a questioni ormonali.
La cifra davvero diversa dei due approcci è forse la visione politica che sta alla base dei due testi: se entrambe le autrici, come detto, si definiscono fin da subito contrarie allo sdoganamento di un femminismo di facciata, di look si potrebbe dire, Crispin lo fa inserendo questa versione del femminismo nello scenario del neo-liberismo: «un’amministratrice delegata può alzarsi fieramente in piedi e proclamare la sua fede al femminismo continuando a subappaltare le commesse a fabbriche in cui donne e bambini lavorano in condizione di schiavitù». Va subito precisato che anche Blasi definisce il femminismo radicale anticapitalista, però poi scrive: «dobbiamo invadere il mercato, un pezzo alla volta, con qualunque mezzo». Di fatto, seppur accuratamente eviti la parola, alcuni passaggi del testo di Blasi sono un invito al famoso o famigerato empowerment femminile, rifuggito come la peste proprio da Crispin.
L’autrice statunitense appoggia tutta la sua riflessione sulla convinzione profonda che il femminismo come movimento radicale, piuttosto che diventare universale e perdere quindi la sua carica rivoluzionaria, debba riappropriarsene e immetterla nella società. Per questo, in primo luogo il femminismo nella visione di Crispin deve essere anticapitalista, contrapporsi proprio alla legge del mercato o meglio al fatto che quella del mercato sia l’unica legge universale, che governa, cioè, il mondo intero. Da qui deriva che il femminismo debba, per Crispin, combattere contro le strutture sociali che derivano e sostengono il neo-liberismo: l’individualismo e la sopravvalutazione della libertà personale intesa come puro egoismo e dall’altra parte l’esaltazione dell’amore di coppia come unica via alla felicità. «Ci siamo illuse […] che mentre il matrimonio nel suo insieme era ovviamente problematico, il singolo matrimonio poteva essere rinegoziato […] Ma non dovrebbe spettare a una singola donna cancellare secoli, millenni di oppressione e controllo. Il problema non è l’esistenza dell’amore, ma il suo primato». Va però precisato che il testo di Blasi se non ha questa stessa profondità di analisi, ha un altro obiettivo e un altro target: è un manuale, una guida, anche pratica, per ragazze. Al suo interno vi si trovano consigli molto utili, per esempio per la fruizione dei social media, sia in termini di difesa da attacchi misogini sia per lanciare e aumentare l’efficacia di una campagna femminista online e non solo: si tratta di questioni cruciali e di grande attualità. La sezione, poi, delle risposte alle domande frequenti è efficace, chiara e andrebbe letta a scuola.
Tirare le somme non è così semplice e soprattutto non serve. Infatti, c’è un’esigenza reale che la radicalità del femminismo contagi la politica perché essa viri verso pratiche antirazziste, di giustizia sociale e sostenibilità e ci sono urgenza e necessità di dare alle ragazze e alle donne gli strumenti quotidiani per contrapporsi ad abusi di potere, discriminazioni e violenze. Non si tratta di ecumenismo, ma della consapevolezza, propria alle femministe radicali che fortunatamente esistono, che femminismi è una parola e una pratica plurale.