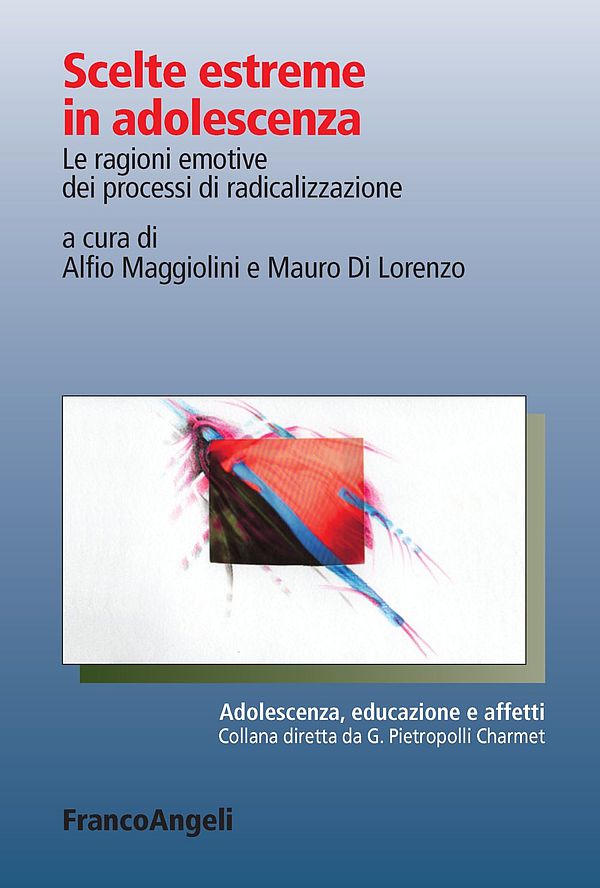L’adolescenza è l’età dell’intransigenza e delle emozioni forti che possono portare sulla cattiva strada. C’è chi si radicalizza, chi si isola drasticamente, chi rifiuta il cibo, chi ingaggia sfide mortali. Agli aspetti più delicati di questa fase della vita è dedicata una raccolta di testi appena pubblicata: Scelte estreme in adolescenza. Le ragioni emotive dei processi di radicalizzazione (Franco Angeli). Curatore del volume, insieme a Mauro Di Lorenzo, è Alfio Maggiolini, psicoterapeuta, docente di Psicologia del ciclo di vita all’Università di Milano-Bicocca e direttore della Scuola di specializzazione Minotauro.
Professore Maggiolini, perché l’adolescenza è l’età in cui si rischia di compiere scelte estreme?
Ci sono vari modi di rispondere a questa domanda. Il primo è che l’adolescente tende a pensare seguendo gli impulsi, non la razionalità, perché vive in un’età in cui c’è un’espansione delle emozioni. Ma questa non è l’unica motivazione che può indurre un giovane a compiere scelte estreme. Ci sono anche il rapporto con il gruppo, l’attivazione di decisioni rischiose e di comportamenti orientati alla ricerca di sensazioni forti, la deresponsabilizzazione delle proprie azioni. Anna Freud diceva che l’estremismo è un sistema di difesa: l’adolescente ha paura delle proprie pulsioni, assume un’ottica intransigente nel giudicare gli altri e questa intransigenza può essere alla base dell’estremismo. Nel nostro libro ci è sembrato interessante analizzare come l’adolescente cerchi di costruire un ideale senza il coinvolgimento di punti di vista diversi dai suoi. È una propensione alle verità assolute, ad assumere il proprio sguardo sul mondo come unico possibile contro quello degli altri, in una dittatura dei valori.
Che cosa si intende esattamente per soluzioni radicali e gesti estremi?
Durante l’adolescenza ci possono essere comportamenti eccessivi estemporanei, che anche se ripetuti sono diversi da quelli che si aggregano attorno a sistemi di credenze cercate e trovate nel mondo esterno. I gesti di cui parliamo nel libro non sono episodici: vanno dal disturbo alimentare, al fanatismo nel calcio, all’adesione a gruppi radicalizzati di tipo violento o terroristico, a un rapporto con la morte vista come un fatto esaltante e positivo. In questi casi, i comportamenti estremi sono sostenuti da credenze collettive. Entro nel merito prendendo come esempio i problemi alimentari. Ci può essere una fase in cui una ragazza non mangia, ma ancora non ha costruito una mentalità attorno al digiuno. Può trattarsi di una condizione iniziale che poi rientra oppure può diventare più elaborata se l’adolescente crea un sistema di giustificazioni non solo autoprodotto ma culturalmente condiviso, che cioè legittima collettivamente il suo comportamento.
In che modo internet facilita il diffondersi di scelte radicali tra i teenager?
Internet viene usato per cercare idee e subculture che confermino le credenze che si hanno già. È come se facesse da amplificatore. Va tenuto in considerazione che il disagio di chi si radicalizza non è una conseguenza di internet, esiste da prima e può essere causato da diversi fattori: senso di ingiustizia, anche sociale, per qualcosa che non va, con la voglia di reagire e combattere. Internet dà conferme e offre soluzioni, potenzia e moltiplica le possibilità, fornisce le parole e i modi per esprimere il disagio. Il meccanismo attuato dalla rete virtuale, sicuramente potente, non è nuovo. Una volta era più difficile trovare subito delle affinità, ma comunque esistevano le subculture giovanili, i sottogruppi ispirati da un ideale di quello che fosse giusto o sbagliato, che avevano i loro canali, le radio ad esempio.
Quali sono i segnali di allarme per chi ha un figlio o una figlia che si sta radicalizzando?
Ci sono dei segnali precisi, l’impulsività non è sufficiente a fare pensare al processo di radicalizzazione. L’estremismo è tipico degli adolescenti, tutti possono sembrare intransigenti e fissati su qualcosa. La preoccupazione deve cominciare quando si vede che il figlio è impermeabile a ogni riflessione e comincia a organizzare il proprio comportamento e l’idea di sé attorno a qualcosa di specifico. È importante che i genitori non rispondano all’intransigenza con altra intransigenza, perché altrimenti accentuano il meccanismo. Bisogna che tengano conto della pluralità dei punti di vista, delle ragioni del teenager, che cerchino di empatizzare. È corretto sottolineare quello che è sbagliato, ma capendo che c’è comunque un pezzo di verità nei discorsi dell’altro. Va poi considerato che può succedere che l’adolescente arrivi a certe soluzioni a causa di dinamiche familiari. Spesso la radicalizzazione è legata alla storia e al mito familiare, a ciò che ha caratterizzato l’identità del padre e della madre. Non a caso è spesso rintracciabile un bisogno di riscatto sociale di sé e dei propri cari, la vendetta per un padre umiliato, ad esempio.
Quando bisogna intervenire?
L’adolescenza è un periodo lungo. In teoria comincia dai dodici o tredici anni fino ai diciotto, ma se si considera la fase della giovane età adulta si protrae fino ai venticinque. Possiamo dire che, nel complesso, duri oltre un decennio. Nella prima parte, in cui prevalgono gli aspetti impulsivi, il teenager è ancora molto legato ai genitori, dipende da loro, che restano interlocutori autorevoli anche se contestati. Con il passare degli anni il rapporto cambia, subentra un’identificazione con il gruppo di riferimento, che diventa centrale, e i livelli di autonomia si fanno più accentuati. Quindi lo spazio di azione degli adulti diminuisce. In una prospettiva preventiva, bisogna intervenire presto.
La scuola e la società in generale sono importanti per evitare i processi di radicalizzazione. In che modo?
È molto importante che a scuola non sia proposto un modello unico di socializzazione, ma vengano forniti strumenti per sviluppare la capacità di assumere visioni plurali. È fondamentale che si impari a convivere con gli altri, nonostante le differenze. E va coltivata l’idea che dentro di sé possano coesistere molti aspetti contrastanti. Ci vuole un’educazione democratica, nel senso più autentico del termine, che prepari alla complessità del mondo.