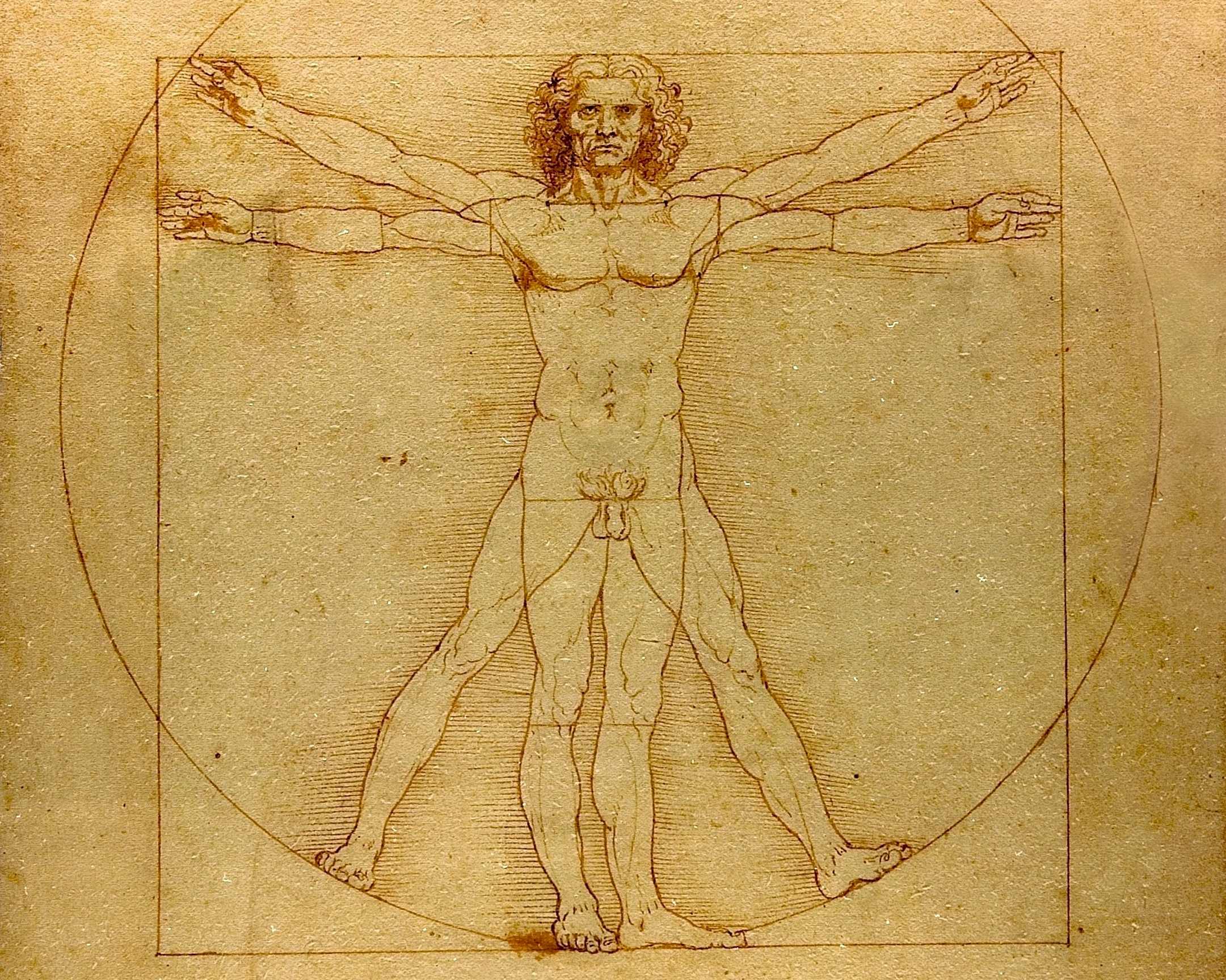Il termine «misura» in relazione all’uomo è stato introdotto dal filosofo greco Protagora che, con quella parola, intendeva sottolineare come in ogni valutazione umana, alla fine, prevalga sempre quella che oggi chiameremmo soggettività, cioè la diversità delle premesse culturali, delle capacità e delle motivazioni che ognuno di noi porta con sé. L’espressione «a misura d’uomo» si è poi largamente diffusa e oggi può essere adottata in vari contesti anche diversi da quelli segnalati da Protagora.
Uno di questi ha a che fare con il rapporto che l’uomo ha con la natura da un lato e le stesse cose umane dall’altro. Per avvicinarci al primo contesto, quello del rapporto con la natura, si pensi all’Arca di Noé, nella quale il patriarca aveva sistemato, per salvarli dal diluvio universale, animali di tutte le specie, alcune migliaia. Tutti noi saremmo in grado di riconoscere molti degli animali posti in salvo perché, anche ignorandone il nome scientifico, abbiamo avuto mille occasioni di vederli dal vivo o in qualche immagine. La stessa cosa aveva fatto Noè, ovviamente, ma sarebbe vano cercare nell’Arca molte specie non osservabili dall’uomo e, a quei tempi, ben lungi dall’essere conosciute, come i batteri ed altri organismi microscopici, condannati dunque a perire.
Il fatto è che l’uomo deve fare i conti con «strumenti» naturali di osservazione del mondo piuttosto limitati. Vista e udito, come del resto gli altri apparati sensori, consentono di vedere o udire i fenomeni con essi compatibili entro intervalli molto ristretti rispetto alla loro ampiezza naturale. Molti animali possiedono capacità diverse dalle nostre, come è per le api o vari uccelli che vedono l’ultravioletto o i cani che, come è noto, riescono ad udire, a differenza nostra, gli ultrasuoni. È sempre raccomandabile per chiunque dare un’occhiata con il microscopio alle cose anche le più apparentemente semplici e magari ritenute banali, come una goccia d’acqua di pozzanghera, per constatare come il mondo che vediamo ogni giorno possieda una profondità di livelli che i nostri occhi non ci permettono di osservare. La stessa raccomandazione vale, va da sé, per il telescopio e per mille altri dispositivi, come i rilevatori di radioattività o di vari tipi di gas.
Diretta conseguenza di tutto questo è che il mondo naturale, così come ci appare, non è il mondo definitivo della natura ma solo lo scenario che i nostri sensi ci consentono di apprezzare, cioè, appunto, il mondo «a misura d’uomo». La percezione del mondo è insomma strettamente dipendente dalla specie animale e quella umana è solo una fra le tante. Lo stesso concetto di ambiente non può essere considerato come qualcosa di assoluto come se gli uomini, con un po’ di presunzione, avessero scoperto la sua «vera» e ultimativa definizione, sulla scorta di una visione antropocentrica, che, cioè, pone il principio della «misura d’uomo» alla base di ogni possibile valutazione. Ogni variazione ambientale, in effetti, produce, ed ha già prodotto infinite volte, nel corso degli ultimi milioni di anni, situazioni vantaggiose per alcune specie e svantaggiose per altre. In sintesi, una bella giornata o un bel paesaggio per l’uomo possono essere una pessima giornata o una vista minacciosa per una specie diversa.
Nelle vicende umane e sociali le cose non cambiano. Qui però Protagora torna pienamente protagonista, nel senso che la varietà delle nostre stime e dei nostri giudizi, non dipende solo, ed eventualmente, dalle nostre limitazioni fisiologiche, ma anche dalla nostra decisione di prendere spunto da una certa premessa piuttosto che da un’altra. La «misura d’uomo» in questo caso si può comunque esprimere come l’impossibilità, da parte di ognuno di noi, di tenere simultaneamente in considerazione tutti i profili dai quali sarebbe possibile descrivere un evento o un oggetto. È il caso di un insegnante il quale, nel valutare il rendimento scolastico, non può che partire dal grado di attenzione, lo scrupolo o la partecipazione alle lezioni mostrate dall’allievo in relazione alla sua abilità nello svolgere i compiti a lui assegnati. L’insegnante, in effetti, non è in grado di tenere in considerazione altri aspetti, psicologici, familiari, di salute personale, noti e non noti, pervenendo così ad un giudizio globale che colga la realtà totale dello studente. Una realtà completa che, a ben vedere, sfugge a lui stesso.
Nella valutazione delle vicende politiche o economiche il peso della «misura d’uomo» è poi quanto mai evidente. La situazione economica complessiva di una società può essere infatti descritta prendendo le mosse da decine di profili diversi fra loro e solo raramente questi sono del tutto convergenti, come durante una crisi generale o una fase di sviluppo prorompente. In tutti gli altri casi, che sono i più numerosi, nessun esperto è in grado di «osservare» e dunque di tenere in considerazione tutte le variabili in gioco.
Anche in tribunale, del resto, si ricorre al criterio della testimonianza nella speranza che, dall’esame di un evento colto da vari punti di vista, possa emergere una descrizione sufficientemente accurata e utile. Inutile dire, infine, che nelle prese di posizione politiche si assiste da sempre ad un’ulteriore esplosione individuale dei presupposti secondo i quali può essere descritta la realtà sociale. Poiché nella vita politica, delle istituzioni e dei gruppi umani portatori di ideali politici o di interessi, l’obiettivo pressoché invariabilmente è indicato nel «bene comune», gli uomini, con la loro «misura», sono posti inevitabilmente in contesti conflittuali nei quali ognuno pretende di avere scoperto la più genuina essenza della natura umana e dei suoi bisogni.
Per questo, cioè proprio a causa del carattere inesorabilmente limitato di qualsiasi nostra capacità di stima dei fatti, la democrazia è l’unico sistema prudentemente «a misura d’uomo». Purché la maggioranza non pensi che la propria visione delle cose, per il solo fatto di essere prevalente, debba essere riconosciuta come «la verità», poiché essa è unicamente la provvisoria rappresentazione di una realtà che può mutare, e di fatto muta, assieme al cambiamento dei nostri «punti di vista».