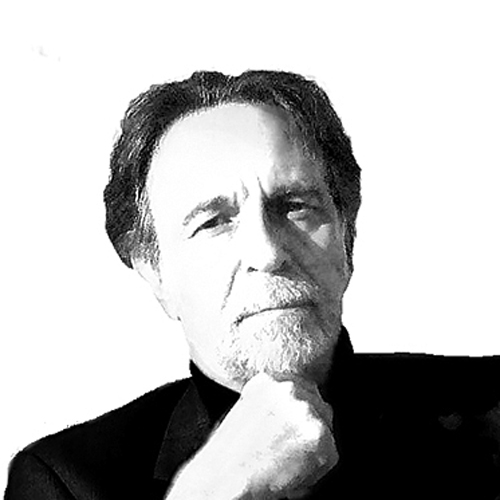Tra le tante cose che un tempo ricorrevano puntualmente ogni fine d’anno e che oggi vanno progressivamente in disuso ci sono gli almanacchi, i lunari. Ricordi d’infanzia mi riportano alla mente venditori ambulanti che nel mese di dicembre offrivano per strada questi strani miscugli di cognizioni astronomiche, di previsioni e di oroscopi per l’anno imminente, insieme a ricette di cucina, storielle, immagini dipinte. Anche nelle edicole i lunari troneggiavano sopra i quotidiani e le riviste, ed erano evidentemente appetiti da un pubblico folto. E poi passava regolarmente di casa in casa il frate questuante (il «fra cercott», come si diceva), con un almanacco speciale in cui – oltre alle fasi della luna – erano messe in rilievo le festività religiose, i santi del giorno e le preghiere più idonee per le diverse circostanze. Non a caso uno dei calendari più diffusi portava il titolo di Frate Indovino: sulla copertina campeggiava un frate con il saio, la lunga tunica dei cappuccini molto popolare e molto amata dalla gente. Ma anche il saio non capita più di vederlo in giro per le strade.
Per lungo tempo gli almanacchi hanno esercitato un fascino potente: alcuni storici hanno appurato che nella Francia del Settecento i lunari occupavano il secondo posto in quella che oggi sarebbe la graduatoria dei best seller, subito dopo la letteratura religiosa. Anche negli Stati italiani dello stesso periodo la loro diffusione (dovuta anche al basso prezzo) era tale che l’illuminista Pietro Verri vi vide un potenziale strumento per l’educazione della società civile; ma a suo avviso, per perseguire questo scopo, l’almanacco avrebbe dovuto eliminare ogni pronostico astrologico, causa di « molti errori nella coltura delle terre e de’ giardini, e persino talvolta dei delitti per la seduzione delle cabale, colle quali lusingano di far acquistar ricchezza».
Inutile dire che, con la rinuncia a questi spizzichi di esoterismo profetico, l’almanacco avrebbe perso gran parte della sua attrattiva. Certo, una qualche utilità il fascicolo poteva sempre averla, dato che indicava le fasi lunari sulle quali si basava gran parte dell’attività agricola del passato (per il contadino l’anno lunare era assai più importante di quello solare, e dunque occorreva conoscere lo snodarsi delle lunazioni, il ciclo dei noviluni e dei pleniluni); e poi l’almanacco segnalava le feste di precetto, durante le quali il lavoro era severamente proibito. Ma, al di là di queste utilità pratiche, gli uomini vogliono pur sempre sognare, sperare, avventurarsi nel futuro: i lunari servivano a questo.
È ancora così? Verrebbe quasi da pensare che l’età contemporanea abbia realizzato il pieno trionfo della razionalità e della scienza, così da mettere definitivamente in disparte gli oracoli, gli indovini e i loro responsi relativi al futuro. Ma mi risulta che astrologi, cartomanti, chiromanti e oroscopi godono tutt’ora di un largo seguito – magari titubante di fronte al responso, ma pur sempre desideroso di sbirciare nel futuro. No, il declino degli almanacchi è certo dovuto al mutamento storico e culturale; ma il bisogno umano di scrutare nel buio del tempo a venire non è scomparso.
Certo, oggi è più difficile prestare ciecamente fede agli indovini: la scienza e la razionalità accresciuta inducono a un ragionevole scetticismo, e in fondo quasi tutti condividiamo quello che il fisico Niels Bohr diceva con garbata ironia: «Fare previsioni è una cosa molto difficile, specialmente se riguardano il futuro». Anche i lunari, con le loro fasi della Luna, sono abbondantemente superati dalla tecnologia moderna: nei quotidiani e in Rete si possono sempre trovare l’ora dell’alba e quella del tramonto, le previsioni meteorologiche, le fasi lunari. E la Luna, del resto, non è più la divinità misteriosa delle culture antiche e neppure l’enigmatico astro errante del Leopardi: le foto dei suoi crateri, l’impronta lasciata nella sua polvere dal primo uomo che vi è disceso hanno annullato il suo fascino misterioso. Ma, forse, proprio per questo aveva ragione Michele Ainis quando, pochi anni fa, documentava una nuova tendenza alla credulità: «Non c’è più niente in cui credere davvero, e allora tanto vale credere a tutto. Per conseguenza è nato un uomo più superstizioso e credulone di quello medievale. Maghi, cartomanti, fattucchiere non hanno mai fatto così tanti affari».
E allora, perché non credere anche al valore propiziatorio degli auguri? Dunque, ai miei eventuali lettori, buon anno!