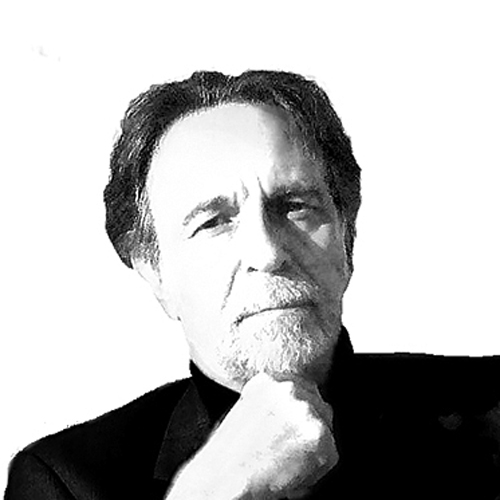Un breve saggio di Sigmund Freud, scritto nel 1914, ha per titolo Psicologia del ginnasiale: rileggerlo oggi fa un effetto curioso, tanto sa di passato. Il ginnasio frequentato da Freud fra il 1865 e il 1873 riuniva i livelli d’istruzione che oggi, per noi, comprendono la scuola media e il liceo, in quel tratto di vita che corrisponde all’adolescenza. Nei ricordi freudiani dell’esperienza ginnasiale spiccano in particolare i rapporti con i docenti: figure d’autorità indiscussa, a quel tempo, che attiravano l’attenzione del giovane Freud e dei suoi compagni al punto che, come si legge nel testo freudiano, era difficile stabilire se fosse maggiore l’interesse per le scienze che venivano insegnate oppure per la persona dell’insegnante.
Il docente era allora un’autorità indiscussa: risvegliava nel ragazzo la figura del padre, il protettore e la guida verso un futuro ancora solo sognato. Beninteso, l’autorità non può essere – né nel genitore, né nell’insegnante – un autoritarismo dogmatico o violento, e neppure un permissivismo indifferente: un padre può perdere la sua autorità sia picchiando il figlio, sia mettendosi a discutere interminabilmente con lui; l’autorevolezza non appartiene né a un tiranno, né a un uguale. Quando un adulto è autorevole induce spontaneamente all’obbedienza, perché in primo luogo suscita rispetto; e il rispetto – per la persona e per la carica che ricopre – è stato sempre il fondamento dell’autorità. Ecco perché ogni educatore non può commettere ingiustizie, mostrare parzialità, cadere nel ridicolo: il nemico peggiore dell’autorità è il disprezzo e la via più sicura per distruggere l’autorità è deriderla. È quanto avviene sempre più spesso oggi: si legge, ad esempio, di studenti che filmano di nascosto un insegnante mentre chiede inutilmente il silenzio in aula; e poi il filmato derisorio finisce in rete.
Al tempo di Freud, e poi ancora per decenni, l’insegnante fu una figura d’autorità per i giovani studenti; e come il genitore tracciava al figlio la via verso la crescita interiore, così anche l’autorevolezza del docente, riprendendo l’educazione familiare, guidava il ragazzo verso un corretto comportamento adulto. Ma ho l’impressione che questa prassi educativa appartenga sempre più al passato. Esiste ancora l’autorità? C’è chi sostiene che è finita: ad esempio, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet nel suo libro L’autorità perduta. In questo libro, apparso pochi anni or sono, l’autore conduce una critica severa contro il permissivismo e la condiscendenza eccessiva degli educatori nei confronti dei giovani; disegna un quadro desolante di bambini maleducati, adolescenti che rifiutano ogni regola, ragazzi apatici che pensano solo a godere del presente senza impegnarsi a costruire un futuro. E tutto, questo – dice Crepet – perché i genitori rinunciano alla loro responsabilità educativa, accondiscendono a ogni desiderio dei figli pur di evitare conflitti: ottengono dunque una sorta di «pace sociale» al costo di appiattire i giovani in un presente senza futuro.
In questo modo l’autorità svanisce, perché – come ebbe a scrivere quella donna straordinaria che fu la filosofa Hannah Arendt – non ci può essere autorità senza responsabilità: «Che gli adulti abbiano voluto disfarsi dell’autorità significa solo questo: essi rifiutano di assumersi la responsabilità del mondo in cui hanno introdotto i loro figli».
L’etimologia della parola «autorità» (auctoritas) spiega che il termine significa, letteralmente, «far crescere»: il giovane si avvia alla condizione adulta grazie a figure d’autorevolezza, assumendone le regole e imitandone il comportamento. Ma la famiglia e la scuola avvertono oggi cambiamenti radicali: entrambe le istituzioni educative sono in crisi. Il processo è in atto da tempo, ma progressivamente le incrinature si dilatano in squarci sempre più vistosi. Scriveva ancora la Arendt che «la moderna prassi pedagogica ha perfino sperimentato questo assurdo modo di trattare i bambini come una minoranza oppressa da liberare». Questa affermazione risale agli anni Sessanta del secolo scorso: da allora la pedagogia si è lanciata alla grande nella direzione deprecata dalla filosofa.
Ma è forse inevitabile che sia così: la scuola riflette l’evoluzione della società, si accoda, e la società d’oggi si fa sempre più libertaria, populista, permissiva; il cittadino rivendica sempre più diritti, preferisce non pensare che esistono anche doveri. In questo contesto difficilmente l’autorità potrà sopravvivere.