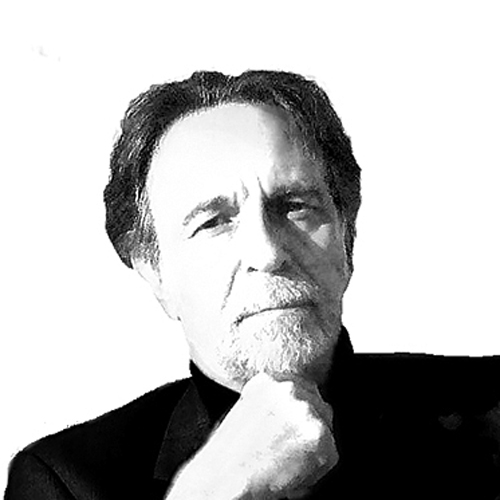«La pubblicità è l’anima del commercio»: questo detto di vecchia data è oggi più vero che mai. Se in passato la pubblicità appariva nelle pagine dei giornali, alla radio, alla televisione o in cartelloni affissi nelle strade, oggi è soprattutto presente in Rete ed è addirittura fatta su misura dell’individuo: se io compero un libro tramite Internet, quando cambio sito mi appaiono sullo schermo offerte di altri prodotti analoghi «che potrebbero interessarmi». La pubblicità mi osserva, mi studia, mi lusinga e mi segue da presso. È diventata anche la mia seconda anima, un’ombra che riappare ogni volta che mi connetto in Rete.
Be’, per lo meno c’è un ambito dove l’anima resiste e sussiste. Le odierne neuroscienze confutano e abbattono sempre più la plurimillenaria convinzione dell’esistenza di un’anima umana immateriale, spiegando che tutto quel che un tempo le si attribuiva – pensiero, affetti, emozioni, immaginazione – si trova localizzato nel cervello; ma l’«anima del commercio» è invece dotata di una capacità di sopravvivenza sempre più forte. E, in effetti, sempre di più gli uomini si affidano a lei.
Le ragioni di questo crescente successo sono molteplici: di certo, la pubblicità commerciale induce desideri e spinge a soddisfarli. Ma anche l’emergere e il prorompere del desiderio sono in genere determinati da altri meccanismi ancestrali che fanno parte della nostra natura biologica. L’uomo è un animale mimetico: la sua naturale tendenza lo porta ad imitare il comportamento altrui, soprattutto quando l’oggetto d’imitazione è un campione sportivo, un leader, un attore di successo. È ovvio, dunque, che la pubblicità si serva di simili figure carismatiche: se un atleta famoso, un divo cinematografico, un miliardario da rotocalco indossano un certo abbigliamento, usano un certo smartphone, bevono certe bevande, è normale che una folla innumerevole si accodi. L’imitazione illude di essere simili al modello, infonde la soddisfazione di innalzarsi al suo stesso livello e di essere ammirati come lui; e quando molti esibiranno per la strada o al bar quella particolare acconciatura o quella nuova tecnologia saranno sempre più imitati via via che il loro numero cresce, perché il non adeguarsi alla moda produce un senso di emarginazione frustrante. Ma anche l’attrazione della moda ha il suo fondamento psicologico innato, come è evidente già nella prima infanzia: un bambino prende in mano un giocattolo; un altro bambino, seduto lì accanto, vuole lo stesso giocattolo, anche se nella stanza ce ne sono molti altri. È il fenomeno che gli psicologi chiamano «desiderio mimetico», per cui siamo indotti a imitare desiderando quello che l’altro desidera.
Fin qui, dunque, il naturale fondamento psicologico che sorregge la pubblicità commerciale. Ma quello che è relativamente nuovo e inquietante è che la strategia pubblicitaria dilaga e pervade ormai anche ambiti molto diversi, come – e soprattutto – la politica. S’intende che tutti gli uomini di potere hanno sempre fatto ricorso alla propaganda per attrarre le masse: i mezzi di propaganda potevano essere, in passato, sfilare per le strade su un carro imperiale, costruire palazzi splendidi e costosi, arringare il popolo con discorsi infocati e magari menzogneri – come nel caso di Mussolini e Hitler e Stalin. Ma oggi, direi, la propaganda ha lasciato il posto alla pubblicità: il politico che vuole avere un seguito deve essere onnipresente in Rete, alle cerimonie e alle feste, attirare la simpatia della gente, apparire come una star – insomma, assurgere a modello da imitare; e poi, soprattutto, promettere che «se acquisterai questo prodotto (questo indirizzo politico) sarai felice».
Carl Gustav Jung l’aveva detto chiaramente decenni fa: «La società è organizzata non tanto dalla legge quanto dalla tendenza all’imitazione». È per questo che ogni educatore sa bene che, se vuole davvero educare, dev’essere d’esempio. Come potrebbe, un insegnante, esigere disciplina e impegno se lui stesso si mostra annoiato, non prepara una lezione, non cura la correttezza e il rigore? Non è certo sbraitando o facendo predicozzi che si ottiene d’essere imitati, ma mostrandosi coerenti, fornendo buoni esempi di comportamento.
Già: ma se l’educatore a sua volta prende esempio non da figure esemplari, ma da modelli pubblicitari, non penserà di avere di fronte a sé giovani anime da nutrire di cultura e da guidare lungo un percorso spirituale e morale, ma solo cervelli golosi da imbottire con giochetti divertenti.