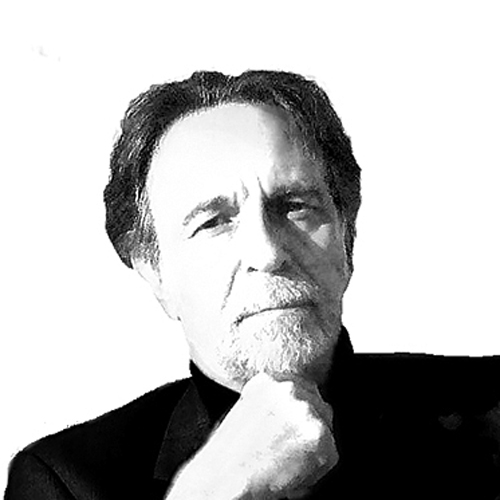Dalla finestra aperta entra alto il richiamo: «Amore!». Capisco, dalla voce infantile che risponde, che una mamma ha chiamato il suo bambino. Sono un po’ deluso: per un attimo avevo pensato che qualcuna chiamasse me. Ma mi ci sto abituando: per la strada sempre più spesso sento chiamare: «Amooore… Dove sei?». E – escludendo che sia il lamento di una povera solitaria in cerca d’affetto – ne concludo che è sempre una donna che richiama un figlio.
Che c’è di strano? Nulla, ormai. Ma per me, che sono cresciuto in un altro millennio, c’è voluto del tempo per abituarmi alla nuova moda. Da bambino sentivo i genitori chiamare i figli per nome: Pietro, Teresa, Paolino… Qualche volta, magari, anche: «Balòss, indùa ta séet?». Ma oggi, che si tratti di Giovanna o Maria o Giuseppe, sono tutti «Amore». Ai tempi nostri l’amore trionfa.
Almeno sulle bocche di tutti. Perché poi si leggono dati contradditori che sollevano non pochi dubbi. Il matrimonio, ad esempio, è notoriamente un’istituzione in crisi: aumenta il numero dei divorzi e delle separazioni, cala costantemente quello delle coppie che convolano a nozze, e sempre di più sono quelle che preferiscono le «unioni di fatto». Le violenze domestiche raggiungono quote preoccupanti; le manifestazioni di devianza giovanile – dalle forme di dipendenza a quelle di aggressività, dai vandalismi al cyberbullismo – sono quotidianamente segnalate dai media. Insomma, sia le relazioni coniugali, sia quelle parentali risultano alterate e disfunzionali rispetto a quelle tradizionali dell’istituzione familiare.
La famiglia è malata. Non tutte, ovviamente, e per fortuna molte ancora sono in buona salute. Ma è l’istituzione ad essere malata: La morte della famiglia era già annunciata, negli anni Settanta, da David Cooper in un suo libro di questo titolo. Morta – o moribonda – è la famiglia tradizionale, quella fondata sull’antica distinzione dei ruoli, il marito capofamiglia e la moglie casalinga. Naturalmente, anche i differenti ruoli educativi sono mutati. Nella seconda metà del Settecento, scrivendo il libro che sarà alle origini della pedagogia moderna, l’Émile, Rousseau sosteneva che, come la vera nutrice è la madre, così il vero precettore è il padre. La madre dispensa alimenti e tenerezza; il padre, quelle regole e quei precetti che avviano alla formazione morale. Non che il rapporto affettivo non competesse anche al padre, ma il bambino avvertiva comunque una differenza: la compagnia della madre era assidua, il padre rientrava la sera dal lavoro; e il padre era la figura d’autorità, quella a cui competeva l’approvazione o la riprovazione del comportamento infantile e – se del caso – la punizione. «Guarda che lo dico al papà!...», era la minaccia della madre per ricondurre il bambino all’obbedienza.
Tutto questo sembra avviato a dissolversi. L’autorità stessa è quasi svanita, non solo in famiglia, ma in tutti i settori: l’autorità politica? Ma il politico è solo un funzionario che ha il compito di risolvere i problemi di tutti i cittadini. L’autorità del docente? Ma il docente è ormai un compagno di giochi, oppure un rompiscatole che vuole costringerti a fare cose noiose che si ha tutto il diritto di rifiutare. Così, anche l’autorità del padre – e della madre – perde di fondamento, negata dall’egualitarismo imperante.
Eppure, di autorità, soprattutto nell’età della crescita, ci sarebbe pur sempre bisogno. Non è una tesi stravagante, dovuta alla nostalgia di tempi andati: lo dicono attenti studiosi per i quali l’errore più grave dei genitori d’oggi è quello di rinunciare ad esercitare la loro autorità. Silvia Vegetti Finzi, ad esempio, ha scritto che «la vera crisi alla quale si assiste oggi non è tanto quella fisiologica degli adolescenti, ma quella degli adulti che abdicano al loro ruolo».
Insomma, l’amore non basta. O meglio, non è un amore completo quello che ignora che ogni prassi educativa traccia anche un destino: avviare a vivere – questo è il compito di chi ama i giovani che gli sono affidati. E la vita impone regole, limiti, forza di volontà (non capricci). Ha imparato a vivere chi ha imparato a disciplinarsi.
Ma forse spesso, alla base di tanti errori educativi, c’è un equivoco. Chi parla continuamente d’amore vuole soprattutto riceverlo. Così a volte un genitore si fa troppo indulgente per timore di perdere l’amore dei figli. Sarà anche per questo che dovunque risuona la parola «Amore». Ma tutto questo amore che risuona nell’aria, nell’aria sembra anche svanire.