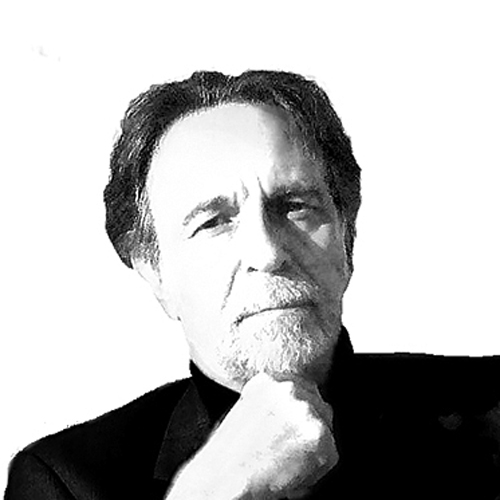Sempre più spesso ho l’impressione che la lettura di un giornale mi diventi via via più difficile: quasi ogni giorno incappo in parole inventate di sana pianta dal giornalista creativo, oppure usate con un valore semantico ben diverso da quello d’uso definito dal dizionario.
Una lingua, si sa, non è un monumento immutabile – a meno che sia una «lingua morta», di quelle che un tempo si studiavano al liceo. Una lingua viva evolve, si trasforma, si arricchisce (o s’impoverisce) di un lessico via via rinnovato, di parole importate da altre lingue e magari adattate alla pronuncia locale; ne sono prova i tanti «gallicismi» che da secoli costituiscono parole comuni del lessico italiano. Oggi è l’inglese a colonizzare le altre lingue, e si avvia a diventare la lingua comune internazionale, come per secoli sono stati il greco e il latino.
Nulla di strano, è un’evoluzione naturale e particolarmente comprensibile oggi, nell’era della globalizzazione. Ma quello che mi stupisce è che i giornalisti utilizzino parole del lessico inglese quando esiste l’equivalente italiano che dice esattamente la stessa cosa. E i politici non sono da meno – anzi, sono «da più»: da un lato, qui nel Ticino, si è sempre pronti a difendere la lingua italiana in quanto lingua nazionale e componente dell’identità elvetica; dall’altro, ci si dimentica che esistono parole italiane che andrebbero benissimo per esprimere la stessa idea senza dover ricorrere a forestierismi. Ad esempio: si decide di istituire un nuovo servizio pubblico, e il politico spiega l’utilità della nuova pensata ed elogia la celerità con la quale è stato approntato il progetto, ormai concluso; poi aggiunge che resta solo da definire la location. Ma, mi chiedo, la collocazione, o la destinazione non andrebbero altrettanto bene? Linguisticamente sì, ma è probabile che parlare di location accresca l’importanza del progetto – e anche la statura di chi lo difende.
Poi ci sono le parole gonfiate – prendendole dal lessico già esistente e conferendo loro arbitrariamente tutt’altro significato. Leggo, ad esempio, su un quotidiano ticinese, che un nuovo progetto di legge che si sta approntando incontra il favore di alcuni partiti, mentre ci sono altri partiti «ad avere qualche criticità». «Criticità»? Be’, sì, la parola esiste ma, a detta dei dizionari, significa semmai una situazione di crisi, o l’instabilità di un particolare momento; mentre, ragionandoci sopra, appare evidente che il giornalista intendeva dire che alcuni partiti mostrano dubbi, riserve, o sollevano critiche nei confronti del progetto. Ma certo, dire che i partiti hanno una «criticità» suona ben più altisonante che dire che «avanzano critiche»!
Un altro esempio: le «problematiche». Ormai, di problemi non ce n’è più – e qui uno potrebbe tirare un respiro di sollievo; ma no, perché al posto dei problemi oggi ci sono le «problematiche». Ora, «problematica» significa – o meglio significava, fino a ieri – un complesso, una pluralità di problemi strettamente connessi tra loro; ma se si tratta di ripulire una fognatura, o di aumentare una tariffa di parcheggio, sarebbe forse più giusto parlare di un problema che va esaminato. Invece no: quel che è certo è che le autorità competenti «si chineranno sulla problematica»; e, a giudicare da quante volte si sente e si legge questa frase nelle cronache quotidiane, c’è da pensare che i politici siano in gran forma per il costante esercizio fisioterapico di chinarsi (e risollevarsi) sulle problematiche che spuntano ogni giorno.
Così, dato l’inevitabile carattere contagioso delle frasi fatte e dei luoghi comuni, questa espressione è dilagata nei media e nei discorsi dei politici: e si può star certi che il politico, dopo essersi chinato sulla problematica, la esaminerà «a 360 gradi» (roba da far girare la testa!), per concludere magari che «bisognerà pensarci ancora un attimino» (dove anche «attimino» non va inteso nel significato letterale – ossia una frazione infinitesimale di tempo – ma si deve ipotizzare un intervallo di parecchi mesi, o magari anni, prima che la «problematica» sia risolta).
Così il linguaggio evolve di continuo, in attesa di sempre nuovi apporti di qualche innovatore; il che dimostra come sia sempre viva la «lingua di Dante». Ma, ora che ci penso: essendo «dante» il participio presente di «dare», è possibile e forse anche doveroso un aggiornamento in inglese; dunque, per procedere al passo con i tempi, suggerirei di chiamarla, d’ora innanzi, «la lingua di Giving».