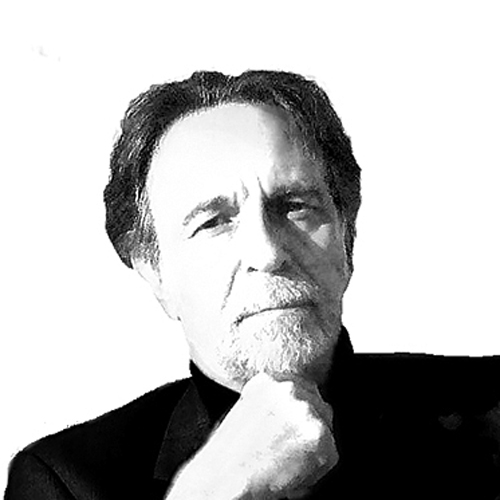È uscito di recente, per i tipi dell’editore Dadò, un libro dal titolo allettante: La Svizzera. Il Paese più felice del mondo. Non voglio riassumerne i contenuti, perché è un libro che vale la pena di leggere. Mi soffermo solo sui parametri presi in considerazione dall’autore, François Garçon (e utilizzati anche da studi internazionali), per giudicare il tasso di felicità elvetico come superiore a quello di tutti gli altri Paesi del mondo (almeno fino al 2015).
Dunque, elencando solo gli elementi principali, la Svizzera gode di: una libertà particolarmente ampia, determinata soprattutto da una democrazia diretta; un basso tasso di disoccupazione; salari elevati; un efficiente sistema previdenziale e sanitario; un ottimo sistema educativo. In base a questi fattori, si può condividere che la Svizzera sia il Paese del benessere – quello dove si sta bene, anzi, si sta meglio che negli altri. Quanto all’essere felici… be’, credo sia opportuno non confondere benessere e felicità. Giustamente Mauro Baranzini, nella sua Introduzione al volume, segnala che la Svizzera figura anche tra i Paesi con un alto tasso di suicidi giovanili e un elevato consumo di droghe. E questo è un dato che sembra contraddire vistosamente la pretesa di felicità nazionale. Soprattutto la crescita della tossicodipendenza tra i giovani sembra indicare che la ricerca della felicità non si traduce in un progetto di vita per il quale impegnarsi e lottare, ma viene affidata a deliranti fughe dalla realtà.
«Felicità», peraltro, è una parola grossa, e qui andrebbe ridimensionata: ancora una volta, mi pare, si tende a confondere l’essere con l’avere. Indubbiamente, là dove manca il cibo, dove non ci sono farmaci per combattere le malattie, dove la guerra infuria, la felicità è improbabile; ma quando si giunge ad avere quel che più conta – cibo, salute, sicurezza – emergono nuovi bisogni e la felicità è rinviata altrove. È quanto spiegava lo psicologo statunitense Abraham Maslow nel 1954, disegnando la sua famosa «piramide» dei bisogni: dapprima vengono quelli essenziali per la sopravvivenza dell’organismo; poi, una volta soddisfatti quelli, erompono i bisogni spirituali, dalla necessità d’affetti alla volontà di emergere e di accrescere la propria autostima. È un meccanismo che può ben essere illustrato dall’aforisma: «Chi si lamenta per il mal d’amore dovrebbe provare il mal di denti!». Quando i bisogni primari vengono soddisfatti, non per questo si è felici; nascono nuovi desideri e dunque nuove occasioni di infelicità. E oggi si sa che l’attuale civiltà dei consumi suscita desideri sempre nuovi e dunque provoca di conseguenza un’insoddisfazione perennemente rinnovata. Forse, proprio grazie alla generale condizione di benessere, agguantare fantasmi di felicità è diventato troppo facile: vuoi una cosa e te la compri. Ma troppo spesso ci si dimentica che il piacere d’aver realizzato un desiderio è proporzionale all’attesa e all’impegno impiegato per giungere allo scopo. L’oggetto del desiderio perde valore se non lo si è atteso, inseguito e infine raggiunto.
Non stupisce, dunque, che il Paese che può vantare un eccellente livello di benessere veda crescere nuove forme di disagio e di sofferenza: ai dati sui suicidi giovanili e sulla tossicodipendenza si può aggiungere quanto appurato nel 2012 dall’Ufficio federale di statistica, in base al quale una persona su cinque, in Svizzera, accusava problemi di sofferenza psichica; lo stesso studio evidenziava il costante aumento, in un periodo di quindici anni, del ricorso a prestazioni mediche per problemi psichici.
Questo, ovviamente, non fa della Svizzera un Paese infelice: la Confederazione continua ad essere una nazione eccellente, dove il benessere, la sicurezza, la pace, l’equità e tutto quanto può contribuire a migliorare la vita sono difesi saldamente. Ma queste condizioni materiali sono solo un’ottima premessa per chi voglia coltivare un suo sogno di felicità: certo, sono fonti di piacere, ma, come scriveva Alain, «il piacere regalato non mantiene mai quello che promette, mentre il piacere conquistato mantiene più di quanto prometta». È una consapevolezza antica che la felicità non vada cercata al di fuori di se stessi, ma nel perseguimento di una crescita interiore e nella volontà di costruire un sogno impegnandosi per renderlo reale. Per tornare ad Alain: «Una felicità capitata per caso non ci piace; ce la vogliamo costruire».