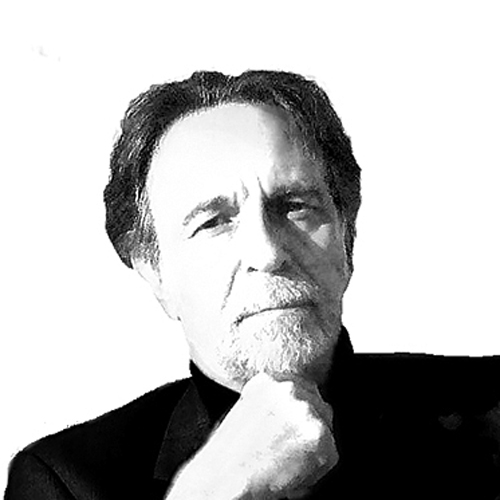«In principio era la Parola»: questo celebre inizio del Vangelo di Giovanni ha molto di vero anche in relazione con l’evoluzione dell’umanità. Non c’è dubbio che lo sviluppo di un linguaggio articolato consentì il grande balzo della civiltà e della cultura: la parola permise la trasmissione di tradizioni e conoscenze, la nascita di idee, la crescita dell’immaginazione.
Ma ora pare che la parola sia in declino: l’immagine prende sempre più il sopravvento, grazie alla sua facile immediatezza e alla forza emotiva; il lessico s’impoverisce, la competenza di lettura si riduce; e nella comunicazione multimediale le faccine e le icone sostituiscono le frasi. La difficoltà di molti giovani a leggere le pagine di un quotidiano è ben documentata in molti Paesi, compreso il nostro. Dunque, la parola e il discorso cedono il posto all’immagine e allo spettacolo.
«In principio era il Logos»: è questa la citazione corretta dell’inizio del Vangelo di Giovanni nell’originale greco; e nella lingua greca «logos» significa «parola», certo, ma anche «pensiero». Parola e pensiero, per i Greci, sono tutt’uno, perché senza un linguaggio evoluto non è possibile neppure un pensiero evoluto; il che è senz’altro vero ancor oggi. In tempi recenti, Ludwig Wittgenstein scrisse: «Il linguaggio non è soltanto il veicolo del pensiero; ne è anche il conducente». Ma se il pensiero perde il conducente, c’è da chiedersi dove andrà a sbattere.
Tra coloro che se lo chiedono – e sono tanti – c’è anche un ottimo politologo, purtroppo scomparso di recente: Giovanni Sartori, nel suo libro Homo videns, si dice convinto che siamo attualmente nella fase di una mutazione genetica che dal primato della parola ci sta riportando indietro, a quel primato della vista che caratterizzò la nascita dell’Homo sapiens. Ma questa tesi diventa ancor più inquietante quando Sartori ne analizza le conseguenze in ambito politico.
Non c’è dubbio che gran parte della gente attinga l’informazione non tanto dai giornali, quanto dalla televisione e dai nuovi mezzi multimediali. I giovani, in particolare, consultano Facebook, Youtube e altri siti del genere, dove immagini e filmati la fanno da padrone. E, naturalmente, non è detto che l’informazione che se ne ricava sia rigorosamente documentata – tutt’altro! Sulla disinformazione prodotta dalla Rete e sulle bufale che vi proliferano esiste già una sovrabbondante documentazione. Del resto il potere – là dove non ha alcun limite democratico – può sempre censurare o negare l’informazione anche in Internet: ne è un esempio la Turchia che, nel maggio scorso, ha bloccato l’accesso a tutte le versioni linguistiche di Wikipedia, l’enciclopedia libera della Rete.
Ma ci sono modi più blandi e ben più subdoli di manipolare l’opinione pubblica, sfruttando sondaggi per assecondare le aspettative dell’elettorato, creando personaggi mitici e facendone delle star (il caso di Trump è eloquente), in modo che la politica stessa diventi spettacolo e che alimenti una specie di tifo sportivo per un politico o per il suo antagonista: così poi si vota per il più simpatico, il più seducente, quello che calca meglio la scena. Però, gli stessi media che veicolano l’informazione spettacolarizzata ospitano anche lamentele frequenti sui populismi che avanzano, sulla scarsa partecipazione elettorale o sulla disinformazione che porta l’elettorato a scelte affrettate, che magari vengono poi ribaltate in una consultazione successiva.
Si potrebbe dire che, in fondo, anche la parola, e non solo l’immagine, può essere uno strumento di seduzione delle masse: il successo di Hitler e di Mussolini è da ascrivere anche alla loro indubbia eloquenza retorica. Entrambi sapevano affascinare l’uditorio evocando spettri paurosi e promettendo protezione. Ed è in particolare su questi temi che le parole del politico andrebbero soppesate: le parole, per comunicare davvero, dovrebbero anche evocare dubbi, pensieri, valutazioni. Quando leggiamo un libro o quando ascoltiamo un discorso li comprendiamo solo nella misura in cui ci inducono a pensare; quando invece prevale lo spettacolo, di solito quel che ne nasce non è un pensiero, ma una reazione emotiva.
Certo, la democrazia resta pur sempre il sistema politico migliore; ma perché possa funzionare al meglio occorre sempre ricordare quanto scriveva Stefano Franscini: «La democrazia non è soltanto la maggioranza che vota, è anche la minoranza che pensa». Ora anche questa minoranza pensante sembra avviata a ridursi sempre di più.